Ebreo non più errante
Quando uscì L’Ebreo Errante. Nuove prospettive su un mito europeo, a cura dell’italianista Fabrizio Franceschini e della germanista Serena Grazzini (Edizioni di Storia e Letteratura), nessuno poteva immaginare che sarebbe successo. Il libro, sorto nelle officine dell’ateneo pisano, reca nell’ultima pagina la data di pubblicazione: ottobre 2023. Un mese che nessuno dimenticherà. Fatale per la storia mondiale, tragico per Israele e per la Striscia di Gaza, per gli insediamenti dei palestinesi in Cisgiordania e per tutti noi. Il tema dell’erranza ebraica torna improvvisamente attuale. Dà i brividi ascoltare la minaccia di cacciare gli ebrei di nuovo in mare. I pionieri, i sionisti, avevano bandito, ripudiato la diaspora come destino degli ebrei.
Nei primi congressi sionisti all’inizio del Novecento, come ricostruisce Arturo Marzano in uno dei più attuali contributi – L’ebreo non è più errante. La diaspora nella politica dei governi Netanyahu – della miscellanea pisana, i delegati si espressero per la shelilat ha-galut, per la negazione della diaspora. Erano tutti a favore di una patria ebraica, di uno stato per gli ebrei. E quel sogno si realizzò il 14 maggio del 1948 con la fondazione di Eretz Israel. Ma è tutto sempre così drammaticamente incerto, come confermano i recenti accadimenti dal pogrom del 7 ottobre alla spropositata reazione d’Israele. La televisione ogni giorno ci mostra l’impegno militare dei nuovi ebrei, i sabra – i ‘fichi d’India, dolci, ma spinosi – come vengono chiamati i cittadini ebrei d’Israele, forti, consapevoli, orgogliosi della loro identità nazionale.
Nel nuovo Stato viene meno l’immagine stereotipata del vecchio ebreo del ghetto: l’ebreo, che, perseguitato, oppresso, migrava di terra in terra, incarnando per la civiltà cristiana la maledizione per la Passione di Cristo. È il mito di Ahasverus che risale a quel ciabattino ebreo che avrebbe deriso il Nazareno nella sua salita al Golgota, come illustra, attentamente, la ricerca di Serena Grazzini. Nei secoli la maledizione dell’ebreo errante si metamorfizza gradualmente in una interpretazione tutta positiva, che si radica nel destino dell’erranza ebraica nella diaspora. All’ebraismo diasporico è riservato il sublime mandato di testimoniare l’unicità dell’Eterno. Su questa rifunzionalizzazione del mito, che da grumo figurale antisemita si trasforma in un’apertura alla comprensione del destino ebraico, si può utilmente leggere il contributo di Stefania Ragaù: Dare una patria agli ebrei erranti. Sionismo, migrazione e cittadinanza nell’era dello Stato nazionale. Affiorano i due aspetti del destino ebraico. Quello diasporico coincide, nel Novecento, con la grande tradizione dell’ebraismo orientale, apparentemente distrutta dai pogrom, dall’Olocausto nazista e dalle spietate campagne antisemite staliniste. Ci restano immense reliquie, rievocate e rivissute nelle narrazioni.
L’interprete dell’ebreo errante è Joseph Roth che nel 1927 – con poetica anticipazione – pubblica Juden auf Wanderschaft, Ebrei erranti (Adelphi) che distingue nitidamente le due strade: «Per l’ebreo orientale è del tutto insignificante qualunque legge che garantisca libertà per la sua persona e per la nazione cui egli appartiene. […] Questo ebreo non è un ebreo ‘nazionale’ nel senso occidentale della parola. Egli è un ebreo di Dio. Non lotta per la Palestina. Odia il sionista che con i ridicoli sistemi europei vuole erigere un ebraismo che non sarebbe più tale, in quanto non ha atteso il Messia». E così il discorso torna al punto di partenza: il Messia, che Ahasverus (italianizzato: Assuero) rifiuta di riconoscere. Ma quale Messia? Di lui parla Kafka degli Aforismi di Zürau (Adelphi): «Il Messia verrà soltanto quando non ci sarà più bisogno di lui, arriverà solo un giorno dopo il proprio arrivo, non arriverà all’ultimo giorno, ma soltanto all’ultimissimo».
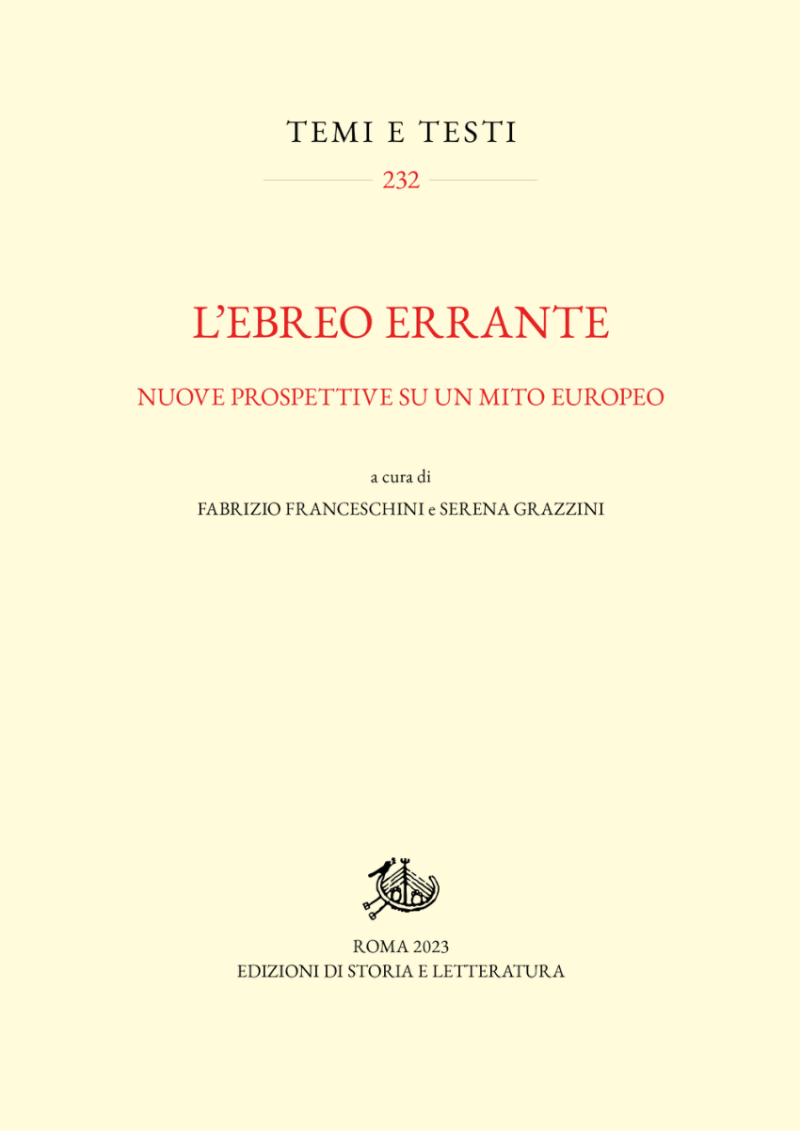
Un autentico kaon zen, imperscrutabile e ineluttabile. Il topos dell’erranza ebraica traversa carsicamente la sua opera, come annota nel saggio, Davanti al confine. Tracce dell’Ebreo errante nell’opera di Franz Kafka, Benedetta Bronzini. Il mito rivive sotterraneamente per affiorare evidente nel racconto Il Cacciatore Gracco. Già la scelta del nome, Gracchus, è suggestiva e tutt’altro che casuale, rimandando proprio a quel corvide che è poi il nome ceco ‘kavka’, taccola. E nel Cacciatore riaffiora un antico mito, che sfiora, in una nuova versione, quello dell’Ebreo Errante. Il Cacciatore, morto in un incidente di caccia nella «Selva Nera, in Germania» (raramente citata in Kafka) giace in una bara sulla barca dei morti che ha perso l’orientamento ed è condannata a navigare senza sosta, per «un numero enorme di anni», in una singolare sospensione tra i vari mondi: «Dopo la morte me ne vo errando per tutti i paesi della terra», così il Cacciatore racconta al sindaco di Riva, che cortesemente lo accoglie.
Dunque un morto che è ancora vivo, un vivo che muore continuamente: «Sono qui, altro non so, altro non posso fare. La mia barca è senza timone, naviga col vento che soffia laggiù nelle infinite regioni della morte». Mai questa situazione eccezionale è stata raffigurata con maggiore potenza narrativa, che è quella che connota Kafka come uno degli ultimi creatori di nuovi miti, oppure di rivisitazioni di antichi miti, da quello di Ulisse e le sirene a quello di Prometeo. Vi è nella costruzione narrativa di questi miti una dimensione moderna, che sprofonda nel nichilismo, nell’insignificanza. Il Cacciatore non ha colpa, cacciava lupi: «Il mio lavoro veniva benedetto». La sua è una esperienza arcaica, che sa di selvatichezze archetipiche, totemiche, con la folgorante intuizione della prossimità, ma inavvicinabile, di una nuova redenzione, quella consegnata al paradosso: «Il fatto che esista solo il mondo dello spirito ci toglie la speranza e ci dà la certezza». Certezza, aggiunge lo scrittore praghese, di un mondo spirituale, che esiste, ma non per noi. Nessuno ha meglio descritto la figura del destino dell’ebreo errante di Kafka: «Esiste un punto di arrivo, ma nessuna via; ciò che chiamiamo via non è che la nostra esitazione».
È l’esitazione di Ahasverus di fronte al Cristo sul Golgota. La costellazione dell’Ebreo Errante – come annota Marcello Massenzio, studioso della storia delle religioni, presente nel volume e autore di un ulteriore significativo confronto con Maestri erranti. Il rinnovamento della cultura ebraica dopo la Shoah (Einaudi) – si configura come estrema possibilità del mito in Occidente, che vi ripropone la sua inquieta storia spirituale. Molteplici variazioni, trasposizioni, trasformazioni – dalla letteratura, da Jan Potocki (su cui scrive Emiliano Ranocchi) fino a Edmond Jàbes (interpretato da Francesca Manzari), alla pittura (Massenzio cita Chagall) alla musica di Luigi Nono (studiata da Alessandro Cecchi) – si snodano per tutta la peregrinazione della cultura moderna. Così incontriamo il Faust goethiano che «erra finché vive», come ha annotato Francesca Tucci nel saggio sulle Rivisitazioni del mito dell’ebreo errante in Die Juden e Nathan der Weise G. E. Lessing. D’altronde il giovane Goethe, quello stürmeriano, si era cimentato con la figura mitica dell’Ebreo Errante, proprio negli anni della genesi del Faust. E quell’inquietudine, quella tensione verso l’incommensurabile che anima Faust, la si ritrova nella figura rilkiana – der Unbehauste Mensch – il senza dimora, senza patria, che non ha più come ricorda Emmanuel Lévinas un chez soi: «personne n’est chez soi».
Su questa condizione estrema ragiona Massenzio, confermando con l’universalizzazione del mito anche la straordinaria attualità, che non smarrisce la sua radice ebraica. E ancora lo studioso annota a proposito del significato universale dell’erranza ebraica che: «la peregrinazione costituisce una tappa necessaria per la formazione dell’uomo libero». L’antitesi sedentarietà/erranza «s’innesta sul contrasto cristianesimo/ebraismo», ed è quella raffigurata nella prima testimonianza scritta (risalente al 1602) del mito di Ahasverus, che gradualmente si discioglie dal suo contesto storico originario. D’altronde l’erranza come destino ebraico germina nella remota antichità, ed è già – e per sempre – affidata al nome di ebreo, ‘ivrit, che – come ricorda Fabrizio Franceschini – si riallaccia a ‘avar oltrepassamento. Vi è inciso nel nome il destino di un nomadismo che si rivela condanna, maledizione.
L’identità ebraica, ancora oggi aggredita, è sempre circondata da una pericolosa incertezza. La minaccia era quella già prevista da Roth, che solo nella diaspora intuiva il compito dell’ebreo e la sua salvezza. A una visione – se possibile – metastorica, quella peregrinazione, quella rothiana ebraica Wanderschaft, custodisce la missione della testimonianza: nessuna delle continue persecuzioni è riuscita ad abbatterla: è una voce perenne che nessuno è riuscito a tacitare, a conferma dell’esistenza dell’eterno mistero. In questa prospettiva risuona paradossale, disperata eppure soave l’impossibile consegna del kafkiano messaggio dell’imperatore: «nessuno può venirne a capo, anche se sia latore del messaggio di un morto. Ma tu siedi alla finestra e immagini che giunga a te, quando scende la sera».
In copertina, Marc Chagall, Ebreo errante.









