Un conversazione / François Jullien, pensare il vivere
Nell’ambito del “Progetto Casa dei Saperi – Nuove Utopie”, la Fondazione Adolfo Pini di Milano ha promosso un ciclo di incontri in cui, grazie ad un team curatoriale under 35, potessero confrontarsi giovani provenienti da differenti ambiti professionali. Sul tema ispiratore, l’esigenza di ripensare nuove forme del vivere insieme, si sono soffermati, fra gli altri, il filosofo Federico Campagna e lo psicoanalista franco-argentino Miguel Benasayag, noto per L’epoca delle passioni tristi. Sabato 21 settembre è toccato al filosofo e sinologo François Jullien tenere un seminario dedicato a L’intimità come eutopia: sapere essere nell’incontro. Gli ultimi scritti di Jullien, Sull’intimità. Lontano dal frastuono dell’amore (Raffaello Cortina 2014), Accanto a lei. Presenza opaca, presenza intima (Mimesi, 2016), pongono a tema la minaccia che grava sulla relazione di coppia, la presenza dell’altro che si traduce in opacità e pienezza abitudinaria. Il ricchissimo e sempre innovativo cantiere filosofico di Jullien torna a interrogare questioni che la filosofia ha in genere eluso: il privilegio attribuito a categorie di pensiero connesse alla logica dell’essere e dell’identità le ha impedito di rivolgersi a quanto rimane ambiguo, alle situazioni incerte che si pongono “tra”, in cui convivono caratteri contraddittori. La filosofia ha pensato la vita, eretta a sostanza, ma non il vivere come processo, l’esistenza come continuo rinnovarsi, quell’ex-sistere che non coincide mai con se stesso, perché solo la de-coincidenza lo mantiene in sviluppo: questione al cuore del suo libro più recente, Il gioco dell’esistenza (Feltrinelli, 2019).
Al termine del seminario, François Jullien con l’abituale cortesia si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande.
Lei aveva promesso fin dai suoi primi libri che la deviazione per la Cina serviva a preparare un ritorno alla cultura dell’Occidente. Il suo utilizzo metodico della saggezza di tradizione confuciana e taoista svolgeva funzione di spaesamento, era un modo per prendere distanza dalla filosofia al fine di svelare gli assunti impliciti della nostra razionalità, le rive in cui scorrono i nostri pensieri. Grazie a questa vera e propria riflessione, al faccia a faccia fra la Cina e l’Occidente (che abbiamo conosciuto nel Trattato dell’efficacia, in Il saggio è senza idee, entrambi tradotti da Einaudi, in Parlare senza parole. Logos e tao, Laterza, in Nutrire la vita, Cortina, e l’elenco potrebbe continuare), si aprono scarti, più che differenze, che permettono di problematizzare il pensiero e sfociare su qualcosa di impensato. In effetti, nei suoi ultimi scritti i riferimenti al pensiero cinese si riducono, come se quest’ultimo restasse soggiacente, pur continuando a sfruttarne le risorse.
In primo luogo, se penso al mio percorso in termini di deviazione (detour) e ritorno (retour), quel che mi sembra importante è che la deviazione è al tempo stesso un ritorno e quest’ultimo non avviene dopo. Se così non fosse, non si tornerebbe mai, perché non la si finirebbe mai una volta entrati nella Cina. Ma credo che il mio lavoro abbia conosciuto un secondo tempo, così come ho parlato di una “seconda vita” [titolo del libro tradotto da Feltrinelli nel 2017], e che il mio progetto sia stato un progetto da filosofo, non da sinologo, da filosofo che può prendere distanza dalla Grecia e che cerca uno scarto per rispondere, o meglio, non proprio rispondere, ma per pensare quel che chiamiamo la verità dei Greci, la loro eredità, da cui non siamo usciti. Sono dunque passato dalla Cina, dalla sua esteriorità rispetto a noi, ma avevo sempre in mente il mio progetto filosofico, progetto generale, come ogni filosofia … Dunque, c’è in effetti un secondo tempo del mio lavoro in cui penso di avere meno bisogno di lavorare sui testi cinesi, cosa che ho già un po’ fatto, e che posso tornare a raccogliere delle sfide filosofiche. Ora, la Cina è sempre presente nel mio lavoro, costituisce un operatore teorico, ma non viene molto tematizzata in quanto tale. D’altra parte, nel mio cantiere propriamente sinologico, la questione del vivere era già all’opera. Dunque si tratta per me, in questo secondo tempo, a partire dal mio cantiere tra il pensiero cinese e quello europeo, di far lavorare tutto questo per riprendere questioni filosofiche, appoggiandomi sul lavoro precedente, in modo da lavorare il campo filosofico europeo osando più di quanto la filosofia faccia abitualmente. L’intimo è proprio questo, perché l’intimo è il concetto che più resiste al concetto. Quel che cerco di fare in questo secondo tempo del mio lavoro, che fa seguito al primo, è di aprire dei nuovi possibili.
La prima fase del suo lavoro ha mostrato come sia possibile porre a confronto culture profondamente diverse, farle dialogare, superando anche la dibattuta questione del relativismo. Al tempo stesso, Lei sostiene l’urgenza di uscire dalla retorica del “dialogo fra le culture”, sempre auspicato e raramente praticato, anche perché ci si attiene a categorie tipiche dell’Occidente, come la nozione di identità, mentre, come dice il titolo di un suo libro, l’identità culturale non esiste (Einaudi, 2018). Ed è un problema che riguarda anche l’unificazione europea, il cui sogno ha perso indubbiamente il suo slancio di fronte al prevalere delle esigenze di mercato e al risorgere dei nazionalismi.
In effetti è così. Ora, dia-logos in greco evidenzia con il dia- lo scarto e la separazione, se no non sarebbe un dialogo ma un monologo. Il dialogo è fecondo perché c’è lo scarto ed anzi tanto più fecondo quanto più vi sono degli scarti in gioco. E un dialogo richiede un percorso, non è immediato, bisogna sviluppare le condizioni di possibilità del dialogo ed è un lavoro progressivo. Per quanto riguarda l’Europa, posto che davvero si voglia fare l’Europa, è esplorando i suoi scarti culturali e rendendo tali scarti dialoganti in modo fecondo che si potrà costruirla. L’Europa può farsi solo a partire da un dialogo che è in primo luogo culturale. È una questione a cui tengo, perché vi è un’antica tradizione per la quale la cultura è ciò che viene dopo, prima c’è l’economia, la società, come voleva il marxismo. Quel che viene prima è la dimensione culturale, la dimensione economica e quella sociale vengono dopo, e questo vale anche per i rapporti con la Cina. Io credo che l’Europa si potrà fare se essa saprà apprezzare le proprie risorse culturali e trarre partito dalle proprie differenze, di lingua e di pensiero, soprattutto di lingua. Si tratta di attivare le risorse delle lingue, di quella italiana come di quella francese. Io non difendo soltanto il francese, difendo le lingue dell’Europa, le considero sullo stesso piano, come le differenze di culture. Credo che vi sia qui qualcosa di decisivo perché si possa davvero fare l’Europa.
Il processo di formazione dell’Europa si è anche bloccato sul dibattito relativo alle sue radici, nozione che Lei ritiene pericolosa perché rischia di imporre statiche identità settarie. Lei ha spiegato che sarebbe meglio parlare di risorse, che si possono sfruttare, di qui il titolo Risorse del cristianesimo (Ponte alle Grazie, 2019), un saggio in cui rilegge il Vangelo di Giovanni dalla prospettiva della vita. E la risorsa fondamentale del cristianesimo è l’ideale dell’incontro con l’altro come colui che permette di uscire da sé.
Qui mi allontano da quella che è stata la via principale di lettura critica del cristianesimo in Europa, quella di Feuerbach, per il quale il cristianesimo è interpretato a partire dal miracolo, dunque in relazione al conflitto fra razionalità e irrazionalità. Giovanni non usa il termine “miracolo”, parla di “segno” e pensa il cristianesimo come rapporto con l’altro, che egli chiama Dio. E quel che produce questo rapporto all’altro è la capacità di tenersi al di fuori di sé, cioè propriamente ex-sistere, esistere. Credo che la grande originalità, la specificità del cristianesimo stia nel pensare, in greco, l’altro in modo totalmente diverso dalla filosofia greca. Per la filosofia greca, l’Altro non è che il contrario dello Stesso, l’altro dialettico, platonico. Ma questo non è per nulla il pensiero di Giovanni. Quel che mi interessa è appunto il modo in cui Giovanni apre dei possibili in greco in senso contrario, ovviamente senza saperlo, rispetto alla filosofia greca, perché nella tradizione ebraica e cristiana l’altro è l’altro che si incontra, è l’altra persona, come nella parabola del Samaritano. E questo è legato alla possibilità o meno dell’incontro, alla sua difficoltà, al suo carattere vertiginoso; ed è qualcosa di totalmente diverso rispetto alla logica greca, dei Sofisti e di Platone. Credo che il cristianesimo, se vuole riflettere su se stesso, debba ripartire da qui, da questo possibile che esso apre, quello di pensare, in greco, l’apertura all’altro. E l’intimo è proprio questo, l’apertura ad opera del cristianesimo all’altro in quanto altro, come spiega Giovanni – “io sono nel Padre e il Padre è in me”, io sono in te: cosa significa essere nell’altro, tenersi in sé nell’altro, ed è questo propriamente e-sistere.
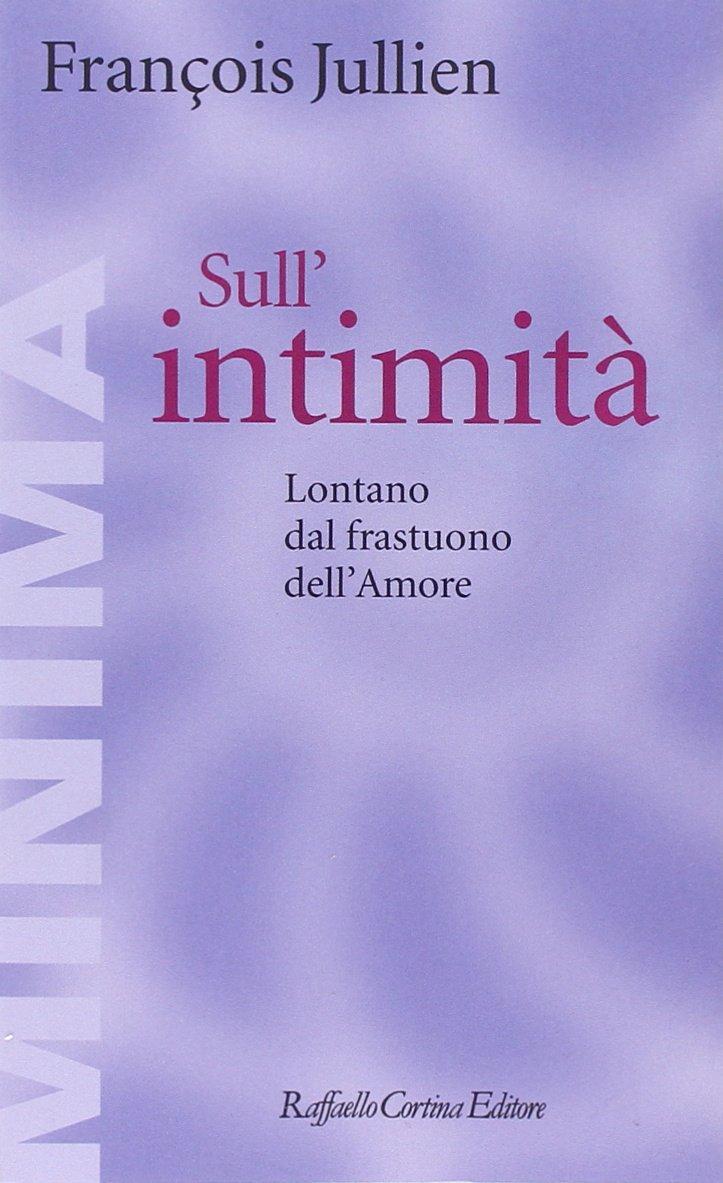
Lei mi chiede di questo libriccino, a cui ho dedicato molta cura e che mi ha procurato anche molte noie, che certamente ho meritato, ma ci sono stati duemila anni di cristianesimo che hanno fatto di tutto per rendere non interessante il testo di Giovanni, a partire dalla traduzione. Nel prologo del Vangelo di Giovanni troviamo scritto egheneto, che significa “avvenne”, e il traduttore si industria a variare questo termine, mentre bisogna conservarlo nella ripetizione che forma un concetto. Si tratta di pensare l’avvento, il rapporto con l’altro, pensare l’esistenza, e dunque si tratta di risorse e di risorse attive. Lo stesso vale per la distinzione fra psyché e zoé; non capisco, pur non essendo cristiano come molte altre persone, che mi si faccia leggere la frase di Giovanni “Chi ama la propria vita la perde” come una formula che non si comprende in francese. Ma se mantengo la distinzione, “chi ama la propria vita” in quanto psyché, il semplice essere in vita, “perde la sua vita”, in quanto pienezza di vita, zoé in greco, allora capisco. E quando al contrario trovo scritto che “chi rinuncia alla propria vita (nel senso di vitale, psyché) si apre alla vita (vivente, zoé)”, allora comprendo e molto bene. Trovo aberrante che si sia conservata una non intelligenza del testo biblico, in questo caso evangelico, mentre in greco la cosa è chiara, netta. È davvero qualcosa di inaccettabile.
In quel piccolo libro sostengo che la questione di credere o meno non è importante e che l’Europa si disfa perché non sa farsi carico della questione cristiana, su cui ci si spacca, in Francia e altrove. Trovo dunque che vi sia una responsabilità storica in merito a questo, una responsabilità che ha dimensione politica perché, se si vuole fare l’Europa, bisogna in primo luogo stabilire, decidere, cosa se ne vuole fare del cristianesimo. Eredità difficile, certo, scomoda, ma la questione da riprendere non è quella di credere o meno; mentre, se non si comprende il messaggio di Giovanni quando dice che vi sono psiché e zoé, cioè la vita del vitale e la vita del vivente, se ne fa qualcosa a cui si deve semplicemente credere. Dunque la fede diventa il prodotto di una incomprensione prodotta dalla lettura del testo. Ritengo che si debba farla finita con tutto questo, uscire dalle critiche antiche al cristianesimo, alla Feuerbach, alla Spinoza, e dire che il cristianesimo è qualcosa d’altro, il pensiero dell’altro, dell’altro nel suo incontro, nel suo incontro impossibile: è quel che dice il racconto evangelico. Occorre ripensare il cristianesimo come risorsa, non come sorgente [source], ma come ressource, cioè una sorgente che torna, che riemerge, che non si spegne. E trovo che questa mancata comprensione abbia conseguenze politiche disastrose, in merito alla nostra capacità di fare l’Europa.
La riflessione sul Vangelo di Giovanni si connette a quell’oggetto nuovo che Lei propone alla filosofia, anche per suggestione del pensiero cinese, che è il vivere, non tanto la vita, elevata a sostanza, ma il vivere come processo, ciò che da noi si è faticato a pensare. Da dove sorge tale difficoltà?
Credo che vi sia una ragione di fondo ed è che, a partire dai Greci, pensiamo il vivere in termini di essere e che l’Essere implica una doppia scelta, la scelta del concetto, e quindi l’eliminazione del singolare, e la scelta della non-contraddizione. Ora, vivere è questione che attiene al singolo, non si può pensare che al singolare, e vivere è nella contraddizione, vivere attiene al contraddittorio, all’ambiguo, a tutto ciò che sconvolge il pensiero della separazione essere non-essere, ecc. Il pensiero dell’Essere ha imposto delle scelte, bisogna andare in cerca di ciò che è identico, stabile – la bebaiotès di Platone, la stabilità dell’Essere. E poiché i Greci hanno pensato in termini di Essere, hanno lasciato cadere il vivere, propriamente lasciato cadere a vantaggio dell’Essere. Essi in effetti non hanno assunto, fatto propria, la vertigine del pensiero della contraddizione e del singolare. Penso allora che vi siano delle condizioni, non dico delle ragioni, per cui la tradizione europea non ha pensato il vivere… Ed oggi, di fronte al ritrarsi del religioso, vivere non è più pensato, se ne fa carico la pubblicistica della “crescita personale”, il mercato della felicità, ecc., che invade le librerie, in Italia come in Francia.
E tale difficoltà permane nella filosofia dell’esistenzialismo, a suo parere, sia Heidegger che Sartre riflettono sull’esistenza a partire dall’Essere?
Certamente, perché si resta nell’ontologia e finché si resta nell’ontologia, finché si assumono le categorie dell’Essere non ci si può accostare al vivere. Ora l’esistenzialismo lo ha affrontato nei termini del patetico, del drammatico, che conosciamo bene, ma direi che tutto quanto sostengo a proposito del concetto di esistenza è del tutto lontano dall’esistenzialismo. Dunque la questione è come uscire dai termini dell’essere per pensare il vivere, cioè il singolare, il contraddittorio, l’ambiguo e tutto quanto ne consegue…
Mi chiedo però se Heidegger non fosse presente nella sua rilettura della tradizione confuciana, in particolare in merito al tema del Fondo da cui il processo della natura si genera di continuo. Mi chiedo se certe nozioni heideggeriane, apertura, svelamento, ecc., non abbiano influito sulla sua pre-comprensione della realtà intesa come processo, propria della cultura cinese, ma che appartiene anche alla natura, physis, dei pre-socratici. Me lo chiedo anche in base a quanto Lei scrive in Philosophie du vivre, (Gallimard, 2011): “Ho seguito il suo [di Heidegger] pensiero per un certo periodo, ma qui [cioè, a proposito del vivere] debbo abbandonarlo”.
Credo di poter dire di no, Heidegger non ha influito sulla mia lettura dei Greci, anche se effettivamente egli ha recuperato la tradizione pre-socratica e l’ha tolta dalla rimozione prodotta da Socrate e da Platone. Dico di no perché se si tratta di uscire dai termini dell’Essere, questo è proprio quel che Heidegger non ha fatto. La scelta in fondo è fra il ripensare il pensiero dell’Essere, ed è quel che lui ha fatto, senza uscirne, e l’uscirne, che è poi la mia prospettiva. Penso che Heidegger sia certamente importante per lo sforzo che ha compiuto per far uscire il pensiero dell’essere dalla banalità, dalla trivialità in cui era caduto, e ritrovarvi un’aspirazione, un’esigenza mai affrontata fino ad allora… Ma è comunque rimasto nel solco dell’Essere, mentre il mio sforzo era di uscirne e c’era la Cina come supporto teorico.
Lei può legittimamente pensare che Heidegger abbia influito sulla mia lettura della physis e dell’apertura, ma io ero sensibile al tema della physis perché negli Stoici essa è pensata staccandosi dal pensiero dell’Essere. Gli Stoici hanno suscitato il mio interesse perché sono stati i primi pensatori greci a staccarsi dal pensiero dell’essere, in merito alla physis come capacità generante. Non a caso già in Processo e creazione (Pratiche, 1991) un capitolo è dedicato allo stoicismo, in quanto presenta analogie con la cultura cinese. Posso dirlo perché ne ho avuto conferma dai sinologi (con cui mi sono formato), dunque qui non c’è nulla di heideggeriano. Uscire dai termini dell’Essere pone una difficoltà radicale, così come pensare il tempo e quel che mi dava problema era come fare intendere a un Francese, a un Europeo, quel che leggo in cinese, che è semplice in cinese, ma che non appena lo riporto in una lingua europea presuppone l’essere, in un modo o nell’altro. Dunque, posso dire serenamente che Heidegger non mi è servito di appoggio ed anzi, nel mio lavoro, mi è stato necessario decostruire Heidegger per poter cominciare a sviluppare quel che era il mio pensiero.
Accanto alla questione del vivere, i suoi ultimi scritti si soffermano sul tema dell’intimo, anch’esso inaudito in filosofia e su cui si è svolto oggi il suo seminario. La filosofia ha pensato l’amore e la passione, ma non quella condizione ambigua, paradossale, dell’interiorità più profonda che si apre al rapporto con l’Altro. Le chiedo se questa sua riflessione sull’intimità sia anche conseguenza delle difficoltà a pensare quel che è comune, ai modi in cui può costituirsi una comunità (problematica centrale del pensiero contemporaneo, in Francia come in Italia) che eviti le forme risorgenti di neo-tribalismo identitario.
Se mi interesso dell’intimo è in primo luogo per sviluppare un pensiero, un concetto, in relazione a ciò che più resiste al concetto. Si tratta in ogni modo di comprendere l’ambiguità, non l’equivoco, perché quest’ultimo bisogna tralasciarlo semplicemente, mentre l’ambiguo occorre affrontarlo, ed è appunto il caso dell’intimità. In effetti, si tratta per me anche di prendere le distanze dal tema della comunità, perché non credo che l’intimo sia portatore di qualcosa di comune al di là del due, del tre. Ci tengo a distinguere in tal senso fra intimo e connivenza, e il primo è qualcosa di specifico, di inaudito che non rientra nel pensiero della comunità. Ed è per questo che ho pensato ciò che è comune non a partire dall’intimo, ma a partire dal diverso, dallo scarto, dal “tra”, ecc., e non di identità culturale [si veda L’universale e il comune, Laterza, 2008]. L’intimo mi appare qualcosa di simile a un concetto di lotta, per dirla in tedesco Kampbegriff. Intendo intimo in opposizione all’inazione, al sentirsi alienato, anonimo, senza faccia a faccia, in seguito al mercato e ai danni della globalizzazione. L’intimo iscrive di nuovo il faccia a faccia, l’altro, ma l’altro in quanto interno a me. L’altra cosa per me rilevante è che l’intimo non dipende da una prescrizione – non si può imporre l’intimo –, ma da una descrizione, etica, ed è per questo che qui si gioca qualcosa di molto importante per me, cioè il rapporto con il letterario. Non è che la letteratura venga ad illustrare la filosofia, ma letteratura e filosofia cooperano sul pensiero dell’intimo.
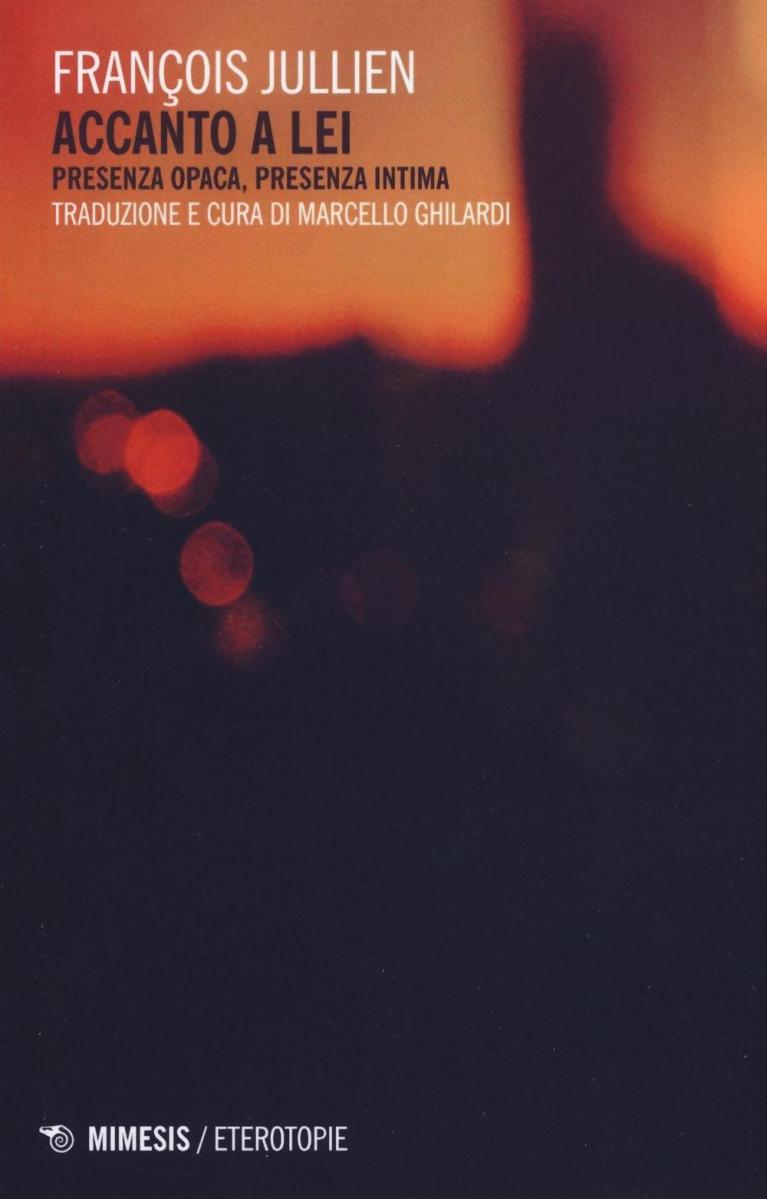
Michel Serres ha scritto che “solo la filosofia può andare tanto in profondità da dimostrare che la letteratura va ancora più in profondità di lei”. Nei suoi libri, professor Jullien, e direi in maniera crescente negli ultimi, si moltiplicano i riferimenti alla narrativa e alla poesia, Proust, Stendhal, Simenon, con cui apre Sull’intimità. È nella letteratura che la filosofia deve cercare il pensiero di quelle situazioni ambigue che per lungo tempo ha rimosso?
Per una volta sono d’accordo con Serres che, purtroppo, è progressivamente scivolato verso una sotto-filosofia, da nonno che stravede per i nipoti; ha venduto molto, ha ceduto a quel che concedono i media. Direi che nell’età moderna, la letteratura, come l’arte e la pittura, pensa e la filosofia non ha l’esclusiva del pensiero; direi anzi che pensa più radicalmente della filosofia, non concepisce, pensa. La letteratura e l’arte colgono, captano in profondità, talora a una profondità abissale, e dunque compito della filosofia è riflettere su ciò che esse colgono, mettere in concetti quel che la letteratura esplora nel modo più profondo possibile. E questo vale in particolare per la poesia, per Rimbaud, o per il romanzo. Questo significa da un lato una cooperazione fra i due ambiti, ad esempio nel mio libro tornano spesso Proust, Stendhal, Rimbaud; cooperare, non illustrare; non si tratta di distrarre il lettore. Dall’altro, a proposito dell’intimo, dell’ambiguo, ecc., la filosofia deve cercare di tradurre in concetti questi temi e di consentire di leggere Stendhal con il beneficio di un chiarimento concettuale. Tanto più che quando Stendhal parla dell’intimo ne parla male, e infatti, nel capitolo di De l’amour che ha per titolo “L’intimità”, parla di tutt’altro in realtà, dell’artificialità della relazione amorosa e resta appunto sotto la luce dell’amore. Mentre il mio lavoro sta appunto nel far uscire l’intimo dalle questioni dell’amore. Dunque si tratta di riconfigurare quel che attiene alla filosofia. La filosofia è nell’avvenire, non tanto per riportare sulla scena i soliti famosi problemi, anche se la filosofia è un fatto singolare, che può anche morire… Mi sembra che proprio da questa cooperazione con la letteratura e l’arte possa risorgere una vocazione della filosofia. Quale vocazione? Proprio quella di pensare il vivere, e infatti il mio prossimo libro ha per titolo De la vraie vie, La vera vita. Ho la sensazione che, essendosi la filosofia sbarazzata del vivere per averlo pensato in termini di essere, essendo in fase di arretramento il religioso, che se ne è fatto carico in ambito europeo – come scrive Giovanni “io sono la via, la verità, la vita” –, il vivere sia lasciato al mercato della felicità e di tutte le sciocchezze che porta con sé. È tempo che la filosofia si faccia nuovamente carico della questione del vivere per chiarirla sulla base dei suoi concetti. E “vera vita” è appunto questo, ed è un tema che rileggo in Platone, in Proust, in Adorno che utilizza in esergo ai suoi Minima Moralia la formula Das Leben nicht lebt, “la vita non vive”. Dunque, c’è secondo me la necessità che la filosofia si impossessi di nuovo di questo tema, prendendo distanza dall’essere e cercando di concettualizzare il “vero vivere”.







