Björn Larsson: i confini dell’umano
Nel Paradigma perduto (1972), il sociologo e filosofo francese Edgar Morin (nato nel 1921) esortava a sfuggire alla visione peninsulare che aveva relegato l’uomo ai margini della natura. L’umanesimo classico, a partire dal mito di Prometeo nel Protagora platonico, tracciava uno “scarto ontologico” fra l’animalità e il percorso intrapreso dall’umanità grazie alla padronanza della tecnica. Unico tra i viventi plasmato ad immagine di Dio o portatore di un’anima razionale, solo all’uomo si aprivano le porte del Regno dello Spirito e del cammino progressivo della Storia. Morin era particolarmente critico nei confronti dell’approccio diffuso nelle scienze umane (in primis nell’antropologia culturale di Lévi-Strauss) dove l’identità umana era definita solo in termini di cultura, materiale o simbolica. Del resto che la natura dell’uomo fosse cultura era convinzione forte dell’antropologia filosofica del Novecento, nelle sue varianti neo-idealiste, storiciste o esistenzialiste: se l’animale vive, l’uomo invece esiste, nel senso che prende distanza – ex-sistere –, si stacca dalla realtà immediata per auto-trascendersi. Di qui la centralità della dimensione temporale nella condizione umana in Essere e tempo (1927) di Martin Heidegger: l’uomo si protende verso il futuro, nel pro-getto con cui mentalmente anticipa l’intervento per trasformare il mondo. L’animale, adattato all’ambiente (Umwelt) in virtù dei requisiti di specie, compie azioni istintive ma rimane povero di mondo (Welt). L’uomo, al contrario, privo da un punto di vista organico di armi naturali e di sensi specializzati, è costretto ad affidarsi alla tecnica per colmare le sue mancanze. Proprio in virtù del suo essere manchevole, ribadiva Arnold Gehlen (L’uomo, 1940), la nostra specie possiede “libertà dalla situazione” ed è capace di “esonero”: rompe l’incantesimo dell’immediatezza per scorgere nel presente l’annuncio di possibili futuri.
Il paradigma perduto di cui Morin andava in cerca era appunto la natura umana. Dopo il darwinismo, la biologia genetica e l’etologia, occorreva “ri-naturalizzare” l’umano, iscriverlo nel percorso evolutivo di cui la nostra specie è l’esito contingente e provvisorio. Un’esigenza che ispirava anche la “filosofia naturale” di Italo Calvino: la storia dell’uomo è un semplice anello, stretto fra “i due estremi della storia dell’organizzazione della materia”, da una parte la continuità con il mondo animale, dall’altra l’estensione alle macchine che elaborano informazione. Si poteva allora immaginare un futuro in cui l’uomo avesse esaurito il suo compito: “L’uomo è stato necessario: adesso è inutile. Perché il mondo riceva informazioni dal mondo e ne goda bastano oramai i calcolatori e le farfalle” (“Storia della foresta che si vendica” nella Taverna dei destini incrociati, 1973). Un passo in cui si avverte la consonanza con il pensiero strutturale dominante negli anni Sessanta, forse eco del Michel Foucault di Le parole e le cose (1962): “L’uomo non è che un’invenzione recente […], una semplice piega del nostro sapere, e che sparirà non appena questo avrà trovato una nuova forma”. È a partire dal radicamento cosmico e biologico dell’umano che muoveva la riflessione di Morin – su cui tornerà il quinto volume del suo Metodo, dedicato all’identità umana (Cortina, 2002); non per ridurre l’Homo sapiens demens a una scimmia nuda (secondo la formula dell’etologo Desmond Morris), ma per comprenderne, integrando le acquisizioni delle diverse scienze, l’identità complessa, biologica e sociale.

Ma l’approccio naturalistico, accolto anche dalle scienze umane, finirebbe per annullare l’eccezionalismo che ci separa dai nostri parenti, i primati con cui condividiamo il 98% del patrimonio genetico. È quanto sostiene il filosofo-romanziere Björn Larsson, in Essere o non essere umani (Cortina), per il quale dai non-umani ci separa uno scarto qualitativo, non una mera differenza di grado: alla nostra specie va riconosciuta la facoltà, almeno potenziale, di comportarsi da agente razionale e auto-cosciente, di disporre di un margine di libertà. Una facoltà che non costituisce una prerogativa innata, geneticamente prestabilita, a differenza di quanto ritiene il riduzionismo della socio-biologia di Richard Dawkins, che ci rende schiavi dell’egoismo dei nostri geni, o di Francis Crick, per cui anche l’essere umano si spiega riconducendolo alle sue basi fisiche o genetiche. Anche i biologi evoluzionisti “tendono, quasi senza eccezioni”, scrive Larsson, a spiegare le manifestazioni superiori della nostra specie con un presunto vantaggio adattativo – paladini anch’essi di una natura umana preconfezionata. Larsson non disconosce il ruolo decisivo dei geni e delle modifiche corporee (l’andatura bipede, il pollice opponibile, lo sviluppo della neocorteccia, ecc.), ma avanza l’ipotesi teorica che la svolta che fa della nostra la specie simbolica (come diceva il neuro-antropologo Terrence Deacon, Fioriti editore, 2001), pur preparata dalla selezione genetica, non derivi da capacità “naturali”, sia invece un’acquisizione culturale. Tra il livello della materia e il piano della mente o della coscienza intercorre una discontinuità ontologica “emergente”, cioè non riducibile alle leggi che regolano le particelle della fisica, classica o quantistica. Nella produzione intenzionale di pietre scheggiate, promossa da Homo habilis, Larsson scorge l’innesco della capacità di distinguere fra la realtà percepita dai sensi, qui e ora, e quella rappresentata, che si ri-presenta alla mente. Questa primordiale acquisizione consentirà a Homo sapiens, fra i duecentomila e i centomila anni orsono, di sviluppare il linguaggio a doppia articolazione, in cui elementi discreti, di per sé privi di significato, vengono combinati per formare parole e frasi che veicolano un significato. Se è vero che anche altre specie comunicano (dalle api ai delfini), è il linguaggio la sola capacità che distingue davvero Homo sapiens, diventato Homo loquens, dagli altri organismi, suggeriscono i lavori dello psicologo Michael Tomasello, co-direttore del Max Planck Institut di Lipsia (Le origini culturali della cognizione umana, Il Mulino, 2005). Ricordava Felice Cimatti (La scimmia che si parla, Bollati Boringhieri, 2000) che l’animale umano utilizza il linguaggio non soltanto per comunicare, ma soprattutto per pensare se stesso, grazie a una mente linguistica.
La svolta che segna la comparsa di Homo sapiens, connessa alla scelta arbitraria di un segno per comunicare, – secondo la proposta di Essere o non essere umani –, consente di parlare anche di oggetti assenti, sottratti ai sensi, di superare il ricorso alla presentazione ostensiva, al gesto dell’indicare. Una cosa qualunque può stare per un’altra: grazie a questa invenzione, il segno può indicare quel che non esiste, anche se resta viva la “tentazione referenziale”, cioè la tendenza ad attribuire a ogni segno una presunzione d’esistenza, reminiscenza psicologica dei primi passi della specie. Per l’uomo si apre il ventaglio delle formulazioni ipotetiche, degli scenari congetturali o futuribili, delle immagini fantastiche, del sapere scientifico come della finzione letteraria e della menzogna. Qui avrebbe origine anche il pensiero astratto che opera su costrutti mentali, come accade nell’invenzione del pensare matematico; e soprattutto la capacità di auto-determinarsi, di dare espressione al libero arbitrio. Larsson procede in controtendenza rispetto all’eredità dello strutturalismo – linguistico o antropologico – per il quale il soggetto è parlato dal linguaggio, vincolato alle regole del gioco che esso impone (il tema è svolto nell’ultimo lavoro di Cimatti, La vita dei segni. Il linguaggio e i corpi nella filosofia francese del ’900, Il melangolo).
L’ipotesi di Larsson – la rappresentazione simbolica arbitraria svincola la nostra specie dall’immediatezza della realtà percepita – ritrova per altre vie quanto ha sostenuto l’umanesimo esistenzialista, quella “condanna alla libertà” in cui Sartre scorgeva la possibilità di dare senso al nostro vivere. La libertà non è un’illusione o un epifenomeno, è “una facoltà emergente dell’essere umano”, scrive Larsson. Certo, oggi non è più sostenibile la convinzione che l’uomo sia l’essere manchevole “per natura”, privo da un punto di vista organico di armi naturali e di sensi specializzati, geneticamente inerme. Nemmeno possiamo contrapporre alla Natura, come Regno della Necessità e della ripetizione, l’universo inventivo della cultura – lo ricordava Roberto Marchesini in Post-human (Bollati Boringhieri, 2001). Il filosofo-scrittore svedese non esclude che l’umano possa essere “oggetto” di scienza: ma non certo delle tante scienze contemporanee – naturali ed umane, incluse le scienze cognitive – in cui predominano tendenze riduzioniste e deterministe, e per le quali la presunta libertà (come l’anima di un tempo) resta un termine vuoto. Il “punto di vista canonico della scienza” è lo “sguardo naturalistico” di un osservatore esterno, alla terza persona, che contempla anche i “fenomeni” umani come se fossero esperimenti di laboratorio. Larsson evoca in merito il cosiddetto apologo di Quine: la situazione di uno studioso che cerca di comprendere il significato di suoni sconosciuti emessi da indigeni che cacciano un coniglio. L’unico modo per comprendere le loro intenzioni, per “entrare” nel loro cervello, è la metodologia partecipativa: l’osservatore deve interagire con loro, assimilarne cultura e lingua – “il luogo in cui si radica l’intersoggettività”, diceva Quine –, prendere parte alla caccia. L’antropologo deve rinunciare al ruolo dello scienziato che rivendica un’analisi impersonale e oggettiva, alla sua stessa identità di accademico occidentale che compie una visita temporanea su di un gruppo di “oggetti”. Sempre che la popolazione indigena voglia partecipare al gioco: un altro apologo, che potremmo dire di Georges Perec (La vita istruzioni per l’uso), narra di un etnologo costretto a inseguire una popolazione che rifiuta d’incontrarlo e che si nasconde in luoghi sempre più impervi e desolati.
Occorrerebbe dunque dotarsi, propone Larsson, di un’epistemologia del noi che non reifichi l’uomo, capace di aprirsi a metodi interazionali, sulla scia degli approcci di “osservazione partecipata” che erano di Franz Boas e Margaret Mead. Le scienze propriamente umane sono scienze della significazione, si rivolgono a quelle facoltà, non garantite dalla genetica o dall’evoluzione, che segnano lo scarto rispetto al mondo animale. La possibilità di condividere significati con altri esseri umani, significati resi stabili dall’uso comune di una lingua condivisa, impone di trasformare l’inter-soggettività esistenziale in inter-soggettività di ordine scientifico. Larsson si fa difensore di un “buon senso comune” (è il titolo di un suo libro) per il quale il modo d’esistenza del significato non è né oggettivo, fondato sulla realtà, né soggettivo, racchiuso nell’interiorità. La linguistica ha spesso dimenticato la lezione del Wittgenstein delle Ricerche filosofiche per il quale non esiste linguaggio privato: parlare un linguaggio equivale a condividere una “forma di vita”. La tradizione strutturalista e chomskyana, nota Larsson, ha privilegiato la sintassi e la grammatica, lasciando in secondo piano la prassi della semantica empirica. Non c’è bisogno di postulare strutture cognitive innate alla base della sintassi, visto che la significazione è un processo storico-sociale, una rappresentazione cognitiva ratificata da accordi intersoggettivi, una convenzione in senso letterale: ci intendiamo anche se non sempre i significati sono stabili, anche se non possediamo regole univoche o non ne comprendiamo il funzionamento. Accedere alla dimensione inter-soggettiva è anche la condizione per l’emergere dell’auto-coscienza, di quell’attenzione potenziata rivolta a se stessi che dipende da come ci vedono gli altri con cui condividiamo il linguaggio simbolico.
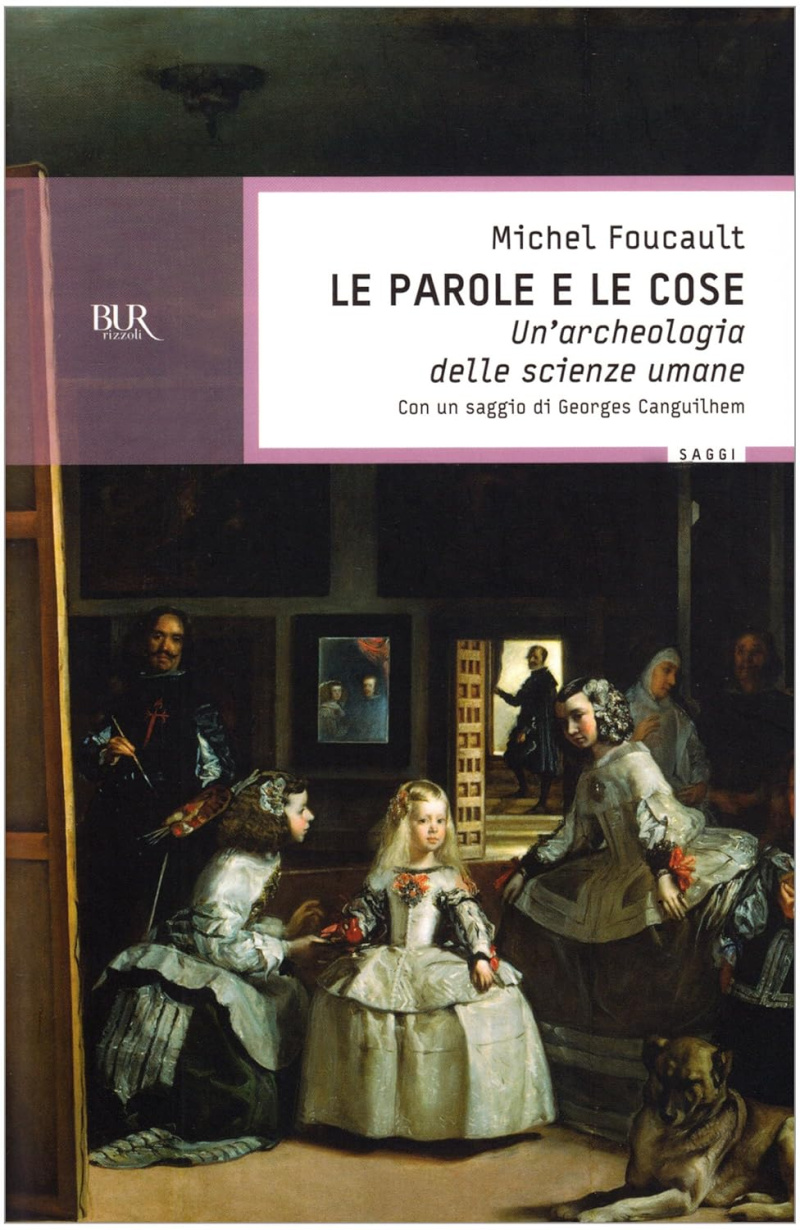
Se la dimensione inter-soggettiva è condizione imprescindibile dell’esperienza umana, ogni scienza “umana” che si confini nello studio del cervello di un individuo isolato si condanna da sé all’incapacità di spiegare in cosa consiste l’umanità dell’uomo. Le situazioni artificiali create in laboratorio negli esperimenti della psicologia o delle scienze cognitive sono finzioni che non aiutano a comprendere le infinite sfumature del nostro agire e comunicare quotidiano, in cui entrano in gioco non solo le forme verbali, ma gesti, contatti, scambi sensoriali ed emozionali. Larsson ha buone ragioni per contestare la validità di famosi esperimenti che avrebbero portato alla luce una presunta “natura umana”, incline alla “banalità del male” per obbedienza all’autorità o per conformismo di gruppo. Sia nel caso del test organizzato da Stanley Milgram nei primi anni Settanta – giovani a cui era concesso punire con una scarica elettrica studenti (in realtà attori) che davano risposte errate –, che dell’esperimento condotto da Philip Zimbardo all’università di Stanford – due gruppi di studenti, suddivisi in detenuti e guardie, lasciati a se stessi finiscono per ingenerare dinamiche conflittuali –, i volontari costituivano un campione decisamente parziale, studenti universitari del ricco Occidente. Senza contare che erano fortemente incoraggiati dai responsabili dell’esperimento (magari in veste di medici) ad adottare comportamenti crudeli.
L’obiettivo di Larsson è promuovere una scienza umanistica dell’uomo che sappia rispondere a una duplice domanda: “che cosa è un uomo?” e “che cosa significa essere umano?”. Il nucleo più intimo della nostra umanità consiste nella capacità di auto-determinarci, senza restare in balia di forze sottratte al nostro controllo, istinti o mutazioni genetiche casuali. Ci è data la scelta tra essere o non essere umani. Larsson evoca in merito la decisione che ha segnato la sua biografia: il rifiuto di prestare servizio militare in Svezia, nel 1973, non da obiettore di coscienza o pacifista, ma di fronte a quanto ha sbraitato un sergente: “Siete qui per imparare a obbedire senza pensare” (la richiesta dei fascismi di sempre, in versione teologica, militare o politica). Larsson per tre volte viene condannato a qualche mese di carcere “per aver disobbedito a un ordine”. Quel che non poteva accettare era l’obbligo di andare in guerra sulla base di decisioni altrui; di qui la proposta di riconoscere un diritto umano fondamentale, quello di decidere, per proprio conto e senza incorrere in sanzioni, se rischiare o no la pelle, e per quale causa farlo (un diritto che nessuno Stato riconosce). Le facoltà “umane” dell’uomo, in primis la libertà, rappresentano conquiste da perseguire e coltivare attivamente nell’interazione con i nostri pari. Larsson ricorda di essere stato invitato nel carcere di Como per discutere con i detenuti del suo inno alla libertà, il romanzo La vera storia del pirata Long John Silver (Iperborea 1998). Uno di loro confessava che, quando era stato brevemente rilasciato per un colloquio di lavoro e aveva potuto godere di una passeggiata in città, il mondo esterno gli era parso ostile e soltanto al rientro in carcere si era sentito libero. Non so se qualcuno fra i detenuti avesse letto anche l’antologia curata da Larsson, Raccontare il mare (Iperborea, 2015), dove l’oceano è indicato come il simbolo di una visione dell’esistenza che preferisce l’insubordinazione all’obbedienza, la ribellione al servilismo, l’eccezione alla triste normalità. La letteratura marinara – di Melville, di Conrad, di Biamonti … – offre un’insicurezza salutare, c’interroga su come evitare di diventare disumani: non si pone in difesa della pena di morte, della tirannia e delle forze dell’ordine, non riconosce l’autorità del capitano, sta sempre dalla parte dell’equipaggio.
“Se questo fosse un uomo” recita il titolo dell’ultimo capitolo di Essere o non essere umani, conclusione ideale del confronto continuato che Larsson persegue con la saggezza del “maestro” Primo Levi. La Shoà ha cambiato la percezione collettiva dell’umano: dis-umanizzare le vittime è il meccanismo “elementare” all’origine delle pratiche di sterminio e dei genocidi. I reduci, come Robert Antelme in La specie umana, rivendicano l’appartenenza alla comunità che è stata loro negata; la sorte delle vittime di quell’esperimento atroce che fu Auschwitz, nella testimonianza di Levi, è la regressione all’animalità, alla condizione bestiale della lotta per la sopravvivenza, nell’impossibilità di prendere distanza dall’immediato, da un presente di fame, freddo e fatica. La condizione umana è precaria, non è scontata, è una potenzialità che può essere smarrita o che ci può essere tolta; la nostra è la specie fragile, non si nasce umani, ricorda Larsson, lo si diventa, proprio perché l’umanità dell’uomo dipende da facoltà acquisite. Alla bestializzazione delle vittime corrisponde, ricorda Levi, quella che si è risvegliata nei carnefici: il male sta nell’obbedienza, nella rinuncia alla libertà di pensiero, l’intolleranza razziale ha radici animali, rappresenta una regressione a uno stadio precedente dell’evoluzione, “addirittura è incorporata in certi istinti primordiali” che ci accomunano ad altri mammiferi o animali gregari.
Quando ha iniziato a scrivere il libro, Larsson si diceva convinto “di riuscire a dimostrare con prove scientifiche e razionali che all’essere umano è dato un certo margine di scelta, se non altro in via potenziale”. Sperava soprattutto di offrire “ragioni convincenti” per indurre a utilizzare la libertà per il bene di tutti, cioè di transitare dalla scienza all’etica, di gettare un ponte fra descrizione e prescrizione, evitando “la fallacia naturalistica”, cioè l’indebito salto dall’essere al dovere essere. È quanto, su di un altro registro, aveva cercato di fare il Principio responsabilità di Hans Jonas: il dover essere dell’umanità è deducibile dall’idea stessa di uomo, per cui il primo imperativo categorico è “che ci sia un’umanità”. Il senso che solo noi possiamo dare alla nostra vita starebbe per Larsson nel difendere e sviluppare quelle facoltà precarie che fanno di noi degli umani umani. Immorale sarà allora ogni comportamento che ostacoli il pieno accesso all’umanità, dunque ogni forma di limitazione delle possibilità di scelta e di conoscenza. Vi sarebbero, argomenta Larsson, gradazioni nell’aggettivo umano: chi rinuncia (o è impossibilitato) a promuovere il potenziale di umanità insito in noi, chi fugge dalla libertà e smarrisce il senso del possibile, chi perde la capacità d’immaginare e interagire con gli altri, sarebbe “meno umano”. E questo riguarda anche le diverse fasi della nostra esistenza: nell’infanzia come nella vecchiaia o nella malattia il nostro grado di “umanità” sarebbe meno sviluppato. Larsson si premura di rilevare che questo non giustifica in alcun modo un trattamento inumano nei confronti dei “meno umani”, ma qui preferisco seguire Amerigo Ormea – il protagonista della Giornata di uno scrutatore (1963) di Italo Calvino. Svolgendo il suo incarico nel seggio del Cottolengo di Torino, mentre osserva in una sala un vecchio contadino venuto a trovare il figlio demente a cui dà da mangiare delle mandorle, così riflette: “l’umano arriva fin dove arriva l’amore: non ha confini se non quelli che gli diamo”.









