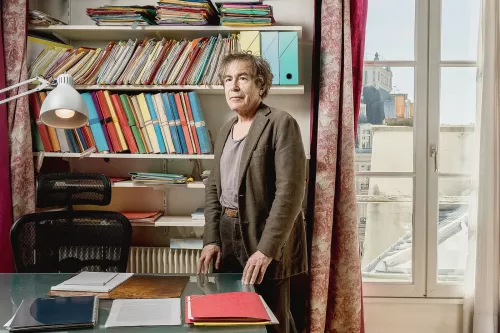Jullien. La vita in Cristo
“In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio e il Verbo era presso Dio”. L’incipit memorabile del Vangelo di Giovanni rinnova gli esordi della filosofia greca: l’arché dei pre-socratici, il principio originario, e il Logos che era già in Eraclito, il Verbum latino, assurto nel pensiero stoico a Ragione immanente al mondo. Stilato in greco sul finire del primo secolo a Efeso, il Vangelo non parla la lingua di Gesù, l’aramaico, appartiene a un’altra famiglia, non semitica ma indo-europea. Proprio quest’incrocio di lingue e di spunti diffusi nel crogiolo ellenistico, fra la Gnosi, l’ebraismo di Filone e il lascito platonico, ha contribuito alla fecondità del Vangelo giovanneo, sostiene François Jullien in Risorse del cristianesimo, ma senza passare per la fede (Ponte alle Grazie, 2019). Ineludibile punto di riferimento nella riflessione dei Padri della Chiesa (da Origene ad Agostino), al Vangelo di Giovanni si è richiamata la mistica di Meister Eckhart le cui tracce ancora si avvertono nel giovane Hegel dello Spirito del cristianesimo e il suo destino (1799). Qui la religione, liberata delle sue componenti esteriori (la dimensione che l’illuminismo diceva “positiva”), si declina come percorso di liberazione dell’uomo, nella speranza di una rivoluzione nello Spirito, ben più profonda di quella affermata dalla rivoluzione francese. Il Gesù hegeliano si contrappone alla scissione ebraica di idea e realtà, di umano e divino, e al sogno infranto dell’armonia immediata con cui la Grecità rivestiva il senso del tragico.
Nel Cristo giovanneo del giovane Hegel gli opposti si riconciliano in virtù della dinamica dell’amore: anche individui in conflitto possono riconoscere nell’altro qualcosa che appartiene a entrambi, il loro essere in vita. Cristo è simbolo della vita che sana: ogni ente determinato rientra con la sua finitudine nel succedersi della vita una e infinita e l’uomo “illuminato dalla vera luce” (photi alethino) riconosce nella propria vita l’impronta divina. Il Logos diventa così l’espressione del rapporto metafisico fra l’umanità e l’assoluto. “Il figlio di Dio è anche figlio dell’uomo: il divino appare in una figura particolare, come uomo; la connessione del finito con l’infinito è certamente un sacro mistero, poiché questa connessione è la vita stessa”. L’amore, in quanto energia che supera il formalismo della legge e l’ostilità del destino, diviene strumento per il formarsi di una comunità di fede; ma il giovane Hegel denuncia il fallimento storico di questo progetto, l’amore non riesce a tradursi in istituzione in cui si riconoscano le vite dei singoli, si trasforma in settarismo o si disperde attorno al “sepolcro vuoto” di Cristo.
“Dio è morto, questo è il pensiero più terribile, che tutto ciò che è eterno, che è vero, non è. La negazione è Dio stesso, a ciò si ricollega il più alto dolore, il sentimento della completa perdizione, la rinuncia a tutto ciò che vi è di più elevato”, scrive l’Hegel berlinese delle Lezioni di filosofia della religione, negli anni Venti dell’Ottocento, ben prima dell’annuncio dell’uomo folle nietzschiano. Ma è solo grazie al transito attraverso il dolore “troppo umano” della Passione che si sconfigge la morte nella resurrezione e si attua la riconciliazione del “Dio vivente” con se stesso, e con il cammino dell’uomo. Nella storia la provvidenza cristiana si è fatta immanente, il cammino della salvezza coincide con il percorso dello Spirito nel mondo. Quel che era, al tempo degli scritti teologici-giovanili, l’unità della vita nel suo frantumarsi e ricomporsi rientra ormai nell’andamento dialettico di cui la filosofia, non più la religione, comprende la Ragione. Il Logos giovanneo, iscritto nell’interpretazione ontologica del Sistema idealistico, è il Dio in cui si esprime l’unità metafisica che precede ogni determinazione e ogni distinzione finita, e il Verbo incarnato si ritrova nel divenire con cui lo Spirito giunge all’Assoluto.
Nell’interpretazione di Jullien, la preoccupazione di Giovanni non è tanto affermare la novità del messaggio cristiano (come Paolo e gli altri evangelisti che diciamo sinottici), quanto iscrivere l’Evento temporale dentro l’Essere eterno. Il lascito platonico della Grecità concepiva il divenire come impoverimento dell’Essere, pallida “realtà” inconsistente, destinata all’incertezza del metamorfico. In Giovanni, il divenire non è più posto sotto l’ombra dell’essere: “tutto è divenuto (il greco egeneto, aoristo) attraverso di lui”, ma qui divenire ha in realtà il senso di avvenire, non corrisponde all’evanescente fluire del “mobilismo” condannato dalla metafisica, ma all’ad-venire che l’evento fa sorgere. Dunque andrebbe detto, rileva Jullien: “avvenne un uomo mandato da Dio”, “il logos avvenne carne” e non “il verbo si è fatto carne” come vuole la traduzione canonica. Così, Gesù non chiede all’infermo “Vuoi guarire?” ma “Vuoi avvenire sano?”, una formula che sfugge alla logica della causazione taumaturgica e del miracolo, per indicare l’evento di una rigenerazione interiore. Il Cristo giovanneo apre un ad-venire all’interno di un Essere che non è quello dell’onto-teologia, statica persistenza identica a sé, ma quello che accoglie l’evento e si apre al novum. Nell’ottica della metafisica greca, all’evento non può essere accordato nessuno statuto; il divenire è corruzione, la spiegazione – Aristotele docet – è causale, esistono cioè solo effetti che procedono da cause, e la concezione ciclica del tempo fa del futuro solo la ripetizione di quel che già è stato. Ma neppure il pensiero processuale della Cina antica è nelle condizioni di pensare l’evento: ogni accadere è solo affioramento manifesto di una “trasformazione silenziosa”, rendersi visibile del nascosto; la comparsa del germoglio dal terreno è da sempre integrata e “compresa” (nel duplice senso, capita e inclusa) nella regolazione del mondo.
L’evento che Giovanni annuncia può cambiare tutto; non rientra nella “comune misura” del nostro intendere, appartiene all’incommensurabile (titolo di uno degli ultimi lavori di Jullien, L’observatoire, 2022), all’inaudito (Feltrinelli, 2021) che spunta improvviso nella nostra vita. La natura dell’evento, in quanto avvento del Cristo, di cui parla fin dal prologo il Vangelo di Giovanni, è quella colta dal giovane Hegel: “L’avvenuto (gegonen) in lui era la vita (zoé)”, e lo ribadisce il finale indicando la destinazione a cui gli uomini possono accedere in virtù della fede: “perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (20,30). Giovanni non segue la distinzione tipica della tradizione greca, dove bios indicava la vita qualificata, dell’etica e della polis, mentre la vita dei meri viventi è zoé. Il Vangelo non considera il primo caso; la vita in quanto semplice essere in vita, che conserva in sé il soffio vitale fino al momento della morte, è detta psyché, “anima”, che corrisponde all’ebraico nèfech e designa, nel greco dei Settanta e del Nuovo Testamento, l’uomo individuale in quanto vive. Giovanni utilizza invece il termine zoé per indicare l’avere in sé la vita nella sua pienezza, la vita “viva”. Cristo ha il potere di “deporre” la propria vita (psyché) per riprenderla di nuovo (10,17-18); in questo corrisponde al buon pastore che si sacrifica e “depone la sua vita per le pecore”, per far sì che esse “abbiano la vita (zoé) in abbondanza” (10,10-11). La distinzione, occultata nella traduzione canonica che usa per entrambi i casi il termine “vita”, non compare negli altri tre evangelisti, che si fermano al vitale, a psyché, come fa anche Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando oppone al corpo come vitalità, psichico, il corpo come spiritualità, dotato di pneuma (distinzione in cui si scorgono tracce della dottrina stoica). Così Giovanni può dire che “chi ama la propria vita (psyché) la perde”, mentre chi odia la propria vita in questo mondo e sa staccarsene “la conserverà per farne una vita (zoé) che non muore (aionios)” (12, 25). In greco originariamente, aionios – prima di configurarsi come il “sempre essente” della metafisica (aei on) – si lega a ogni fluido organico (lacrime, liquido spinale), a ogni linfa vitale, mentre la morte è connessa al disseccamento. Nella rilettura non-cristiana di Jullien, Giovanni evita il dualismo anima/corpo, non vi è dunque necessità di ricorrere alla separazione ontologica fra il transeunte e l’eterno e di evocare il richiamo al trascendente.

La formula giovannea, che si ritrova in uno dei testi base del taoismo, lo Zhuangzi, suggerisce che, per vivere pienamente, si deve impedire che l’interesse per la propria vita vegetativa diventi assillo estenuante. “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv, 12,24). Sul versante evangelico, secondo il grande sdoppiamento fra il concreto e il figurato, proprio del registro occidentale del simbolico (sul tema Jullien si è soffermato in Strategie del senso in Cina e in Grecia, Meltemi, 2004), il chicco di grano designa il Cristo, che è pane di vita e nutrimento spirituale, e la cui Passione garantirà la salvezza degli uomini. La distinzione tra l’essere in vita e la vita viva già si annuncia nel dialogo tra Cristo e la Samaritana. L’acqua del pozzo che Gesù le chiede è semplice psyché, rientra nel metabolismo del vitale e disseta l’organismo, ma l’acqua che Cristo offre in cambio è acqua viva, “sorgente d’acqua che zampilla per la vita (zoé) che non muore”. Giovanni non concettualizza, come ci hanno insegnato a fare i Greci, non passa dal concreto all’idea astratta sotto la quale si unifica il diverso; se mai spiritualizza, spiega Jullien, dove lo spirito è il soffio (pneuma) che infonde la vita nella sua pienezza. Non si tratta di compiere la conversione, metanoia, qui ad essere in gioco non è l’intelletto filosofico, il nous, ma la dimensione spirituale; lo spirito promuove non tanto una vita intensa quanto una vita espansa, una vita che si condivide e si dedica all’Altro, sul modello del Cristo in croce. Giovanni indica così la capacità esistenziale di “tenersi fuori” da sé, di ex-sistere, strapparsi da se stessi e dal mondo per traboccare nell’incontro con l’Altro. La novitas cristiana – assente nell’interrogazione dei Greci sulla vita buona – invita a sviluppare in sé la vita in abbondanza, un invito agli antipodi rispetto alle trivialità dell’odierno mercato della “crescita personale”, dove consigli di salute si mischiano a forme ingenue di spiritualità, adorne di richiami all’Oriente.
Aprirsi non alla “vera vita” (come in Platone), ma alla vita in quanto è da sé la propria fonte (zoé), implica la vocazione alla verità: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), come se i primi due termini fossero gradini che consentono di accedere all’ultimo. Il greco del Vangelo utilizza aletheia, svelamento, termine che la filosofia ha ripreso – Parmenide docet – dal linguaggio sacrale. Ma qui siamo lontani dal senso filosofico, come dalla nozione latina di veritas in quanto corrispondenza alla realtà, conformità all’Essere; la verità di Giovanni non si esaurisce nel contenuto di un discorso, non rimanda all’universalità del logos come in Eraclito, “Ascoltando non me, ma il discorso-ragione, logos …”. Si approssima al senso ebraico di emet, “quel che tieni dentro di te”, con la stessa radice di imma, la madre che accoglie in sé il nascituro. La verità è del singolo, per dirla con Kierkegaard, non tanto soggettiva quanto soggettivata; non riguarda il possesso della conoscenza, è il soggetto che nel suo agire la fa avvenire: “chi fa la verità viene verso la luce” (Gv 3,21). La verità “libera” (8,32), non tanto dalla schiavitù del peccato, ma nel senso che si offre come dimora in cui vivere; non impone “regole di vita”, prescrizioni che siano forzatamente da seguire, ma promuove la ricchezza del vivere interiore. “Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”, afferma Gesù condotto per la prima volta da Pilato, il quale risponde con la domanda: “Che cos’è la verità?” (Gv 18, 38).
“Ma voi, chi dite che io sia?”, interroga Gesù nel Vangelo di Marco. Cristo sfugge a ogni determinazione che cerca di definirne l’identità, a ogni riferimento in cui si cerca di rinchiuderlo: a chi lo designa figlio di Dio replica dicendosi figlio dell’uomo. Assume pienamente il turbamento e il pathos che è proprio dell’umano, di cui condivide la sorte mortale, non conosce l’atarassia del saggio (stoico o del Mencio), tanto decantata ma inumana; al contempo, non smette di ricordare che procede dall’Assoluto e dall’Eterno. Richiamandosi alla distinzione – tematizzata da Paul Ricoeur in Sé come un altro (Jaca Book, 2016) nel confronto critico con l’Emmanuel Lévinas di Totalità e infinito (Jaca Book, 1977) – fra lo stesso (l’idem dell’identità) e il sé (ipse), Jullien mostra come il Cristo giovanneo reclami di continuo la propria ipseità sepolta sotto le identità con cui gli altri la ricoprono. L’identità vorrebbe de-finire in modo stabile un’essenza, ma non dice niente dell’unicità del soggetto in quanto ipse. È questa la risorsa esistenziale che Jullien rintraccia nel cristianesimo: la figura del Cristo dà volto alla ipseità assoluta del soggetto, quella che Gesù esprime dicendo di sé “io sono”, senza predicato (Gv 8,24; 13,19). L’ipseità di ciascun uomo è chiamata nel Cristo a dis-isolarsi ed entrare in comunione con l’Altro: di qui si apre quella promozione dell’umano, non nella versione dell’umanesimo di Protagora, ma erigendo il sé-soggetto nella sua ipseità ad assoluto.
È l’ipseità ad essere coinvolta nel credere: non nel “credere a” della credulità e dell’ideologia, ma nel “credere in” che implica piena fiducia in colui in cui s’investe la nostra speranza. Mentre “credere a” resta esteriore al soggetto e va in cerca di prove e conferme – e chi le cerca le trova sempre –, “credere in” coinvolge il soggetto che s’impegna per testimoniare (martyrein) la verità. Dal senso strettamente giuridico (ebraico e greco), testimoniare assume allora, rileva Jullien, un senso esistenziale: il sé del soggetto risulta coinvolto nella sua ipseità, come sanno i discepoli di Gesù che solo da quello che faranno verranno riconosciuti. È questo a rendere credibile la testimonianza dell’evento inaudito; lo sanno bene i superstiti dello sterminio, da Primo Levi a Elie Wiesel, la cui parola non è neutra registrazione, ma coinvolge il soggetto in quel che ha di più profondo di sé. La verità da testimoniare è una sfida lanciata alla logica della forza che sorregge il mondo; non per fuggirlo o condannarlo e volgersi a un altro mondo, come ha fatto la metafisica o il cristianesimo ideologizzato, ma per affermare la propria ipseità, contraria a tutte le identificazioni in cui il mondo la rinchiude. Sta in questo, suggerisce Jullien, la risorsa universalizzante del cristianesimo: nella sovranità del soggetto che non si assoggetta al mondo, nell’auto-rivelarsi dell’ipseità che diventa fermento di una concezione dell’ex-sistenza. Tenendosi fuori dall’integrazione al mondo, il soggetto passa dalla dimensione della psyché, dall’attaccamento al proprio essere vitale, alla zoé, alla vita sovrabbondante che, scoprendo un più profondo di sé in sé, riconosce l’ipseità dell’Altro. Nella rilettura senza trascendenza che Jullien propone del Vangelo di Giovanni, Cristo non fa appello a un altro mondo, apre invece in questo un’altra dimensione, la dimensione dell’Altro. È necessario stare fuori dal mondo – un volto non è di questo mondo, ha detto Lévinas – per vivere la propria ipseità e tenersi presso l’Altro, o meglio, dice Giovanni, dimorare in lui. È questo il movimento espansivo che caratterizza la zoè predicata da Cristo: l’esteriorità rispetto ai rapporti di forza del mondo è la condizione di una interiorità condivisa fra sé e l’Altro. Il Vangelo predica un unico comandamento, “che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 15,17); ma Paolo non dice “seguite la via dell’amore” (Efesini), come se la strada fosse già tracciata, dice “muovetevi da parte a parte, andate e venite nell’amore” (peripateite). Non l’Eros della filosofia greca, che dal desiderio fisico eleva alla purezza dell’idea, ma agàpe, che non si riduce alla virtù etica della carità o dell’altruismo: indica l’amore espansivo e disinteressato che ignora il possesso, l’amore che annulla la separazione fra gli esseri e consente di “dimorare” nell’ipseità dell’altro.
Leggi anche:
Mario Porro | La vita come processo / François Jullien, sul vivere
Mario Porro | Sul vivere, d’après / François Jullien, aspirare alla felicità?
Mario Porro | Jullien. Lo spirituale dell’arte
Mario Porro | Jullien. Psicoanalisi e saggezza
Mario Porro | Jullien. Né Dio né Male