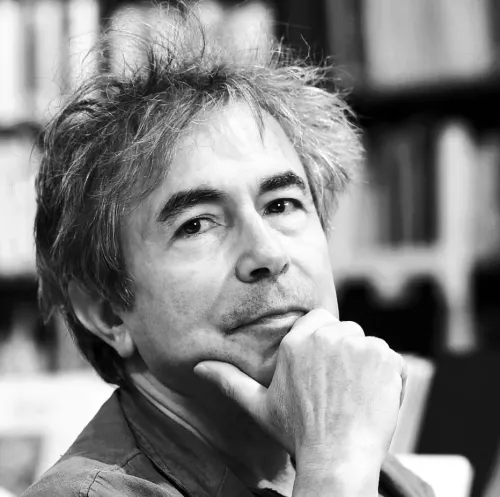Jullien. Né Dio né Male
Nell’immaginario cinese della via (Tao), è la viabilità che va garantita, cioè che si proceda senza ostruzioni, congiungendosi alla logica di rinnovamento per alternanza del processo vitale. Certo, le necessità oppongono continui ostacoli ed è per questo che la saggezza taoica esorta a considerare come “esterni”, non più d’intralcio alla vitalità, il mondo intero e l’assillo stesso del vivere. Viene così a cadere, ricorda François Jullien in Philosophie du vivre (Gallimard, 2011), l’ossessione dell’Occidente per la ricerca di un Senso o di un Fine a cui tendere: vivere, di per sé, non ha né fine né senso, al più ha una direzione, quella che conduce inesorabile al deperimento del nostro potenziale vitale. Per non disperderlo, non bisogna fissarsi su di esso, forzarlo a durare; anzi, solo trascurandolo potrò portarlo al suo pieno regime. “Chi si sbarazza [uccide] della vita non muore, chi cerca di vivere [vivere-vivere, sheng sheng] non vive”, recita la Vegliarda dello Zhuangzi, lei che ha avuto accesso alla “trasparenza del mattino”.
Chi si “attacca” alla propria vita finisce per estenuarla, chi la trascura e se ne disinteressa, elimina quel che la può intralciare. Vivere non è dell’ordine dell’intenzione – voglio vivere, sempre più e a ogni costo –, ma dell’ordine del risultato, è quel che si consegue coltivando la de-preoccupazione. Ed ecco che ritroviamo parole pressoché identiche nel Vangelo di Giovanni (XII, 25): “Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna”. Al di sotto del richiamo al trascendente, si delinea, rileva Jullien in Nutrire la vita (Cortina, 2006), un “fondo d’intesa” fra civiltà estranee e prive per millenni di contatti, un assunto comune trans-culturale, accostabile anche all’esortazione all’atarassia, l’assenza di turbamenti, delle scuole ellenistiche.
Al centro del Vangelo di Giovanni, di cui Jullien ha proposto un’originale interpretazione in Risorse del cristianesimo (Ponte alle Grazie, 2019) con l’intento di farne emergere una filosofia non cristiana, si pone proprio la domanda: che cosa vuol dire essere realmente vivi? Qui emerge una delle risorse che l’Europa ha potuto sfruttare dal suo rivolgersi a Dio: risorsa e non valore, se è vero che i valori sono prospettive e dipendono dall’arbitrio di una valutazione, come sosteneva Nietzsche, nel suo proposito di trans-valutare i valori della tradizione platonico-cristiana in nome della volontà di potenza, cioè dell’ultima (forse) forma della metafisica. I valori si proclamano quando si smette di praticarli, si pretendono esclusivi e si prestano dunque, come il richiamo alle radici, al gioco della chiusura identitaria, mentre le risorse sono aperte, disponibili a chiunque voglia utilizzarle. Non si tratta di riaprire la stantia questione delle radici cristiane dell’Europa, nozione che ripiega il culturale sul naturale, veicola il mito dell’unitario-originale, fa volgere indietro e induce al settarismo – Jullien lo ha ribadito in più occasioni, ad esempio in Il ponte delle scimmie (Lindau, 2017) o in L’identità culturale non esiste (Einaudi, 2018). La fecondità del pensiero europeo si deve semmai proprio al confronto / conflitto tra fede e ragione, uno scarto che ha mantenuto in tensione entrambi. Del resto, il richiamo alle “radici” contraddice proprio una delle principali risorse del cristianesimo, la religione che si è affrancata dal marchio etnico dell’ebraismo: “non c’è più né giudeo né greco …”, ricorda san Paolo nella Lettera ai Galati. L’esigenza di universalità da concetto astratto, com’era nella grecità, o formale, come la cittadinanza romana, diventa nel messaggio evangelico condizione concreta dell’umano – Jullien vi si è soffermato in L’universale e il comune (Laterza, 2010).
Nietzsche accusava la fede cristiana di aver cancellato l’eroismo guerresco e l’esuberanza dionisiaca della Grecità, anche se il tragico era già stato sconfitto da Socrate, l’homo intellectualis che affronta serenamente la morte e prepara la strada a quel “platonismo per le masse” che sarà il cristianesimo. Ma quest’ultimo, rileva Jullien, non ha soltanto promosso la “perversione” a favore dei deboli o il risentimento contro la vita da cui ha avuto origine l’“uomo malato”; ha anche scavato lo spazio di un’interiorità abissale, innescando così una promozione dell’umano grazie all’approfondimento dell’intimità del soggetto. Oggi che appare giunto a compimento l’annuncio dell’uomo folle nietzschiano nella Gaia Scienza – “Dio è morto” –, è ormai priva di effetto, per indifferenza più che per rifiuto, la disputa sull’esistenza o meno di Dio, come insegnava già il Kant della Dialettica nella Critica della Ragion pura. Rovesciando l’impianto dell’indagine trascendentale kantiana, Jullien s’interroga in Mosè o la Cina (Medusa, 2023) sulle “condizioni d’impossibilità” dello sviluppo dell’idea di Dio, sulle ragioni culturali che motivano l’amara constatazione di Montesquieu nello Spirito delle Leggi (1748): “Ne deriva una cosa tristissima: cioè che è quasi impossibile che il cristianesimo si stabilisca mai in Cina”.
La Cina antica ha conosciuto una variante del Dio unico, a cui ha dato nome di “Signore dall’Alto”, ma tale idea non ha assunto consistenza, come se, più che rifiutarla in nome di un ateismo che le è rimasto ignoto, non avesse saputo cosa farsene. Senza suscitare conflitti, attorno al primo millennio a.C., all’avvento della dinastia degli Zhou, un’altra nozione ne ha preso il posto, il Cielo: non la trascendenza del divino che apre l’altro piano, immateriale, della realtà, ma il buon funzionamento del processo del mondo, sempre in cooperazione con la Terra, secondo quella correlazione di opposti complementari (yang e yin) che caratterizza la lingua/pensiero della Cina. La fiducia nell’auto-regolazione del mondo, sorretta dall’ideologia millenaria dell’armonia, dispensa da ogni intervento esterno alla costanza della “via”; la coerenza (letteralmente, il tenersi insieme) del processo manifesta da sé la sua benefica efficacia, non si apre dunque uno squarcio da cui invocare il soccorso dell’Altro, a cui rivolgere quella “parola ferita” che è la preghiera. Non c’è bisogno d’interpretare il Senso promulgato dall’oracolo né della Rivelazione della Parola, neppure di teorizzazioni filosofiche o teologiche. Non sentendo la condizione umana come derelitta, esito di una caduta a cui darebbe consolazione il piano divino della Salvezza, il pensiero confuciano ignora l’appello a Dio dal più profondo di sé, dall’intimus – de profundis clamavi ad Te, Domine, recita il Salmo. L’invocazione promuove uno scavo nella soggettività, già attestato dalle Confessioni di Agostino, anche quando l’incontro con l’Altro (nella mistica o in Simone Weil di Attesa di Dio) è un patire o un’esperienza dell’impossibile.
“La Cina ha fatto a meno di Dio, scrive Jullien, perché ha misconosciuto l’alterità”. Non solo l’Aldilà dell’ideale, il nietzschiano “Mondo Vero” caro alla metafisica, sogno in cui evadere o speranza da realizzare (è il tema di L’invenzione dell’ideale, Medusa, 2011), ma anche, in termini esistenziali, l’Alterità che si presenta nell’incontro con lo straniero al (mio) mondo e che schiude, di colpo, all’incommensurabile (titolo del saggio che fa seguito a Mosè o la Cina, L’Observatoire, 2022). Nel processo scandito dal Tao non si apre il varco per la messa in scena drammatica dispiegata dalla Fenomenologia dello Spirito, per il cammino del soggetto per giungere all’Assoluto. Il pensiero cinese non pensa che per la coscienza il mondo esterno sia l’essere-altro che sta di contro (gegen-stand) e con cui si entra in conflitto; non immagina la lotta a morte per il riconoscimento fra le autocoscienze e neppure la Coscienza infelice che rigetta l’Immutabile al di là di sé e si avverte come inessenziale di fronte al divino. Quel che Hegel presenta come l’esperienza universale dell’umano, ricorda Jullien, non è altro che il divenire particolare della coscienza europea, indissociabile dalle tappe della nostra storia.
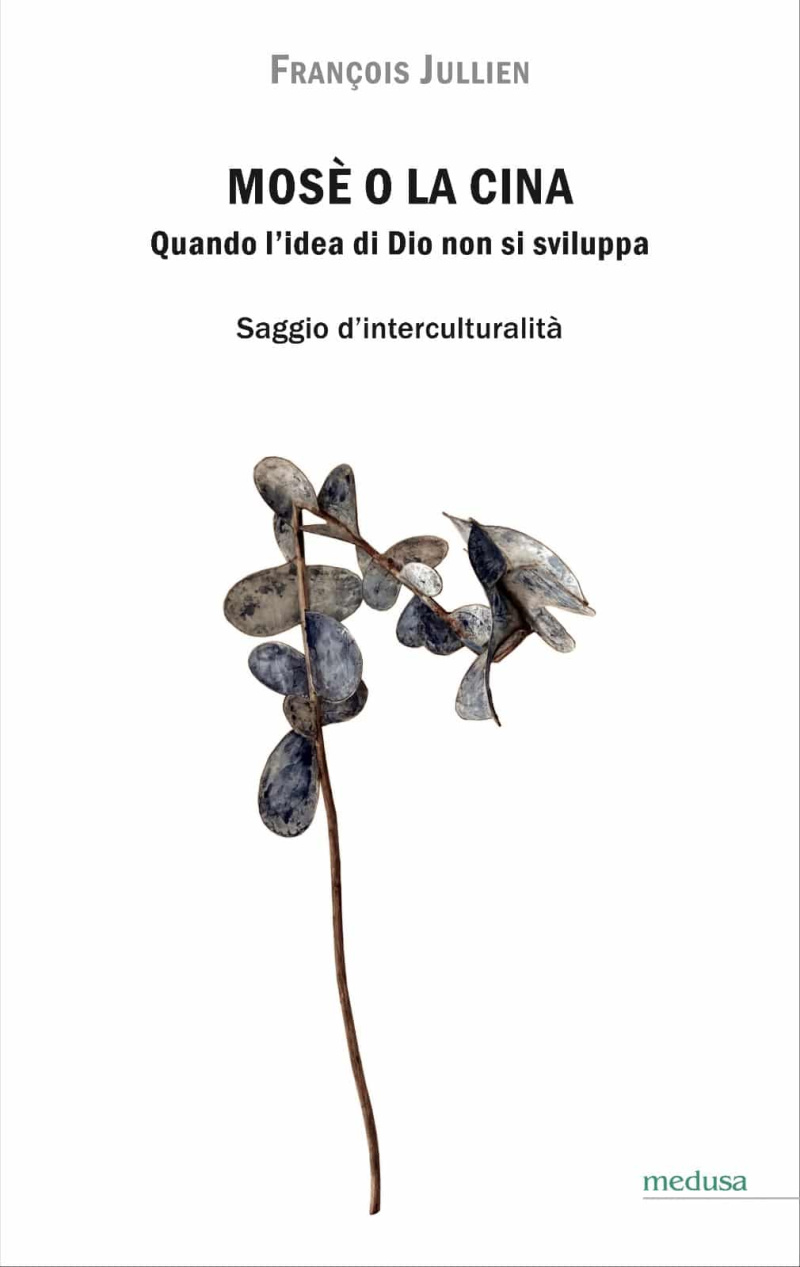
Invece del religioso con i suoi precetti e i suoi dogmi, invece di regole che si vorrebbero dotate di necessità e che immobilizzano arbitrariamente il corso del divenire, la Cina ha visto proliferare i riti che si traducono in norme per incanalare la condotta, come a impedirle di tracimare. Il religioso si è organizzato soprattutto attorno al culto degli antenati, e a presiedere il culto è il continuatore della stirpe, nella famiglia come nello Stato; grazie all’intercezione degli antenati regali, il sovrano a cui è stato concesso il Mandato può far discendere la regolazione del Cielo nell’orizzonte mondano. Dal sovrano ai principi, giù in ordine gerarchico fino agli agricoltori da cui dipendono i raccolti, la “vigilanza rispettosa” per la propria carica diventa la raccomandazione esclusiva a cui conformare in silenzio la condotta individuale. Così, attraverso il formalismo dei comportamenti, il Cielo legittima il corretto funzionamento dell’amministrazione sociale: è la burocrazia, rileva Jullien, a consentire alla civiltà della Cina di fare a meno di Dio. Invece del terrore nei confronti di potenze superiori, del sacro numinoso, arcano e tremendo, il sentimento religioso s’interiorizza in inquietudine morale di demeritare, si converte in responsabilità scrupolosa ad agire in conformità alla regolazione del Cielo. La coscienza si disinteressa dell’Aldilà per accentuare la morale della cura vigile che induce l’uomo, con prudenza e devozione, ad affrontare gli incarichi che gli sono demandati. Non si apre dunque lo scarto fra sacro e profano – spazzare davanti alla porta è già servire il Cielo – che da noi ha visto formarsi una classe sacerdotale; la Cina ha ignorato la distinzione fra quel che dobbiamo a Cesare e quel che dobbiamo a Dio, la sua Storia non ha conosciuto guerre di religione, i massacri perpetrati dai fedeli dell’unica Verità.
La figura tutelare del Cielo promuove un’ideologia, politica ed etica insieme, che si fa garante della coerenza continua della Storia, e di cui la Cina che si dice comunista conserva le tracce. Il Cielo, attento alle sventure degli uomini, affida il suo mandato ai sovrani meritevoli che si accordano con esso, ma sui quali cade comunque la responsabilità dei mali del popolo. La fiducia (non la fede) nell’armonia cosmica e storica impedisce di pensare a una personificazione del Male, scarta la tentazione manichea – ancora viva nel linguaggio politico-religioso del nostro tempo – di ridurre il mondo terreno al palcoscenico dello scontro fra un dio malvagio e il Bene quale “dover essere”, Ideale a cui volge lo sguardo il filosofo sulla scia di Platone. L’enigma del Male in Occidente s’iscrive nel dramma meta-fisico, suppone una separazione di piani fra reale e ideale, induce a pensare l’esistenza come rottura e uscita (ex-sistere) dalla naturalità originaria del vivere. Di qui sorge l’interrogazione sul senso del nostro transitare mortale, l’angoscia delle responsabilità e il fantasma del libero arbitrio da cui si origina la possibilità del peccato e della disobbedienza. Il pensiero dell’Occidente si è così trovato nella necessità di dare un senso alla macchia di cui facciamo tutti esperienza nel cammino della vita, alle “piccole morti” (sofferenze, abbandoni, ingiustizie) che preludono al calare del sipario. Tema classico sullo sfondo delle teodicee di un Occidente che include l’India e l’Islam: è grazie all’ombra nel quadro (titolo dell’originale francese, tradotto con L’ombra del “male”, Colla, 2005) che meglio possono risaltare i colori, è il negativo che rende avvertibile il gusto di vivere. “Un po’ di acido, di aspro o di amaro piace spesso più dello zucchero; le ombre fanno risaltare i colori ed anche una dissonanza posta dove si deve dà rilievo all’armonia”, scriveva Leibniz, per indicare come la parzialità del negativo cooperi alla positività globale.
La Cina non ha conosciuto il teatro della trasgressione e della colpa, la cacciata dal Paradiso e la ribellione al Padre. Nel mondo auto-regolato che ci accoglie e in cui non siamo stranieri, non è presente propriamente il Male, se mai il “negativo”, l’opposto polare che prepara l’avvento del positivo e tiene in tensione il vivere. Al pensiero della Salvezza, che vuole redimersi dal Male e invoca una narrazione mitico o religiosa per sconfiggere le tenebre nella luce della Rivelazione, la Cina oppone un pensiero della Saggezza che integra il negativo nell’armonia e guarda nell’ombra per percepire l’apparire della luce. L’Occidente non ha ignorato la prospettiva della Saggezza; lo stoicismo – che concorda col pensiero confuciano nella concezione di un divenire per immanenza – si serve del verbo adsentior per esprimere il sentimento di fondo di conciliazione con la vita, l’aderenza al corso del mondo. Ecco affiorare, rileva Jullien, un fondo d’intesa trans-culturale, l’ancoraggio originario alla logica metabolica della digestione che è propria del vivere: i mali vengono riassorbiti come accidenti che fanno uscire dall’atonia e promuovono l’inquietudine da cui sorge la ricchezza dell’esistenza. Anche Hegel, nello sforzo di “pensare la pura vita”, si era affidato al “lavoro del negativo” per dischiudere l’auto-movimento del Logos che si fa Soggetto opponendosi a se stesso, che si fa altro per ritrovarsi. L’ottimismo conciliatore della dialettica hegeliana fa del “Male” un “negativo” che coopera con il bene giustificandosi come sua condizione di possibilità: “la ragione astuta” fa emergere anche dalla violenza della guerra il motore del progresso. Non vi sarebbe allora più posto per la teodicea, dato che la riconciliazione non è da attendere in un altro mondo; non c’è più Provvidenza quando Dio si realizza nella storia e il male è destinato a dissolversi nel progredire dello Spirito. La dialettica rimane preda però della logica della destinazione, lascito della rivelazione religiosa, del divenire dello Spirito che ha per fine il compimento nell’Assoluto.
Ma vi è, ricorda Jullien, anche il negativo che paralizza, quello che annulla l’ex-sistenza nella stagnazione, quando vivere sembra arenarsi, nell’inerzia o nella sterilità del conformismo. S’insinua nelle relazioni fra gli amanti per corrodere in modo progressivo e inavvertito la gioia dell’intimità, fa scivolare per “trasformazioni silenziose” le rivoluzioni in dittature. Per sfuggire all’entropia che travolge i sistemi chiusi, le società o le civiltà al tramonto, Roger Caillois evocava una rottura dell’equilibro, un’asimmetria che riporti al caos fecondo delle origini. L’effrazione sopraggiunta dall’esterno, l’evento della festa, della rivolta, o della follia, il varco aperto alle energie della “barbarie”, spezzano la stagnazione e l’atonia secreta dalla durata. Nella prospettiva della Cina antica, il negativo è l’ostruzione della via che non consente la comunicazione con il mondo, l’arresto del naturale procedere delle cose: il male è paralisi, che assume comunque dimensione morale, in quanto si traduce in mancata disponibilità ad accogliere il momento. La saggezza raccomandata dallo Zhuangzi non cerca nell’intervento esterno l’opportunità di sfuggire all’inerzia, nel trionfo del negativo scorge il rinnovarsi del positivo, sotto l’uno vede già spuntare l’altro, come i germogli nel terreno invernale. L’importante è non lasciarsi bloccare, non cadere nella fissazione che impedisce di restare in fase con il processo: “la virtù superiore non è virtuosa”, dice in modo apparentemente paradossale il Laozi, perché, quando si lascia individuare nei suoi contrassegni tangibili, essa ha già perso il suo slancio. La virtù sarà dunque non arenarsi nelle determinazioni, ma tornare all’indeterminazione originaria, dove gli opposti comunicano e non si escludono, per restituire alla vita la sua fluidità: dato che un contrario si rovescia nell’altro, basta situarsi nello stadio opposto per conseguire l’obiettivo a cui condurrà la logica stessa della situazione, porsi dietro per farsi portare in avanti. La sottile intelligenza non è quella dialettica (e rivoluzionaria) della contraddizione, suggerisce Jullien, ma quella strategica della contradduzione, farsi portare dal rovesciamento del moto alternato del tao.
Mario Porro | La vita come processo / François Jullien, sul vivere
Mario Porro | Sul vivere, d’après / François Jullien, aspirare alla felicità?
Mario Porro | Jullien. Lo spirituale dell’arte
Mario Porro | Jullien. Psicoanalisi e saggezza