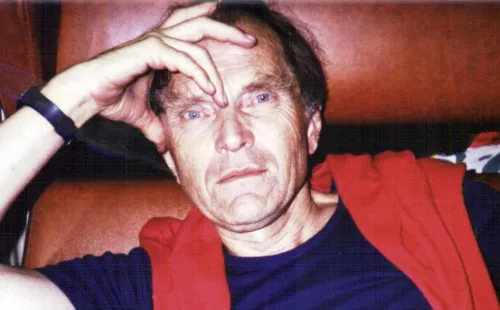Feyerabend, cento anni contro il metodo
Quando apparve nel 1979 (Feltrinelli, l’edizione originale è del ‘75), Contro il metodo – “abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza”, recitava il sottotitolo – ebbe su molti un effetto liberatorio. Con lo slancio di un dadaista iconoclasta, l’autore, Paul K. Feyerabend – nato a Vienna un secolo fa, il 13 gennaio 1924 – si apprestava a demolire l’ultima forma che l’autorità aveva conservato nel dissolversi del Moderno, quella della scienza. Era stato ufficiale dell’esercito tedesco durante la guerra mondiale, in cui venne gravemente ferito alla spina dorsale; tornato a Vienna, dopo aver studiato Fisica e Filosofia, avrebbe desiderato seguire i corsi del concittadino Ludwig Wittgenstein a Cambridge, ma il progetto non andò in porto per la morte dell’autore del Tractatus nel 1952. Feyerabend dovette “accontentarsi” di un altro supervisor, un viennese di nome Karl Popper, come racconta nell’autobiografia dal titolo Ammazzando il tempo (Laterza, 1994), in cui brillano le doti che lo hanno reso famoso e scomodo al mondo accademico, l’audacia e la stravaganza di un intellettuale birichino.

Al cuore di Contro il metodo sta la rivisitazione della difesa del copernicanesimo nel Dialogo sopra i due massimi sistemi. Non godendo ancora di solide conferme empiriche, Galileo deve far ricorso al contributo della retorica, a trucchi dialettici e tecniche di propaganda nel duello contro Simplicio e le credenze ecclesiastiche. Dall’altare dei martiri della razionalità, il fondatore della scienza moderna finiva così relegato nel limbo dei ciarlatani, e degli imbonitori, dei sofisti che fanno apparire forte il discorso debole e confidano nella credulità del pubblico. Non potendo attenersi ai “fatti”, Galileo deve costruire arte-fatti e spacciarli per dati oggettivi; ma la realtà, ricorda Feyerabend, non è data, è costruita grazie a una messa in scena, con dispositivi e apparati analoghi a quelli di cui si era servito Brunelleschi nell’invenzione della prospettiva pittorica (l’esempio si ritrova in Scienza come arte, Laterza, 1984). Non c’è differenza in tal senso fra arte e scienza: in entrambi i casi, il gioco non consiste nell’imitare una realtà immutabile preesistente, ma nel fabbricare una rappresentazione, un allestimento teatrale. Anche Galileo ha costruito una messa in scena, quella dell’esperimento, si è servito di meccanismi di proiezione, come il telescopio, presentati come specchi veritieri della realtà. L’analogia fra arte e scienza per Feyerabend non si ferma qui: quel che diciamo progresso nella scienza non è che un cambiamento di stile, una teoria non viene giudicata migliore per la sua maggiore corrispondenza con la realtà, ma in virtù di un mutamento di gusto.
Il Novecento è stato il secolo dell’epistemologia, emblematicamente racchiuso fra l’anno di nascita di Popper, il 1902, e quello della sua morte, il 1994, lo stesso della morte di Feyerabend. L’epistemologia muoveva dalla convinzione che esistesse un metodo, un insieme di procedure e di regole vincolanti che garantiscono la validità di una teoria, o almeno una “logica della scoperta scientifica”, per citare il titolo del libro di Popper del 1934. Al principio di verificazione del neo-empirismo del Circolo di Vienna – una teoria è scientifica se può essere confermata dall’esperienza – Popper contrapponeva il criterio di falsificabilità: una teoria è scientifica se può indicare i suoi falsificatori potenziali, cioè quali fatti, se accadessero, la renderebbero falsa. Era un modo per cogliere la lezione della rivoluzione di Einstein, le cui ipotesi apparivano contro-intuitive, e di contrapporsi alle velleità di ideologie che si spacciavano per scientifiche come la psicoanalisi o il marxismo. Il razionalismo critico di Popper indicava come metodo l’elaborazione di ipotesi da sottoporre a controllo empirico; non per verificarle, perché chi cerca conferme le trova sempre, ma per metterle alla prova spietata della critica e della sperimentazione. Si procede per congetture e confutazioni, non si muove dai fatti osservati per giungere a elaborare teorie, come vorrebbe il metodo induttivo; al piano della realtà empirica si giunge deducendo dalla teoria le implicazioni che la rendono controllabile.
È questa la strada su cui si muove Feyerabend, come attestano i saggi raccolti in Il realismo scientifico e l’autorità della scienza (Il Saggiatore, 1983) – risalenti agli anni fra il ’57 e il ’77 – e Problemi dell’empirismo (Lampugnani Nigri, 1971). Ma la sua “crociata anti-empiristica” finiva per colpire anche il maestro Karl Popper che del neo-positivismo si era definito l’uccisore; in lui resterebbero “radicali pregiudizi sul sostegno empirico”, poiché il falsificazionismo continua ad assegnare ad asserti osservativi il compito di confutare le teorie. In realtà, rileva Feyerabend, tutti i nostri asserti sono teorici; i dati dei sensi non sono neutrali, un astronomo tolemaico vede un cielo diverso da un copernicano. Certo i “fatti” sono indipendenti dal soggetto, ma sono le teorie a stabilire come relazionarsi a essi; una concezione realista della scienza favorisce la proliferazione di congetture concorrenti. Il desiderio di Galileo d’interpretare la teoria copernicana come descrizione oggettiva del cosmo, e non come strumento più rigoroso per il calcolo dei moti planetari, lo induce a elaborare teorie alternative alla dinamica aristotelica e a difenderle strenuamente.
Il Galileo di Contro il metodo ha condotto la sua ricerca disobbedendo alle prescrizioni della Ragione, alle norme legiferate dal tribunale dell’epistemologo. Non si è attenuto né al metodo induttivo dei neo-empiristi, né a quello ipotetico-deduttivo del falsificazionismo popperiano: non si possono imporre le rigide norme del balletto classico a chi si accinge a scalare un’impervia montagna. Il rispetto delle regole è il nemico peggiore della ricerca scientifica: per continuare a essere inventiva la scienza deve rinnegare la fedeltà a ogni metodologia che voglia in modo aprioristico valutare la pratica dei ricercatori. Meglio, suggerisce Feyerabend, affidarsi al principio “ogni cosa può andar bene”: i metodi sono plurali e circostanziali, da adattare ogni volta alle specifiche particolarità del libero gioco della ricerca. Violare le regole assume allora il valore di unico precetto “razionale” raccomandato alla scienza, un’attività troppo complessa per venire rinchiusa nei canoni logico-formali imposti dai metodologi; i loro principi tengono conto solo della “scienza dei manuali”, quella che di sé offre l’immagine caricaturale di un sistema di enunciati coerenti e ordinati con rigore. Le proposte degli epistemologi valgono per un mondo ideale, sono simili a castelli in aria che “hanno molto in comune con le malattie mentali”. L’imposizione di regole universali “dall’ultima fila di galleria del teatro della conoscenza” non può che entrare in conflitto con il processo storico tormentato del farsi della scienza; è quel che metterà in rilievo Imre Lakatos a proposito della matematica, al quale però Feyerabend rimproverava di essere un “anarchico che si vergogna”. La salda amicizia che li legava – si veda la corrispondenza raccolta in Sull’orlo della scienza (Cortina, 1995) – non impedisce a Feyerabend di accusare Lakatos di essere rimasto fedele all’idea che il progresso delle scienze sia un cammino di approssimazione alla verità. Ma non sarà la verità a renderci liberi (come vuole il Vangelo di Giovanni), “sono lo scherzo, il divertimento, l’illusione a renderci liberi”.

Feyerabend ha allargato le crepe del “buon senso” epistemologico di Popper, portando alle estreme conseguenze la tesi per i cui i fatti sono carichi di teoria; non esistono allora dati “oggettivi” che possano valere universalmente da tribunale per accogliere o rifiutare una teoria, visto che i fatti sono sempre racchiusi in “cornici” che danno loro senso. Una prospettiva in cui l’anarchismo di Feyerabend finiva per incrociare quanto aveva sostenuto Thomas Kuhn con La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962, Einaudi, 1969). Ad accomunarli era anche la lezione del Wittgenstein delle Ricerche filosofiche: Kuhn richiamava l’oscillazione percettiva di fronte all’immagine ambigua di un’anatra-coniglio per esemplificare il modo con cui “paradigmi” differenti orientano lo sguardo sul mondo. L’evoluzione della scienza è un percorso discontinuo, non cumulativo, in cui fasi di “scienza normale”, regolata da un “paradigma” (l’aristotelismo nel pensiero medioevale o la dinamica newtoniana dal Settecento al primo Novecento), vengono rotte da una rivoluzione. Le teorie sono fra loro incommensurabili: non esiste un terreno solido di osservazioni neutre a cui ancorare il controllo sperimentale di teorie in conflitto, dato che il mondo osservato dallo scienziato tolemaico, ad esempio, non è conciliabile con quello di un copernicano. Una conseguenza inaccettabile per chi difendeva la razionalità della scienza: Popper si scaglierà contro il “mito della cornice” (Il Mulino, 1995), contro l’idea che le culture, racchiuse entro rigidi contorni teorici, non abbiano la possibilità di confrontarsi e dialogare.
Quel che il Feyerabend ancora popperiano degli anni Sessanta obietta a Kuhn è di essere rimasto un teorico della “scienza normale” più che delle rivoluzioni, in sostanza un conservatore. Lo attesta il progettato dialogo nel ’65 in cui l’intervento di Kuhn, Dogma contro critica (Cortina, 2000) doveva essere seguito da quello di Feyerabend (assente per motivi di salute) dal titolo rovesciato, Critica contro dogma (da quell’incontro mancato avrebbe avuto origine il convegno collettaneo i cui atti sono in Critica e crescita della conoscenza, Feltrinelli, 1976). In effetti, per Kuhn il “necessario preliminare” alla rivoluzione è il dogmatico rispetto delle norme accolte dalla comunità, l’osservanza rigorosa del paradigma. “Lo scienziato produttivo, per essere un innovatore […], deve essere un tradizionalista cui piace giocare complicati giochi seconde regole prestabilite”. La garanzia del successo delle comunità scientifiche starebbe in tal senso nella resistenza alle novità, nell’adesione al pensiero convergente; solo grazie a quest’ultimo il ricercatore può scorgere le anomalie che intaccano il paradigma in cui si è formato.
Le discontinuità che spezzano l’apparente linearità del cammino delle scienze sorgono solo sullo sfondo di una tradizione di ricerca consolidata: per dirla nel lessico della teoria delle catastrofi di René Thom, è la stabilità strutturale a preparare il terreno della morfogenesi. L’obiezione di Feyerabend è che solo disponendo di un nuovo paradigma si rendono avvertibili le anomalie che intaccano quello antico. Dunque, la cosa migliore è la proliferazione di teorie che possano mettersi reciprocamente in crisi: “Rivoluzione permanente” diventa lo slogan trozkista che Feyerabend oppone alla normalità della chiusa cittadella scientifica.
Popper si era limitato a contestare l’idea della scienza come episteme, sapere fondato sulla salda roccia dei fatti oggettivi; è costruita su palafitte, su congetture che sono frutto dell’inventiva dello scienziato, ardite costruzioni sempre fallibili. La scienza rientra nell’ambito della doxa, di un sapere incerto che si muove comunque nello “spazio delle ragioni” consolidato dal dibattito critico, dalla disponibilità al “dialogo”, dalla sincerità nel riconoscere il giudizio dei fatti – ed è questo il tratto alla base della civiltà occidentale. Il percorso senza fine della ricerca resta per Popper un progresso in cui ci si approssima alla verità per tentativi ed errori, un’evoluzione darwiniana in cui vengono via via eliminate le teorie inadatte. Il Feyerabend che prende sempre più distanza da Popper – accusato di non aver avuto nemmeno un’amante fra le sue studentesse – non si limita a considerare una favola l’esistenza di un metodo scientifico. Dalla concezione di una razionalità flessibile, capace di riconoscere i propri limiti (l’opportunismo dello scienziato di cui Einstein era pronto a vantarsi), Feyerabend giunge al disconoscimento del valore della scienza, una delle tante forme di pensiero che l’uomo ha sviluppato, non necessariamente la migliore. Esemplare in tal senso il caso della medicina affrontato nel Dialogo sul metodo (Laterza, 1989): perché non dovrebbe essere lasciata al cittadino la libertà di scegliere fra l’invasiva e interventista medicina ufficiale e pratiche dolci come l’agopuntura? Una società libera è quella in cui tutte le tradizioni godono di uguali diritti, possono venire insegnate ed entrare in aperta concorrenza, per poi lasciare che siano gli individui a scegliere la strada che prediligono.
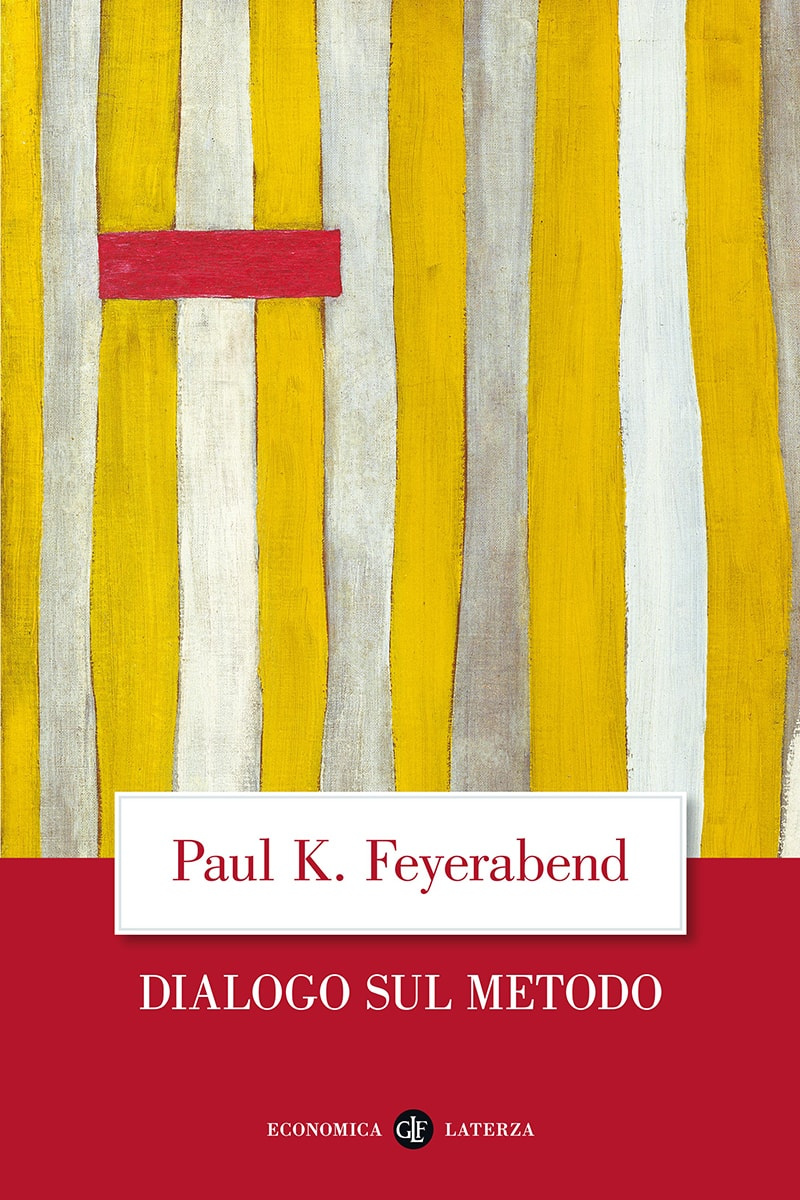
L’anima californiana di Feyerabend, docente a Berkeley a partire dal ’68, finiva così per minare l’autorità della scienza, non più giustificata dal richiamo galileiano alle sensate esperienze e alle necessarie dimostrazioni. La posizione eminente che essa svolge nelle società sviluppate non avrebbe giustificazioni razionali, sarebbe solo il segno della conquista del potere da parte della “setta” degli scienziati, che hanno sostituito gli antichi sacerdoti. Il finale di Contro il metodo proclamava l’obiettivo di “liberare la società dalla presa soffocante di una scienza ideologicamente fossilizzata, come i nostri antenati ci hanno liberati dalla presa soffocante dell’Unica Vera Religione”. In La scienza in una società libera (Feltrinelli, 1978), Feyerabend sosteneva che i pre-giudizi degli scienziati costituiscono un rischio per la democrazia, in quanto limitano le possibilità di altre tradizioni culturali (miti, religioni e credenze condannate perché irrazionali) di esprimersi. Nel volersi custode esclusiva della verità e unico arbitro delle controversie, la scienza stessa si fa portatrice di oscurantismo: dall’atteggiamento critico come connotato proprio alla scienza, Feyerabend passa alla critica della scienza, accusata proprio di quell’autoritarismo contro cui aveva lottato all’epoca di Galileo. Seguace di un pensiero liberale che non disdegnava di richiamarsi a John Stuart Mill, Feyerabend ha annunciato la morte del Dio della scienza; se, ricordava Popper, per chi ha assaggiato l’albero della scienza non esiste paradiso, la prospettiva di Feyerabend ci fa precipitare nell’inferno in cui tutto è possibile e tutto va bene. Non solo verrebbe meno la possibilità di comunicare fra prospettive diverse, ma, in assenza di criteri “razionali” per distinguere il vero dal falso, la scelta fra teorie sarebbe affidata solo alla forza dei gruppi di pressione economica o delle maggioranze politiche del momento. Nel saggio Addio alla ragione (Armando, 1990), Feyerabend si schierava in difesa di Bellarmino, il cardinale che aveva invitato Galileo a parlare del copernicanesimo solo ex suppositione e non come teoria corrispondente alla realtà (ma era anche il cardinale che aveva condotto il processo a Giordano Bruno).
Non sorprende che il pensiero di Feyerabend, pronto a condurre le argomentazioni fino al paradosso, a schierare la razionalità contro se stessa, abbia subito l’ostracismo della comunità degli scienziati e degli epistemologi. Negli ultimi mesi della sua vita Feyerabend rifletteva sul potere totalitario della ragione che, formando concetti generali, riporta all’identico quel che appare diverso e disperde sotto l’universale lo specifico e l’irregolare (Conquista dell’abbondanza, Cortina, 2002; manoscritto ricostruito per volontà della moglie italiana, Grazia Borrini). “La scienza occidentale ha infettato il mondo come una malattia contagiosa”, l’astrazione teorica provoca la distruzione dell’abbondanza, un progressivo (anche nel senso di frutto del progresso) saccheggio del mondo fisico e mentale, ridotto a una Terra desolata. Lo spirito polemico di Feyerabend si rivolge all’ideale che sta all’origine del pensiero dell’Occidente, quell’ideale parmenideo e platonico che, in nome della Verità, va in cerca di idee perfette e immutabili, della realtà profonda nascosta sotto il velo dell’apparenza. L’indagine genealogica torna all’origine del miracolo greco, alla comparsa del logos, quando il presocratico Senofane sostituisce con un Dio unico l’omerica e variopinta ricchezza delle divinità olimpiche. È il peccato originale della reductio ad unum che troverà la sua incarnazione massima nella scienza moderna: il mondo perde la variegata pluralità di suoni e colori per ridursi nelle gabbie di leggi quantitative del moto che impongono regolarità e stabilità. Quel trionfo della Ragione che sarà celebrato dalla Modernità era in realtà l’esito di un percorso storico singolare, la comparsa di una specifica “forma di vita” (termine wittgensteiniano) in cui domina l’universale come equivalente generale, analogo al denaro che sostituisce gli oggetti diversi da barattare. La strategia logico-argomentativa cancella i saperi incerti delle tecniche artigianali: il “cuore di tenebra” della missione civilizzatrice dell’Occidente annulla concezioni traboccanti d’interpretazioni possibili del mondo, in cui l’esperienza sensoriale manteneva viva una relazione corposa con la molteplicità degli esseri. Una concezione monolitica, governata dalle astrazioni fisico-matematiche ed economiche, apre la via al mondo uniformato dalla globalizzazione che si va “riempiendo di conoscenza, puzza, armi e monotonia”. Non esiste una sola modalità valida di conoscenza, ce ne sono (ce n’erano) molte, valide “nel senso che mantenevano la gente viva e rendevano la sua esistenza comprensibile”. La pretesa dei cultori della Scienza di porsi come esclusivi e indiscussi portavoce della Realtà non è che l’espressione tirannica di una tradizione locale che vuole farsi globale.
Credevamo che la modernità coincidesse con il razionalismo critico delle scienze, con la loro capacità di auto-correggersi – la virtù condivisa con la democrazia, suggeriva Popper –, che l’universalità dei diritti umani facesse il paio con l’universalità delle leggi fisiche, quando invece, suggerisce l’autore di Contro il metodo, l’ideologia della Razionalità scientifica distrugge l’abbondanza dell’abito di Arlecchino del mondo. Convinto che “ogni cultura sia in potenza tutte le culture” e che esista sempre la possibilità di comprensione fra di esse, Feyerabend predica la tolleranza nei confronti di pratiche e tradizioni “non scientifiche”, ma rischia così di annullare le ragioni per cui oggi Galileo può con-vincere i tanti Simplicio del nostro tempo. La provocazione di Feyrabend ci ha costretto a tornare su quell’evidenza che Bruno Latour chiamava la “grande Partizione” fra Noi e gli Altri da cui sarebbe sorta la Modernità. Noi, la Civiltà custode della Verità oggettiva e dei saperi efficaci per comprendere e dominare il mondo; gli Altri, primitivi e arcaici, immersi nelle illusioni, ricche ma fuorvianti, incapaci di distinguere la realtà dalle proiezioni del desiderio, di separare la Natura dalla Cultura. “Non esiste nessuna ragione ‘oggettiva’ per preferire la scienza e il razionalismo occidentale ad altre tradizioni”. Dall’epistemologia – di cui ha dichiarato la fine, The End of Epistemology recita il titolo di un suo saggio in La conquista dell’abbondanza – siamo passati alle “politiche della ragione”: un risultato scientifico non sarebbe molto diverso dall’esito di una complicata contrattazione politica. Non sorprende che Feyerabend si sia richiamato alle indagini di Bruno Latour, agli approcci di sociologia o di antropologia della scienza che rivolgono alle pratiche di laboratorio lo sguardo che un tempo gli antropologi dedicavano a civiltà lontane e straniere.