
Ruggero Pierantoni studioso atopico
Come il gatto del Cheshire descritto da Lewis Carroll nel meraviglioso paese di Alice, Ruggero Pierantoni è scomparso alla nostra vista, si è ritirato qualche giorno fa nel regno dell’invisibile, ma per chi lo ha conosciuto o anche ha semplicemente letto i suoi libri resta il suo sorriso, difficile a definirsi come il suo pensiero: chiarissimo se non solare ma allo stesso tempo inafferrabile perché anch’esso sospeso sempre in miracoloso equilibrio tra il materiale e l’immateriale, il concreto e l’astratto, il finito e l’infinito, l’omogeneo e l’eterogeneo, lo stabile e il mobile, il certo e l’aleatorio. Difficile anzi impossibile dire davvero di che cosa i suoi libri (non) trattano. Certo: scienze cognitive, espressione che vuol dire tutto e niente. Come ogni etichetta, se applicata ai libri scritti da Ruggero dice qualcosa, ma non spiega nulla. In ognuno di essi si tratta del rapporto tra la realtà e i modelli di essa che abbiamo avuto e abbiamo in testa. Certo: neuroscienze. Quando di qualcuno non si sa con precisione l’occupazione, nel senso che non si riesce a definirla, ad inquadrarla secondo i canoni che valgono per tutti, a Bologna si dice che egli fa un mestiere “vago”, insomma atipico, inclassificabile, atopico avrebbe detto il Socrate di Platone. Tutti i libri di Ruggero sono in questo senso, e per nostra fortuna, vaghi, anche se precisissimi e minuziosamente documentati, oltre che straordinariamente chiari e suggestivi: la vaghezza di chi ha passato tra l’altro decenni a scrutare in maniera acribica minuscole sostanze al microscopio e, forse proprio perciò, ha sentito poi per una specie di contrappasso il bisogno di rivolgere la stessa attenzione agli universi formali e rappresentativi delle culture, occidentali e orientali, del passato. È molto raro, se mai possibile, e accade soltanto ai davvero grandi, che uno scienziato conservi in età adulta lo slancio e lo stupore, l’entusiasmo e il trasporto dell’adolescenza se non dell’infanzia nei confronti del mondo e delle sue forme. E questo anche nel caso di erranti ed eretici come Ruggero: per Ruggero invece tale sospensione rispetto ai vizi degli adulti era la norma, nel suo caso proprio questo è accaduto. Atopico cioè inclassificabile, egli si è aggirato in maniera del tutto solitaria nel campo della fisica più avanzata e dell’antichità più remota e anche più esotica, inseguendo ciò che è più difficile da afferrare: le forme della luce e manifestazioni ancora più sfuggenti, sempre sulla soglia tra l’analisi della volontà di rappresentazione da parte delle differenti culture e quella degli strumenti e delle mosse mentali di volta in volta impegnati.
Non esitando se doveroso ad ammettere, come nel caso ad esempio della crisi del controllo pittorico della luce per lui evidente in alcuni dei mosaici antichi dopo le grandi prove di San Vitale o di Cartagine, di non essere in grado di comprenderne le ragioni. Ciò che in ogni caso colpisce in ogni sua analisi, sempre o quasi sempre francamente condotta in prima persona, non è soltanto quella che nel mondo anglosassone si chiama scholarship, e che consiste, a proposito di qualsiasi argomento, nel conoscere tutto quello che di rilevante esiste su di esso. Ma Ruggero innestava su tale conoscenza qualcosa di molto raro nel mondo anglosassone in cui era stato costretto (concretamente prima ancora che culturalmente, per l’insipienza del mondo accademico nostrano) in qualche maniera a riconoscersi: una latitudine e un’originalità che, trapiantate su una rara perspicuità espressiva, ne individuavano in ogni momento il pensiero. Nulla gli era più estraneo e alieno dell’espressione che, come amava ripetere a proposito d’altri, risultasse “sticky”, appiccicosa: vale a dire non semplice, non elegante e allo stesso tempo non del tutto significativa ed essenziale come per lui ogni espressione avrebbe dovuto essere. Un dato verso il quale convergevano le sue origini genovesi e la sua educazione americana, secondo un’economia che in ogni punto la sua scrittura esibisce, e contribuisce a fare dei suoi scritti prove in grado di resistere molto più e molto meglio di tanti altri al passare del tempo. Questo perché le domande alla base dei testi di Ruggero erano molto spesso proprio quelle che ci si pone da bambini e cui nessuno il più delle volte risponde, e di cui diventando grandi ci dimentichiamo: che cos’è davvero una stella? Che cos’è un riflesso? Ruggero lo si trovava appostato sempre lì, sul limitare tra resa fenomenica e dato cognitivo, artificio o pratica rappresentativa e strutture che riguardano la luce e lo spazio: un guardiano della soglia molto speciale, sempre pronto allo stesso tempo a stupirsi e a ricondurre quel che si vede alla mossa della ragione, e viceversa.

Anzitutto un fatto d’attenzione, come quando ad esempio si accorge (ma è soltanto uno dei tanti possibili casi che nei suoi libri dissemina come Pollicino lasciava cadere i suoi sassolini) che le anatre dei mosaici romani hanno invariabilmente il proprio riflesso decapitato, nel senso che mai appare sullo specchio d’acqua in cui esse nuotano l’immagine rovesciata della loro testa, a differenza di quel che accade per il resto del corpo. Viene in mente in proposito la favola di Andersen sul re nudo e il ragazzino che, unico, ha il coraggio o meglio l’impulso di farlo notare, smascherando con il suo incosciente ma spontaneo ardire l’atteggiamento generale, e ponendo un problema in grado di rovesciare ogni convenzione o comportamento acquisito. In questo senso Ruggero era davvero radicale, al punto da concludere la sua analisi sull’assenza del riflesso del becco con il seguente interrogativo: “Difficoltà tecnica, tabù rappresentativo o solo cattiva statistica dell’autore?”, cioè di Ruggero stesso? Allo stesso modo, al cospetto dell’intricata mappa stellare dipinta sulla tomba di Ramesse VI nella sala del sarcofago non esita ad ammettere che non vi capisce nulla. Dove la difficoltà di una precisa risposta dipende anzitutto dalla consapevolezza della sterminata estensione dell’universo formale di possibile riferimento, se riferito alle forze del singolo studioso. Cercatore inclassificabile, Ruggero era un solitario, in grado di attraversare con le proprie forze molteplici territori internamente variegati e l’un dall’altro diversi, riducendoli alla propria logica e al proprio dominio. Il contrario appunto del normale docente universitario, spesso specialista di un limitato registro di temi, di solito tradizionalmente ben individuati e circoscritti, immediatamente afferrabili e protetti da rassicuranti cinture di sicurezza.
Ruggero al contrario inseguiva da un secolo all’altro i segni visivi più labili e sfuggenti, i riflessi più sottili e i baleni più effimeri, perché vedeva forme e lineamenti dove gli altri non erano stati e non erano in grado di vedere proprio nulla, di notare alcunché. E per poter far questo era stato costretto a spostarsi, da Pasadena a Tubinga, da Toronto a Filadelfia a Calgary a Ottawa, solo alla fine nella sua Genova, presso l’Istituto di Cibernetica e Biofisica del CNR: chierico vagante lungo il filo sospeso tra continenti e saperi diversi, portatore di un pensiero e di una conoscenza troppo dotti, intelligenti e originali per trovare albergo stabile in una delle nostre comode sedi universitarie. Al punto che tutti i suoi libri, da L’occhio e l’idea del 1980 a Forma fluens del 1986 a Monologo sulle stelle del 1994 a La trottola di Prometeo del 1996 a Verità a bassissima definizione del 1998 a Vortici, atomi e sirene. Immagini e forme del pensiero esatto del 2003, tutti sospesi sull’antichità più storicamente lontana e geograficamente remota, sono ancora passerelle indispensabili per chiunque voglia valicare senza farsi troppo male l’abisso tra i mondi di ieri e quello che ci attende. Come ogni grande e autentico scienziato Ruggero trasformava il più diffuso e apparentemente semplice dei problemi nel fenomeno più complesso e viceversa, e sempre in funzione del soggetto più terribile mai pensato dalla cultura occidentale: l’umanità, cioè l’insieme di tutte e tutti coloro che sono esistiti, esistono ed esisteranno.
Era questo, inevitabilmente e costantemente, l’orizzonte di riferimento del suo pensiero: Ruggero romantico, nel senso proprio e storico, in termini culturali, del termine (anche se personalmente dubito molto che avrebbe apprezzato la definizione). Quel che più colpiva nel suo sterminato sapere, che proprio per questo era tale, era che si trattava evidentemente di un sapere per così dire autoctono, ancora una volta inclassificabile, perché esterno a quasi tutte le convenzioni e ad ogni stilema. Un sapere al cui interno ogni elemento derivava da un moto di personale adesione, da un vissuto in seno al quale sarebbe stato impossibile tentare di separare l’essenza dall’esistenza, un sapere per così dire incorporato, al cui interno il più alto grado di astrazione e la capacità della più minuta attenzione trovavano sempre inedite e originali forme di sintesi e conciliazione. Tutti i suoi libri, sotto tale profilo, resteranno a lungo patrimonio dell’umanità intera, incubando magari ancora per molto tempo in silenzio prima di tornare di nuovo a rivelarsi come essenziali e decisivi, capaci di illuminare non soltanto il passato del mondo ma anche il suo futuro. Ruggero non c’è più, il suo corpo è sottratto alla nostra vista, sfuma nell’aria. Ma resta la sua opera, quello che ha pensato e scritto, e che attraversa tutti i tempi: l’incancellabile, ineffabile sorriso del carrolliano gatto del Cheshire.
Franco Farinelli
***
È stato il nomadismo la cifra esistenziale ed intellettuale di Ruggero Pierantoni, nato a Roma nel 1934 e scomparso pochi giorni orsono, il 30 gennaio. Biofisico di formazione, studioso della percezione acustica e visiva, ha lavorato a lungo al CNR di Genova sul disegno infantile, non per trarne indicazioni psichiatriche, ma per comprendere le strategie grafiche con cui si mira a rappresentare il moto o a rendere la terza dimensione. Scienziato immaginifico e fuori scala rispetto alle clausure specialistiche, aveva lavorato spesso all’estero: visiting professor in numerose università europee, canadesi (a Calgary e Toronto) e statunitensi (in Florida e al Caltech di Pasadena), ma il suo insegnamento non si era limitato alle facoltà scientifiche. Era stato docente di Teoria della Forma all’Accademia di Belle Arti a Genova (dove era stato anche apprezzato assessore alla Cultura dal 1997 al 2002), aveva insegnato presso la facoltà del Design del Politecnico di Milano e all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Raccontava dell’enorme piacere di frequentare le foltissime biblioteche delle università americane (l’avvento di Internet, diceva, non rendeva più necessaria l’emigrazione intellettuale); nelle mattine libere, in compagnia della moglie e dei figli, poteva scivolare in canoa sull’acqua dei laghi canadesi, mentre un leggero strato di nebbia nascondeva la superficie. Il suo spirito era quello del ricercatore, in senso stretto: la passione di apprendere, la gioia delle connessioni impreviste fra arti e scienze, la sorpresa di avventure culturali in territori inusuali e poco frequentati, con un’unica esclusione: certe derive filosofiche lo infastidivano, lui così attento alla precisione e avverso alle vaghezze o agli svolazzi intellettuali. La sua cultura immensa, di cui non faceva sfoggio né vanto, muoveva dalla consapevolezza della propria ignoranza. Con un sorriso autoironico, ricordava di aver creduto a lungo che il Fourier matematico (Jean Baptiste Joseph) fosse lo stesso Fourier (Charles) socialista utopista; e gli pareva impossibile che un unico studioso avesse scritto migliaia di pagine su argomenti tanto disparati. Proprio per evitare “figuracce”, ogni sua pagina era sorretta dalla lettura di tutto quanto era possibile scovare sull’argomento trattato, come attestano le corpose bibliografie che chiudono i suoi scritti (40 pagine ad esempio in Salto di scala). Le sue opere componevano un’intricata tessitura fra le cosiddette “due culture”, ma Pierantoni ricordava di continuo che il transito dall’una all’altra restava impervio ed esponeva a facili ma fuorvianti suggestioni. Certo, esiste un terreno comune in cui arte e scienza coabitano, ma le competenze professionali non si sovrappongono; può accadere che un testo sugli avori ottoniani o sulla porcellana di Sèvres abbia la stessa accurata precisione di un saggio di astrofisica, ma Hugo van der Goes, nel Trittico Portinari degli Uffizi, nel rendere mirabilmente la presenza dell’acqua in un vaso trasparente, non aveva bisogno di conoscere le leggi della rifrazione ottica.
Chi si è lasciato sedurre dal fascino e dall’impressionante competenza dei saggi di Pierantoni – da L’occhio e l’idea (Boringhieri, 1981) a Salto di scala (Bollati Boringhieri, 2012) – sa che seguirlo obbliga a percorrere l’intero Paese d’Enciclopedia. Il Paradiso, sognava Bachelard, è un’immensa biblioteca, ma Pierantoni transitava con sorprendente agilità da una sezione all’altra dei saperi. Ho faticato a ritrovare i suoi libri nella mia biblioteca (che non è certo quella di Eco o di Pontiggia); non erano fra quelli dedicati alla visione e al colore, nemmeno fra quelli di storia della scienza o dei rapporti fra le due culture, con un po’ di sorpresa li ho ritrovati fra quelli di storia dell’Arte. Del resto, Forma fluens (Boringhieri, 1986) è uno dei testi più affascinanti per accostare in modo obliquo l’avventura dell’arte, al pari di Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale di Erwin Panofsky o La storia delle immagini di Fritz Saxl. Il suo campo originario di ricerca, che lo aveva condotto a lavorare al Max Planck Institut di Tubinga, riguardava i meccanismi biofisici e biochimici della comunicazione negli invertebrati, dal livello molecolare ai messaggi scambiati nelle società animali, ad esempio fra le api: sono queste le tematiche che Pierantoni offriva ai lettori di Riconoscere e comunicare (Boringhieri, 1977). Aveva condotto esperimenti sulla memoria delle larve, dopo che la metamorfosi le trasforma in scarafaggi: una questione, diceva, non estranea a Kafka. Sulla percezione acustica e visiva tornava anche La trottola di Prometeo (Laterza, 1996) in cui la spiegazione della fisica dei suoni e delle regole dell’armonia era sorretta da incursioni dotte nella storia della musica, da Tartini a Stravinskij.
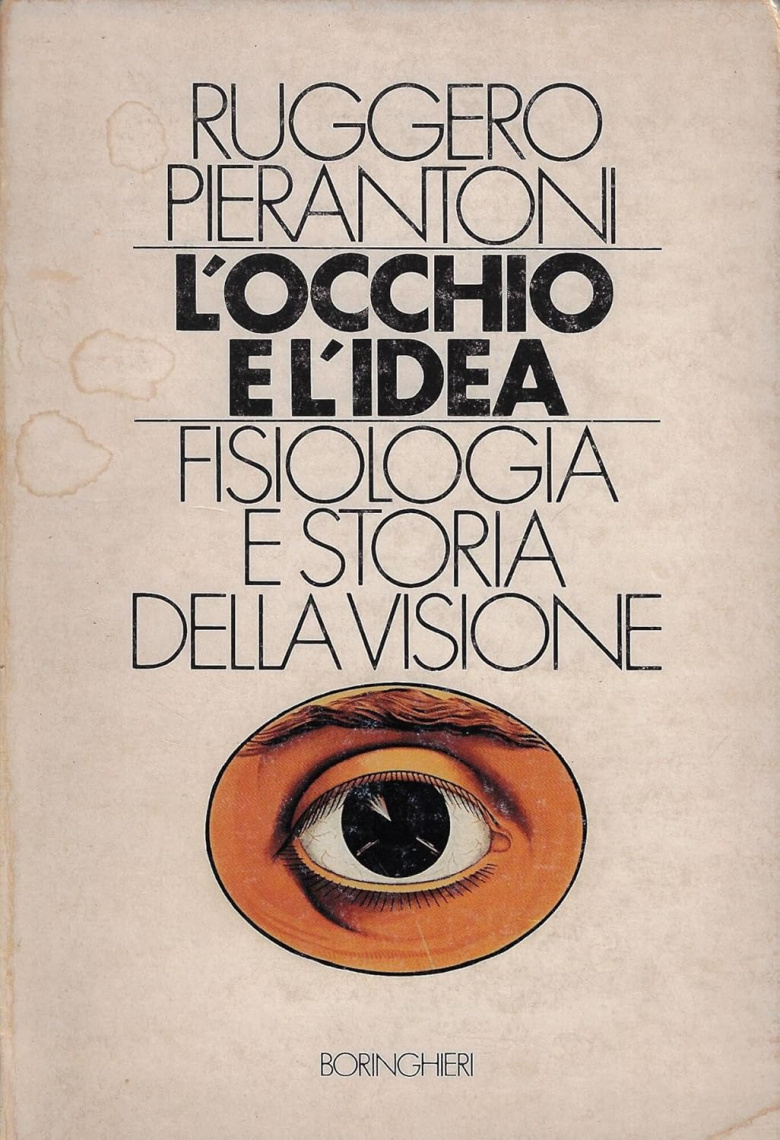
Sarà la pubblicazione di L’occhio e l’idea (Boringhieri, 1981) a renderlo famoso: un testo in cui spiccava quella “scrittura elegante da saggista letterario”, lontana dalla prosa spenta e insapore di tanta divulgazione scientifica, che doveva colpire Italo Calvino (Pierantoni ci ha lasciato anche un romanzo, Segesta domani, Bollati Boringhieri, 1990). La ricostruzione della storia della visione, da Pitagora alla neurofisiologia, muovendo dall’anatomia e fisiologia dell’occhio, si volgeva all’analisi dei “miti”, delle suggestioni filosofiche connesse al vedere: con un costante riferimento alle vicende artistiche, dalle questioni connesse alla prospettiva e alla proporzione, ai conflitti sulla natura ambigua del colore, cercando con gesto bachelardiano di mettere in guardia dalle metafore che hanno ostacolato la comprensione. Nella recensione a L’occhio e l’idea apparsa su “Repubblica”, lo scrittore sanremese, così attento alle tematiche dello sguardo, “scrutatore” ancor prima di assumere le vesti del signor Palomar, mostrava un forte apprezzamento per quella storia dell’ottica scandita dal succedersi di modelli della visione: “In ogni modello Pierantoni ravvisa delle costanti ‘mitiche’ e il filo conduttore del suo libro è appunto il disvelamento di questi ‘miti’ di cui la nostra conoscenza si nutre, che impediscono di comprendere la realtà dei processi naturali anche quando già si dispone di tutti i dati necessari […]. Quest’approccio ‘mitologico’ alla storia della scienza e della cultura mi pare il più giusto e necessario”. Pierantoni sarà spesso invitato a parlare di Calvino – lo sarà anche nel caso del chimico Primo Levi – di cui offriva interpretazioni originali e sorprendenti. In Il nodo, il canestro, il pane e il filo spinato (Quodlibet, 2018) ricordava che “Palomar” si riferisce ovviamente all’osservatorio solare del sud della California, ma un sapiente gioco d’incastri etimologici ci conduce alla “palamara”, variante sud-mediterranea di un termine di origine greca che indicava la “gomena” che teneva unite le galere. Il siciliano “palamaru” era usato per le funi di giunco marino, legate ai lati della tonnara, un mondo che si ritrova anche in ambito ligure, dove compare il termine “paloma”, “colomba” oppure “fionda”. Il termine, scriveva Pierantoni, aveva certo interessato Italo Calvino nel narrare di un universo fattosi “illeggibile” allo sguardo del signor Palomar, che alla fine rinuncia alla lettura del mondo. Non è un caso che l’immagine disegnata da Albrecht Dürer dell’uomo che “scrive la donna dal seno nudo” fu scelta proprio da Calvino per la copertina del libro pubblicato nel 1983 da Einaudi.
In Forma fluens (Boringhieri, 1986), Pierantoni si avventurava nella storia degli artifici figurali, pittorici e plastici, a cui gli artisti hanno fatto ricorso per trasmettere l’idea del movimento. Questione complessa soprattutto quando si tratta di restituire gesti quotidiani, come camminare o correre: gli artisti egizi, nel raffigurare uomini intenti a pescare o a mietere il grano, ricorrono all’artificio di porre il piede sinistro davanti al destro, ma la figura rimane statica, non riesce a evocare la sensazione di un personaggio vivo, non ne restituisce il pathos. Di qui si avviava un percorso suggestivo sulle tecniche di raffigurazione dei corpi in moto, delle forme dinamiche, con richiami ai test cognitivi condotti all’università di Toronto sul modo in cui i ciechi raffigurano gli oggetti: dalla statuina di Eleusi di una fanciulla in corsa (forse Persefone in fuga), attraverso i panneggi delle vesti e il “nuvolismo” di Turner, il libro approdava dopo 590 pagine alle forme uniche di Boccioni e al fuso di bronzo di Brancusi. Ma il tentativo millenario della pittura, la pretesa di mostrare il tempo che lavora lo spazio (magari con la trasparenza dei raggi per suggerire la veloce rotazione dell’arcolaio delle filatrici di Velazquez), sembra risolversi in uno scacco, per la debolezza del nostro occhio/mente nel vedere quel che ci sta intorno. E così, concludeva Pierantoni, invece di cogliere la quarta dimensione, l’arte approda nell’action painting di Pollock alla scomparsa sia della forma che del moto.

Ormai viviamo in una realtà in cui anche la tridimensionalità si è persa a vantaggio della bidimensionalità. Pierantoni lo sosteneva in un saggio dal titolo “Passione e morte della terza dimensione” apparso nel 2003 su una delle prime riviste telematiche, “Golem”. La contemplazione passiva delle immagini colorate e mobili equivale al venir meno della competenza spaziale, della capacità di muoversi in un mondo a tre dimensioni, in cui la profondità di campo, fondamentale per i nostri progenitori cacciatori, diminuisce progressivamente. Solo due categorie di umani continuano a fare uso della terza dimensione: i boy scout e i criminali, i primi a scopo ludico educativo, i secondi per evitare di essere colti in fragrante, ad esempio quando con destrezza strappano i portafogli dalle borsette. Nel Monologo sulle stelle (Bollati Boringhieri, 1994), il vagabondaggio di Pierantoni si fermava su oggetti che appaiono fatti solo di luce e privi di forma, semplici punti che l’iconografia ha tradotto con rapidi colpi di pennello, tessere di mosaico splendenti sulle pareti di Galla Placidia, cristalli sul manto di Mitra. Nel corso dei secoli si è sempre cercato di dare forme precise anche ad oggetti che non rientrano nel percepibile o addirittura sono invenzioni di fantasia. Era questo il tema al cuore di Vortici, atomi e sirene. Immagini e forme del pensiero esatto (Mondadori Electa, 2003): questione che coinvolge anche le illustrazioni a cui ha fatto ricorso la scienza, come nel caso degli anelli di Saturno, della Luna osservata dall’occhiale di Galileo, della forma di atomi e cristalli.
In Salto di scala (Bollati Boringhieri, 2012) l’accostamento alle opere d’arte non avveniva attraverso il gesto simbolico del vedere (il privilegio dell’occhio nasce in un’epoca recente della storia umana, suggeriva Pierantoni), ma affidandosi alla misura. Il lettore era invitato a prendere un righello per misurare in millimetri l’altezza degli uomini raffigurati su di un mosaico di Thera o sui resti di un muro dell’antica Roma; veniva coinvolto in un viaggio avventuroso che costringeva a transitare più volte fra le due sponde dell’Atlantico, seguendo “colossi” come la statua della Libertà, o le assonanze fra il progetto di Suger, l’abate di Saint Denis del XII secolo, e Gutzon Borglum che nel 1927 inizia a trivellare il Mount Rushmore per scolpirvi i volti di presidenti statunitensi. I continui andirivieni di Salto di scala confermano quel metodo “peregrinante” di cui Pierantoni scriveva nella prefazione a Riconoscere e comunicare: il lettore non ha l’impressione di “un procedere retto e sereno per sentieri tranquilli e ben segnati e in paesaggi forse troppo rassegnati […], ma potrà, forse, alla fine scrivere a destra e a sinistra della via seguita con sorridente serenità: Hic leones non sunt”. Ma “misurare non basta, anzi è ingannevole, soprattutto quando non si conosce la storia”: contare ha spesso bisogno del conforto del raccontare. Ecco allora Pierantoni guidarci nei meandri di “biografie di immagini” che si intrecciano con le biografie dei loro autori; mostrarci le varianti delle trasposizioni figurative di un testo scritto o gli slittamenti millimetrici dall’originale alle sue copie o dalla creta al marmo. Quando si ricorre alla misurazione vanno considerate, ricorda Pierantoni, anche le condizioni di visibilità dell’immagine e la sua distanza dall’osservatore. Chi avesse osservato al tempo di Fidia il Fregio delle Panatenaiche, magari la Metopa I con il centauro che strangola un ragazzo, sarebbe stato distante 23,80 metri, con un’angolazione di 45 gradi, mentre adesso al British Museum lo vediamo a soli 2 metri. E il Fregio interno, alla stessa altezza della serie delle Metope, scorre a 10,26 metri da terra, lungo il muro della cella e restava immerso nell’ombra. La serie esterna delle metope è pensabile come una serie di episodi o di istantanee, una successione discreta in senso matematico, adatta a un’osservazione passiva, mentre quella interna è “animata” dallo sguardo di un osservatore in movimento; come Goethe fra le rovine di Paestum, sembra che “solo girandovi intorno e percorrendole da una parte all’altra si comunica loro una vera vita”.
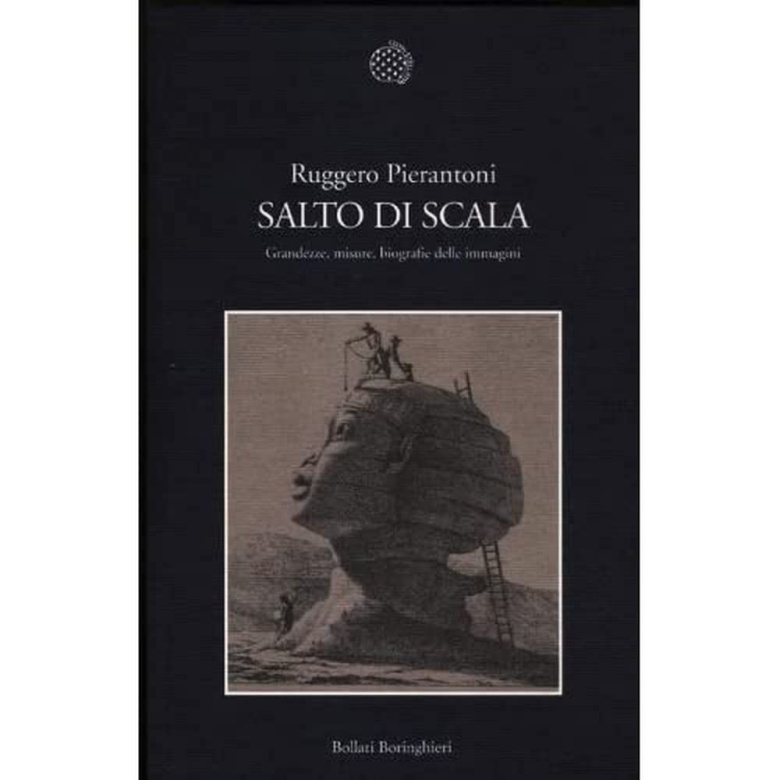
Il tempo comincia a fare capolino dentro lo spazio: il fregio continuo delle Panatenaiche assume un andamento “melodico”, può essere visto solo suonandolo, suggerisce Pierantoni. Spesso dimentichiamo che il vedere presuppone una complessa attività in cui è rilevante la gestualità corporea. Forma fluens si apriva con l’illustrazione della mano sinistra lasciata sulla parete della grotta di Pech-Merle, richiamata nell’epilogo: nelle case delle città centinaia di milioni “siedono inerti e immobili con gli occhi irrigati da una luce azzurra. Davanti a loro si agitano immagini minuscole colorate e frenetiche i cui moti si ripetono identici per ore […]. Forse, un istante prima dell’aurora, contro un muro qualsiasi qualcuno poggerà la palma a dita spalancate. E con l’altra, libera e colma di colore, ne segnerà il profilo fermo nel cemento”.
Mario Porro
Leggi anche:
Mario Porro | Ruggero Pierantoni. Salto di scala









