“Ora, se mi chiamano, non mi giro”. Politiche dell’autismo
“Autismo” è una parola che ha avuto una fortuna crescente negli ultimi anni, capace di generare dibattito nelle più disparate discipline, dalla neurologia e la psichiatria alle scienze sociali, in un andirivieni incredibilmente fertile fra teoria e pratica, grazie a un emergente ambito di attivismo. Più precisamente, la presa di parola delle persone autistiche sull’oggetto stesso, dando vita a quello che Ian Hacking ha definito “looping effect”, lo ridefinisce, dislocandolo continuamente. Non solo: lo sguardo critico sulla neurodiversità è in grado di porre nuove domande di tipo epistemologico sullo statuto delle scienze mediche, sulla natura della diagnosi, sui concetti di “normalità”, “disabilità”, e molti altri ancora.
Ne è testimone la recente raccolta curata da Alberto Bartoccini, Lorenzo Petrachi e Giulia Russo per DeriveApprodi, Politiche dell’autismo. Etica, epistemologia, attivismo. I saggi che compongono il volume sono tutti scritti da persone neurodivergenti/autistiche e pongono – dialogando anche fra loro – una serie di questioni teoriche inedite in Italia, a partire dall’esperienza personale. In questo senso, contribuiscono a colmare un vuoto che, nel nostro paese, ha iniziato soltanto negli ultimi anni ad essere popolato di traduzioni e contributi originali. Se, infatti, nel mondo anglosassone si parla già dagli anni Settanta di Disability Studies, facendo riferimento ai modelli sociali della disabilità, dalle nostre parti pochi dei testi fondativi sono arrivati nella nostra lingua, e soltanto molto di recente (fra questi, è d’obbligo menzionare Michael Oliver, Le politiche della disabilitazione, ombre corte 2023). Se altrove si è formato da tempo un campo specifico come quello dei Critical Autism Studies, caratterizzato da un dibattito intenso e capace di influenzare la produzione accademica, qui alcuni gruppi di ricerca indipendente hanno iniziato a far conoscere questi lavori, a dire il vero con una certa intensità, se diamo uno sguardo a quanto pubblicato in Italia negli ultimi anni. Il primo di questi contributi è il volume di Enrico Valtellina, Tipi umani particolarmente strani. La Sindrome di Asperger come oggetto culturale (Mimesis, 2016), cui segue la selezione di testi tradotti L’autismo oltre lo sguardo medico (Erickson, 2020). L’associazione Neuropeculiar cura, nel 2022, la raccolta di testi provenienti dall’attivismo autistico italiano Almanacco TUPS (LEM edizioni), dove l’acronimo indica proprio quei “tipi umani particolarmente strani” individuati da una definizione “dal basso” che si propone di resistere alle narrazioni patologizzanti del funzionamento autistico. In questo solco si inserisce il successivo La triade dell’autismo. Etica, epistemologia, attivismo, a cura dell’Anonima Autisticɜ Associatɜ (LEM, 2024), e, appunto, Politiche dell’autismo.
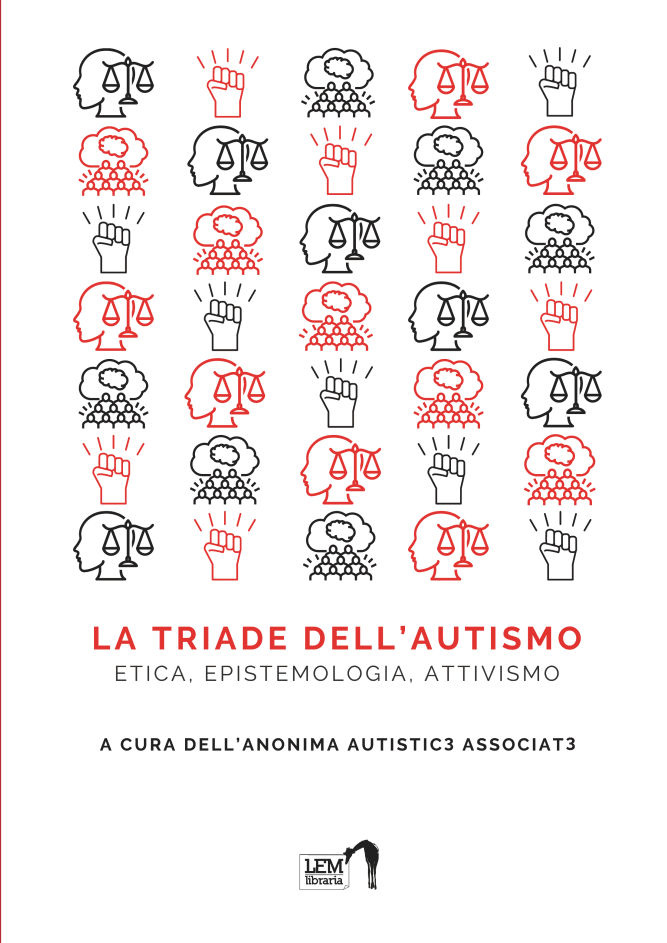
Il mosaico dei testi, per certi versi molto eterogenei, delinea anzitutto un percorso storico-epistemologico fondamentale per comprendere i termini del dibattito. L’autismo, originariamente inquadrato come manifestazione precoce della schizofrenia, diventa un’entità nosografica autonoma in seguito agli studi, pressoché contemporanei ma indipendenti fra loro, degli psichiatri Leo Kanner e Hans Asperger negli anni Trenta-Quaranta. Si aprirà poco dopo la lunga stagione dell’interpretazione psicodinamica, con la celebre teoria delle “madri frigorifero” di Bruno Bettelheim che verrà scalzata grazie alle rivendicazioni dei genitori. Si intravede, qui, un primo elemento di interesse nel rapporto conflittuale fra scienza, potere medico e attivismo, tanto che si arriverà a definire l’autismo come un advocacy disorder, un disturbo “per il quale i genitori sono attivamente impegnati nella ricerca di una diagnosi” (Alice Scavarda, Radicalmente differente?). Gli ultimi decenni sono caratterizzati, invece, dalla presa di parola delle persone autistiche che, appunto, non si limitano a ricercare una diagnosi, ma modellano i confini e le caratteristiche dell’oggetto stesso, influenzando – fra le altre cose – le continue ridefinizioni che lo stesso DSM sembra portato a compiere per stare al passo con un campo di indagine in continuo divenire. Per comprendere questo processo, alcun* attivist* e studios* si rifanno al concetto di “tipi umani” di Ian Hacking: “ciò che caratterizza le scienze umane è che le classificazioni, a differenza di quelle su cui si ancorano le scienze dure, sono interattive, i soggetti che vengono detti da una categoria, assumendola, ne ridefiniscono i caratteri” (Enrico Valtellina, Classificazione, interpellazione).
In questo senso, la storia dell’attivismo autistico è prima di tutto un’opera di decostruzione e smantellamento delle numerose teorie che si sono avvicendate in una comunità scientifica poco attenta al vissuto delle persone e alle specificità dei singoli individui “nello spettro”. Tale attitudine critica ha presto assunto connotazioni autenticamente intersezionali, come dimostrano, per citare un caso particolarmente emblematico, i saggi di Carlo Gervasi, Devirilizzare l’attivismo e di Eleonora Marocchini, Le comunità autistiche: comunità di conoscenza rifiutata o alternativa?, che si cimentano in un corpo a corpo con una cornice esplicativa – quella dell’extreme male brain theory di Simon Baron-Cohen – che riverbera, nascondendolo, il privilegio cisetero sulla definizione di “autismo”. Secondo questa teoria il cervello femminile sarebbe naturalmente più portato all’empatia, mentre quello maschile sarebbe più predisposto alla sistematizzazione. L’autismo non sarebbe altro che uno squilibrio in direzione di quest’ultima. Tale teoria, oltre a rafforzare, assumendola acriticamente, una forma di neurosessismo, influenzerà buona parte del dibattito scientifico e delle politiche di welfare, alimentando lo stigma contro la figura dell’autistico “privo di empatia”.
Anche i contributi di taglio antropologico (Francesca D’Egidio, Sulle tracce delle esperienze femminili autistiche nel Sud antico), quelli relativi alla comunicazione di massa (Angelica Mereu, Autismo nei media tradizionali e sui social; Silvia Maestre Limiñana, Violenza epistemica nella rappresentazione dell’autismo) e quelli che parlano espressamente di attivismo (Giulia Gennaro, Autistica e female presenting nello spazio pubblico, per esempio) fanno emergere un posizionamento di genere decisivo per leggere la violenza delle tassonomie psichiatriche e della rappresentazione culturale – apertamente stigmatizzante o più sottilmente pietistica – della comunità autistica.
Ne emergono una serie di modi di intendere la neurodiversità che fanno riferimento più a definizioni “per sottrazione” (che cosa l’autismo “non è”), per loro natura porose, più che a etichette nosografiche circoscritte e impermeabili. All’interno di una riflessione sul welfare, la cura, l’interdipendenza e l’autonomia, la diagnosi stessa diventa uno strumento ambivalente. Sottoposta a critica feroce da quei movimenti antipsichiatrici cui l’attivismo autistico è pure debitore, essa è notoriamente un elemento ricercato dalle singole persone autistiche in chiave di autoconsapevolezza, se non di emancipazione. E si presenta anche – il che non è per nulla irrilevante – in forma di autodiagnosi (Giulia Russo, Esperienze di autodiagnosi tra epistemologia e politiche della cura). Anche in questo caso, come sottolinea il saggio di Valtellina, l’oggetto “diagnosi”, in un campo che non accetta pienamente di essere ridotto né al potere psichiatrico né al determinismo neurologico, finisce per perdere la sua identità originaria, mostrando che non solo le singole diagnosi, non solo le singole tipologie di diagnosi, ma persino il concetto stesso di “diagnosi” vada inquadrato storicamente, genealogicamente: un ingenuo realismo si sgretola, per mostrare la vita che scorre dietro le classificazioni, pur senza approdare a un altrettanto ingenuo nominalismo (che nella vita di tutti i giorni si esprime con il diffuso adagio normotipico “ma allora siamo tutti un po’ autistici..:”; per una confutazione sintetica ma particolarmente chiara e convincente delle retoriche di questo tipo, si veda Eleonora Marocchini, Neurodivergente. Capire e coltivare la diversità dei cervelli umani, Tlon, Roma 2024).
Del resto, è ancora Ian Hacking a definire la diagnosi di autismo una “diagnosi amministrativa”: “un modo per individuare popolazioni eterogenee di soggetti che necessitano di un supporto”. Ed è qui che emerge lo scarto impressionante fra le categorie istituzionali e quelle elaborate dall’attivismo. Quest’ultimo rifiuta decisamente l’idea dell’autismo come “malattia” o come “disturbo”, e ha superato da tempo espressioni come “affetto da autismo” (sebbene l’adozione di una correttezza comunicativa celi spesso un “approccio cosmetico” che sottende concezioni altrettanto escludenti, seppur imbellettate, come mostra molto bene il saggio di Alessandro Monchietto e Alice Sodi, Desiderare con strategia).
E allora la diagnosi può essere letta come evento, come atto linguistico, e più precisamente come forma di interpellazione in senso althusseriano. Soltanto che, dice Valtellina, quando il poliziotto che rappresenta l’autorità della società circostante apostrofa una persona autistica, questa, forse, non risponde nel modo atteso: “ora, se mi chiamano, non mi giro, e questa mi sembra la più deliziosa delle risposte autistiche”.
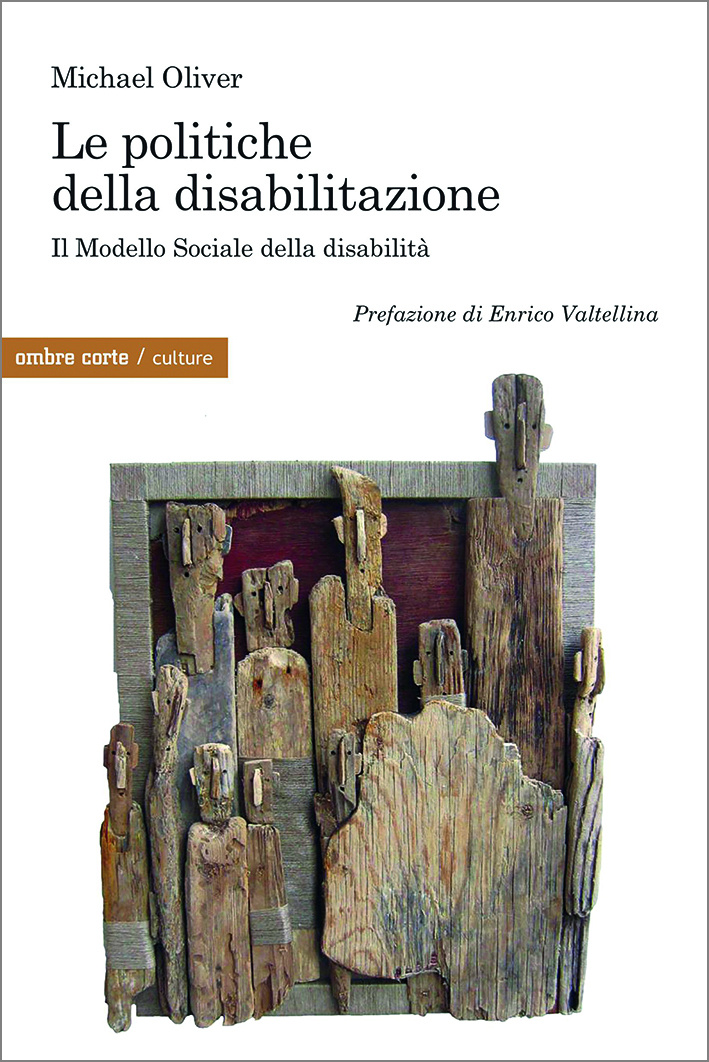
Su questo crinale, è ineludibile il problema del rapporto con la psichiatria e con i movimenti di critica, in un contesto in cui la relazione con il sapere medico è fecondamente ambivalente, sempre più consapevole della sua natura ambigua di sapere disciplinare, nel senso foucaultiano del termine – e dunque normalizzante –, ma al tempo stesso non privo di un potenziale emancipatorio, o almeno di costruzione di senso. Del primo polo, quello dei pericoli della psichiatria, testimonia Marialuisa Amodio (Il labirinto dei desideri), tematizzando lo stigma sul disagio mentale e il modo in cui si riverbera sulle non conformità relazionali, sensoriali, emotive fra le quali l’autismo è il funzionamento più discusso: lo fa in modo estremamente coinvolgente, soprattutto perché parte dall’esperienza di chi ha subito l’abuso psichiatrico. L’idea di configurazioni individuali portatrici di un senso che fatica ad emergere nell’ordine del discorso dominante è invece al centro del saggio di Viviana López Torres e Majia H. Nadesan (Autismo e singolarità del senso), che propongono una serie di strumenti concettuali in grado di superare il modello biomedico.
In generale, quello del confronto fra advocacy autistica e pratica psichiatrica è un tema complesso, che Luca Negrogno approccia nel suo saggio (Premesse a un dialogo tra deistituzionalizzazione e neurodiversità) prendendo in esame l’ambito di critica alla psichiatria che nel nostro paese ha avuto la maggior fortuna, quello basagliano. Negrogno cerca di mostrare come entrambi gli “attori” in gioco – Basaglia e il movimento per la neurodiversità – siano decisivi l’uno per l’altro: il primo costituisce uno stimolo critico preziosissimo per il secondo, mentre il secondo può combattere la “monumentalizzazione” del primo, e dunque il suo recupero istituzionale, il suo addomesticamento. Occorre notare, qui, le possibilità che il significante “autismo”, come anticipato all’inizio, dischiude: parola sfuggente, che tuttavia rifiuta la diluizione omeopatica nell’idea di un possesso indiscriminato dei “tratti autistici” da parte della totalità della popolazione; significante in perpetuo, e rapido, divenire al di là – e talvolta contro – gli specialisti; termine che mostra il paradosso, forse scandaloso, di uno stretto rapporto fra diagnosi e istanze di depatologizzazione; parola-manifesto per un’identità che non si limita a difendere (cosa di per sé del tutto meritoria) i diritti di una “nuova” minoranza, ma che lancia una sfida generale alle richieste di performance sempre più stringenti del modo di produzione e di organizzazione sociale dominante. Questa sfida – e questo mi pare l’elemento più perturbante e promettente – non guarda soltanto a chi, nella distribuzione statistica, possiede un cervello “diverso”, a chi possiede un funzionamento agli estremi della curva gaussiana: la rivendicazione di rispettare radicalmente i singoli modi di essere è per ogni persona, comprese quelle neurotipiche.
Tale aspetto emerge molto chiaramente nei saggi di Alessandro Bartoccini, Schiacciati dal mito di Gramsci, e Lorenzo Petrachi, Affinità e neurodivergenze fra il compagno Marx e noi. Bartoccini muove dalla propria esperienza di attivismo, confrontandosi con il paradigma del militante, “un supereroe, un intellettuale organico, sapiente e instancabile, un modello con il quale anche persone abili in un senso tradizionale difficilmente possono stare al passo, e che genera un forte senso di inadeguatezza”. Una serie di domande squisitamente pratiche, sul solco della Teoria della donna malata di Johanna Hedva, rivelano l’importanza del paradigma della neurodiversità per l’attivismo anticapitalista: come rivendicare il proprio spazio nelle lotte? Come sfuggire a una visione spettacolarizzante ed eroica della disabilità che rientra continuamente dalle finestre delle associazioni, dei centri sociali, dei luoghi di riunione dei collettivi? Come includere davvero la molteplicità di funzionamenti sensoriali, relazionali, cognitivi – e, aggiungerei a questo punto, politici? Come disinnescare la produttività e la gabbia delle aspettative nella politica dal basso?
Non è dunque un caso se Petrachi accosta, in un modo che a questo punto non dovrebbe sorprendere troppo, il concetto di biodiversità secondo colei che ha contribuito a diffondere il termine, la studiosa e attivista Judy Singer, e quello di comunismo in Marx. Entrambi mettono al centro i bisogni, e non chiedono né più né meno di quanto non sia già implicito nel noto adagio “da ognuno secondo le proprie capacità a ognuno secondo i propri bisogni”. Ed ecco perché l’autismo “rappresenta attualmente non solo una modalità di funzionamento, ma una possibilità di far funzionare il mondo”.
Leggi anche:
Moreno Montanari | Diversi da chi? Autismo e alterità
Enrico Valtellina, Popi Porrini | Tipi Umani Particolarmente Strani
Pino Donghi | Autismo e creatività
Anna Stefi | Scuola: dislessia, autismo e bullismo
Pietro Barbetta | L'autismo oltre lo sguardo medico
Enrico Valtellina | Asperger: la sorte di un nome
Anita Romanello | Cervelli diversi









