Speciale
Dizionario Levi / Ibrido
Il testimone, il chimico, lo scrittore, il narratore fantastico, l'etologo, l'antropologo, l'alpinista, il linguista, l'enigmista, e altro ancora. Primo Levi è un autore poliedrico la cui conoscenza è una scoperta continua. Nel centenario della sua nascita (31 luglio 1919) abbiamo pensato di costruire un Dizionario Levi con l'apporto dei nostri collaboratori per approfondire in una serie di brevi voci molti degli aspetti di questo fondamentale autore la cui opera è ancora da scoprire.
“Gli incroci sono fecondi, sempre”, afferma Levi in un’intervista a Federico De Melis sul “Manifesto” nel maggio del 1983, al tempo della traduzione del Processo di Kafka. Credo che nella “fecondità degli incroci” si possa indicare il fulcro tematico dominante attorno al quale ruotano le prospettive del pensare di Levi. Le “nozze” fra entità diverse (se non opposte) danno origine a realtà ibride; il latino hybrida, “bastardo”, è di etimo incerto, ma in esso si sospetta la presenza dell’hybris greca, eccesso, violenza, da cui il verbo hybrizein, cioè essere sfrenato, varcare i confini. Su quelle entità miste – dal latino miscere, mescolare, sarebbe poi derivato “meticcio” – è gravata la condanna del pensiero dell’Occidente, già a partire dai Greci. Solo l’oggetto dai contorni netti, che è dunque possibile de-finire, merita l’attenzione del Logos, di una Ragione che conosce solo due valori e impone di escludere il terzo, l’indistinto che confonde in sé i contrari. La formazione chimica ha certo contribuito a sviluppare in Levi quel “pensiero della mescolanza” in cui Gaston Bachelard (Il materialismo razionale, 1953) indicava il modo in cui il chimico moderno, attento al carattere ibrido e impuro delle cose, si dispone di fronte alle reazioni degli elementi. È questa la lezione politico-morale che Levi riceve nel suo primo giorno di laboratorio all’Università torinese, ricorda in Il sistema periodico (1975). Il tenero zinco, il “metallo noioso” con cui si facevano i mastelli per la biancheria, è arrendevole di fronte agli acidi, ma “resiste ostinatamente all’attacco” quando è molto puro. Non è la purezza come protezione dal male o la virtù immacolata a venire elogiata, bensì l’impurezza perché “dà adito ai mutamenti, cioè alla vita. […] Perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze, e le impurezze delle impurezze: anche nel terreno, come è noto, se ha da essere fertile. Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape: il fascismo non li vuole, li vieta, e per questo tu non sei fascista; vuole tutti uguali e tu non sei uguale”.
La chimica diventa filtro interpretativo, chiave di lettura per la comprensione della propria identità e, più in generale, delle relazioni umane. Levi non si sente più estraneo (xenon), come gli antenati ai margini della società rievocati in “Argon”, il primo capitolo di Il sistema periodico, ma diverso e quindi fecondo rispetto alla pretesa ideologica del fascismo, di ieri e di oggi, che persegue l’uniformità sterile, l’equilibrio entropico e terminale in cui le differenze si annullano. “Sono io l’impurezza che fa reagire lo zinco, sono io il granello di sale e di senape. L’impurezza, certo: poiché proprio in quei mesi iniziava la pubblicazione di La Difesa della Razza, e di purezza si faceva un gran parlare, ed io cominciavo ad essere fiero di essere impuro”, conclude il capitolo “Zinco”. L’identità leviana si declina al plurale: da un lato il radicamento, il sentirsi italiano e piemontese, dall’altro la rivendicazione della condizione di minoranza impura che può arricchire la vita culturale del paese in cui vive, spiega Levi conversando con Philip Roth. Possedere due culture è un segno di ricchezza: di qui il desiderio, non di assimilazione, cioè di cancellazione della differenza, ma d’integrazione, che era di suo padre, ed il connesso rifiuto del sionismo. Nell’omaggio che “Argon” dedica agli avi, fuggiti dall’intolleranza spagnola di fine Quattrocento, l’attenzione si rivolge ben presto al dialetto di quel “piccolo popolo”, che mescola termini ebraici storpiati con desinenze e flessioni piemontesi. Anch’esso un “ibrido linguistico”, “yiddish minore e mediterraneo, più locale e meno illustre” rispetto a quello, levigato dai secoli, dell’ebraismo askenazita, che Levi incontra ad Auschwitz. Quel gergo dall’evidente radice “umiliata”, possiede un notevole interesse umano, osserva Levi, come quello di tutti i linguaggi di confine e di transizione; contiene una “mirabile forza comica, che scaturisce dal contrasto fra il tessuto del discorso, che è il dialetto piemontese scabro, sobrio e laconico […], e l’incastro ebraico, carpito alla remota lingua dei padri, sacra e solenne, geologica, levigata dai millenni come l’alveo dei ghiacciai”. Ogni condizione ibrida si alimenta del contrasto fra gli opposti che non si escludono ma si mantengono in tensione reciproca, schisi dolorosa ed insieme connubio vivificante. Quel linguaggio miscelato rispecchia il contrasto interno all’ebraismo della Diaspora, in bilico fra vocazione divina e miseria quotidiana, e da cui sorge il suo riso di salvazione, dirà La ricerca delle radici; ma un altro contrasto ancora rispecchia, “quello insito nella condizione umana, poiché l’uomo è centauro, groviglio di carne e di mente, di alito divino e di polvere” (SP).
“Io credo proprio che il mio destino profondo (il mio pianeta, direbbe don Abbondio) sia l’ibridismo, la spaccatura. Italiano, ma ebreo. Chimico, ma scrittore. Deportato, ma non tanto (o non sempre) disposto al lamento e alla querela”, afferma Levi in un’intervista del 1982. L’unitas multiplex che forma l’identità di Levi è il “precipitato chimico” della stratigrafia composita della sua formazione: studente del Liceo classico attratto da una scienza di cui farà il suo “primo mestiere”, avido lettore dei libri prelevati dalla biblioteca paterna, che finiscono per “reagire fra loro” nel costruire “una cultura disordinata, lacunosa e saputella”, dirà la premessa a L’altrui mestiere. Dal ’66, al tempo della messa in scena a Torino di tre suoi atti unici (poi confluiti nei racconti di Storie naturali), Levi adotta per autodefinirsi l’immagine del centauro: “Io sono un anfibio, un centauro. Io sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un’altra invece è totalmente distaccata dalla prima, ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli. È una spaccatura paranoica (come quella, credo, di un Gadda, di un Sinisgalli, di un Solmi)”. Alla percezione di una incomunicabilità fra le due sfere, il lavoro diurno della fabbrica e la fatica notturna della scrittura, finirà per sostituirsi la ricerca fortunata di un congiungimento: dal quotidiano delle pratiche di laboratorio sorgono suggestioni che aprono la routine del tecnico a implicazioni distorte o al mistero, come avviene nella fantascienza “italica” di tanti racconti di Storie naturali (1966) e di Vizio di forma (1971). Il “primo mestiere” diviene una riserva privilegiata per dare sfogo alla vocazione fantastica, si traduce in narrazione delle “avventure spirituali” che anche il chimico vive, come il marinaio di Conrad. E il lavoro, grazie al contatto della mano con la materia e alle sfide che impone, riscopre le emozioni più antiche dell’uomo, i momenti di incertezza che accompagnano l’indagine, il successo e la sconfitta. Il chimico procede come un detective che scova gli indizi per giungere al colpevole, mette alla prova le sue ipotesi di ricerca e misurandosi con la materia si misura con se stesso.
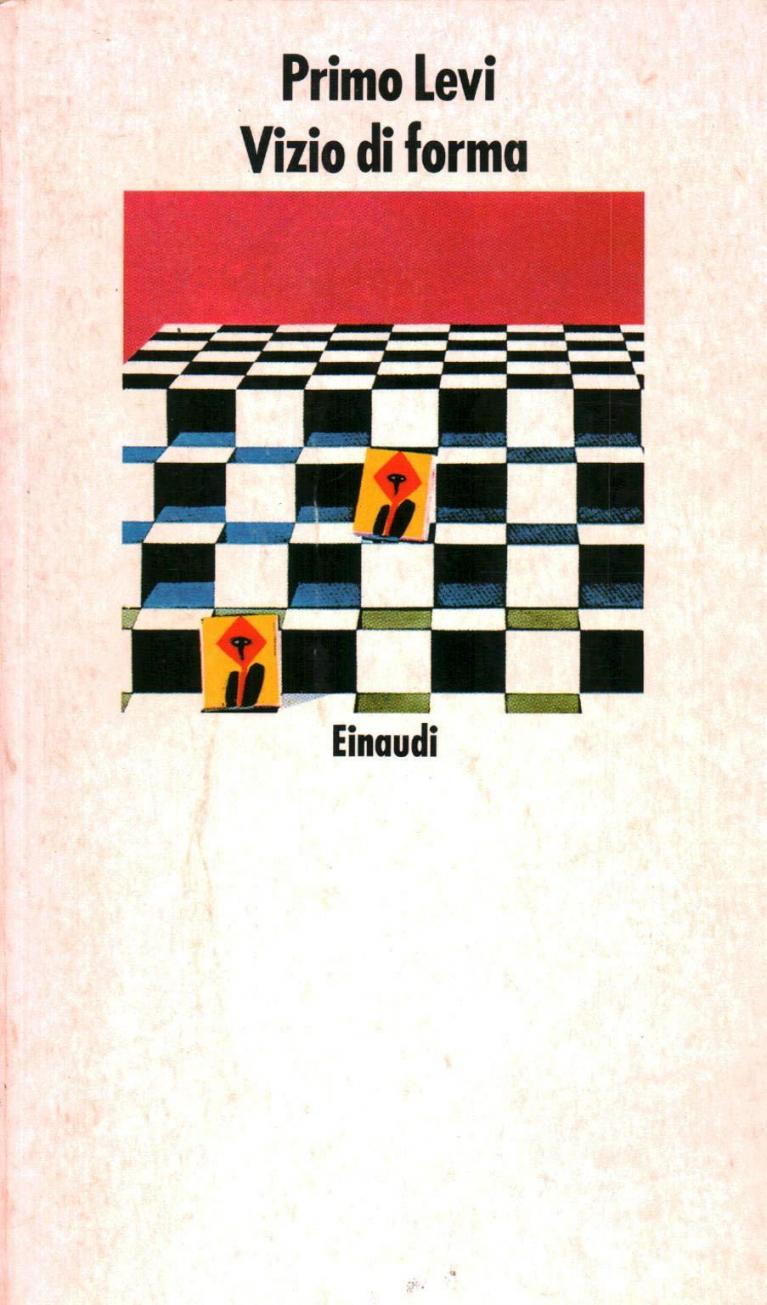
Il “meticciato” fra i mestieri di chimico e di scrittore troverà la sua espressione più alta nelle pagine di Il sistema periodico, avventure del “tecnico” alle prese con gli elementi della tavola di Mendeleev, libro che Calvino salutò come “un nuovo ponte fra le due culture”. Nel ricordare l’amico scrittore da poco scomparso nel settembre del 1985, Levi insiste sulla comunanza dei progetti, sull’idea condivisa “di una letteratura mediatrice, rivelatrice, a cavallo fra le ‘due culture’, partecipe di entrambe”. Nel centauro Levi, la frangia luminosa dei concetti scientifici convive con la penombra in cui restano attivi gli archetipi dell’inconscio: e la letteratura ne è il crocevia chiaroscurale. Il lavoro razionale e la tecnica dominatrice della materia coabitano con l’immaginario dell’alchimista che trae lezioni di psicologia umana dai piani misteriosi delle sostanze. Il soggetto si proietta sulle materie, tende a una valorizzazione immaginaria del fatto materiale; il ricorso al lessico metaforico delle tendenze e dei desideri a proposito delle sostanze risponde al bisogno di partecipazione dell’uomo con la natura di cui la letteratura si fa custode, dopo che l’oggettivismo delle scienze ha scavato un abisso fra l’uomo e il mondo. La letteratura è il luogo in cui si ricompone la frattura fra ragione e immaginazione, fra osservazione empirica e fantasia sognante, fra rigore e invenzione: “letteratura, figlia del mito e del sapere”, ha scritto Michel Serres. L’immagine che il filosofo francese da poco scomparso ha affidato alla sua proposta pedagogica, il Terzo Istruito, si adatta perfettamente all’opera di Levi (e di Calvino). Il Terzo Istruito lavora a una “filosofia della mescolanza”, la sua navigazione va in cerca del “passaggio a Nord Ovest”, del varco in cui i saperi “positivi” comunicano con le tradizioni mitico-religiose: aspira a tessere insieme la verità delle scienze e la pacatezza del giudizio, l’efficacia delle tecniche e la pietas di fronte al male.
Le scelte che scandiscono l’antologia personale di Levi, La ricerca delle radici (1981), sono motivate dalla fiducia negli accostamenti inusuali e talora incongrui, sperimentano quali reazioni possano prodursi “all’interfaccia (per esempio) fra Omero e Darwin, fra Lucrezio e Babel’, fra Conrad il marinaio e Gattermann il chimico prudente”. Ne deriva un esuberante elogio dell’ibridazione e della contaminazione, da cui emergono affinità insospettate fra autori ebraici e poeti dialettali, scrittori di avventura e scienziati: “Qui veramente tutto è possibile, basta pensare a certi matrimoni improbabili e duraturi, a certe amicizie asimmetriche e feconde”. È il frate francescano e medico Rabelais a legittimare con la libertà vitale della sua scrittura, con la mescolanza di registri colti e triviali, anche lo spirito indisciplinato che presiede alle incursioni leviane in territori “stranieri” nei saggi di L’altrui mestiere (1985). È lo spirito impertinente di chi si diverte a varcare i confini, anche quelli disciplinari, a compiere incursioni in territori che altri vorrebbero di propria pertinenza esclusiva. È lo stesso spirito di Libertino Faussone di La chiave a stella (1978), il montatore di tralicci che si esprime con un altro ibrido linguistico, un italiano spoglio infarcito di termini tecnici e dialettali. “Io ho sempre pensato che i ponti è il più bel lavoro che sia: perché si è sicuri che non ne viene male a nessuno, anzi del bene, perché sui ponti passano le strade e senza le strade saremmo ancora come i selvaggi; insomma perché sono come l’incontrario delle frontiere e le frontiere è dove nascono le guerre”. Anche nell’ambito delle scienze, nuovi cammini di ricerca si aprono a chi congiunge ciò che è stato separato. In uno dei suoi ultimi scritti, la recensione a Sette indizi sull’origine della vita di Graham Cairn-Smith, Levi rintraccia il pregio del libro nella comparsa di “una idea nuova, a mezza via fra la chimica e la geologia, e oggi sappiamo quanto feconde sono le ibridazioni fra discipline diverse”.
Abitando il crinale dove s’incontrano le due culture, Levi pontifex è disponibile al nomadismo, al vagabondaggio, alla randonnée, avrebbe detto Serres: può compiere “invasioni di campo”, “bracconaggi in distretti di caccia riservata”, scorribande nei territori delle scienze naturali, dalla zoologia all’astronomia, in quelli della linguistica e della letteratura, “rivisitare le cose della tecnica con l’occhio del letterato, e le lettere con l’occhio del tecnico”. I ponti su cui la scrittura leviana si avventura non mirano solo a scavalcare l’assurdo “crepaccio” fra scienza e letteratura, puntano anche a saldare la spaccatura fra intellettuale e tecnico, fra chi lavora col pensiero e chi lavora con le mani, “una schisi innaturale, non necessaria, nociva, frutto di lontani tabù e della controriforma […]. Non la conoscevano Empedocle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo dell’inconoscibile” (AM).
“Io ibrido lo sono nel profondo, e non è un caso che l’ibridismo tanto profondamente compaia nei miei racconti”, dice Levi in un’intervista del 1982. Il racconto più riuscito di Storie naturali, “Quaestio de centauris”, la cui prima stesura risale al ’61, fantastica di un caos originario conseguente al diluvio, una sorta di zuppa prebiotica, un fango prodigiosamente ricco e fecondo come quello delle terre sovietiche attraversate dopo la liberazione dal Lager e ricordate in La tregua. Nella mescolanza di questo apeiron anassimandreo, la natura è preda di una “fecondità delirante, furibonda”, nella putredine calda albergano tutti i fermenti di quanto il diluvio ha sommerso. Ogni contatto, anche fra specie diverse, anche fra bestie e pietre, genera nuovi esseri, come se la biosfera fosse un immenso campo di sperimentazioni biochimiche. E fra questi ibridi ecco apparire i centauri, dove le pulsioni animalesche, aggressive e sessuali, si risvegliano insieme ai sentimenti umani. L’uso distorto di un farmaco antirigetto, la disfilassi dell’omonimo racconto di Lilìt, produce la caduta delle difese immunitarie, anche di quelle che “un tempo impedivano gli incroci fra specie diverse”; qualunque specie, animale, vegetale o umana, “aveva buone probabilità di dare origine a un ibrido”. Chi può dire se l’infrangersi della barriera fra le specie sia un bene o un male, se dalla “seconda”, la “vera creazione”, non siano da attendersi anche mostri speranzosi, gli hopefulmonsters di cui parlava l’evoluzionista Stephen J. Gould? “Perché non confidare in una nuova selezione millenaria, in un uomo nuovo, rapido e forte come la tigre, longevo come il cedro, prudente come le formiche?”. La chimica, campo delle trasmutazioni della materia, consolida in Levi l’immagine della natura come luogo di intrecci su cui l’evoluzione fa giocare i suoi meticciati, incroci portentosi in cui si annullano non solo le barriere di specie fra umano e animale/vegetale, ma i confini stessi fra meccanico e organico: le tenie secernono poesia, le automobili sviluppano una distinzione in generi sessuali, la Rete telefonica conquista una mente auto-organizzatrice, ecc.
“Altrove”, scrive Levi nella premessa a L’altrui mestiere, mi sono avventurato ad esplorare “i legami trasversali che collegano il mondo della natura con quello della cultura”. L’epistemologo Bruno Latour, ispirato dal pensiero di Serres, ha sostenuto che i fenomeni del nostro tempo, buco dell’ozono, trattamento degli embrioni, virus dell’AIDS, ecc., sono fatti ibridi; abbiamo creduto che la modernità si definisse per la capacità di separare quel che è della natura da quel che è della cultura, superando l’indistinzione dei “primitivi”, ma in realtà “non siamo mai stati moderni” (è il titolo del suo libro, Eleuthera, 1996). L’intera opera di Levi si muove in effetti nei luoghi di contatto e di transizione fra naturale e culturale: non più sospeso fra l’angelo e la bestia, come voleva l’umanesimo classico, l’animale-uomo, ultimo arrivato nel cammino dell’evoluzione, oscilla fra la pura vita e il meccanismo, suggeriscono le pagine di Se questo è un uomo. Ibrida è la situazione del Campo, “il lager è una grande macchina per ridurci a bestie”. Ibrida è la condizione della vittima. La disumanità di Auschwitz non si esprime solo nella riconduzione alla bestialità, involuzione a una forma di vita pre-umana, conosce anche la riduzione dell’individuo ad automa, “pezzo” di cui calcolare la quantità, componente di una struttura meccanica distorta. Auschwitz, “un enorme progetto di ingegneria sociale”, è figlio dell’Occidente tanto quanto le fabbriche di Detroit, ha scritto Zygmunt Bauman, in Modernità e Olocausto (1989): precisione, disciplina e insensibilità militaresca convivono con i criteri della razionalità weberiana del capitalismo, efficienza (minimo dei costi e massimo dei “benefici”, fino al risparmio esasperato del recupero dei “materiali”, cioè delle spoglie delle vittime) e dell’efficacia (mezzi adeguati al fine). Il deportato regredisce allo “stato di natura”, senza che gli sia più concesso ex-sistere, cioè staccarsi dalla condizione di immediatezza rispetto alle esigenze elementari del vivere. Il rischio di venire ridotto a cosa, a inerte macchina automatizzata, sottoposto a “specifiche” come qualunque materiale di laboratorio, è la sorte che attende l’uomo in molti racconti di Storie naturali o di Vizio di forma: programmato fin dall’origine da un comitato di esperti, suggerisce Il sesto giorno, divenuto “sintetico” come nel racconto omonimo. Anche nei carnefici, puri esecutori di ordini meccanici, si è cancellato non solo il senso di umanità ma anche la pietà animale intraspecifica; la logica dell’obbedienza li ha ridotti a ingranaggi di un sistema di cui gestiscono soltanto i mezzi per attuare fini che non controllano.
La natura dell’uomo rimane indefinita, creatura “duplice”, “centauro, uomo fino ai precordi e di qui belva” (SN), sospeso “fra il fango e il cielo, fra il nulla e l’infinito” (AM). E se è vero che l’homo sapiens resta adattabile secondo i giochi dell’evoluzione, in lui l’animalità non si cancella. Come potremmo spiegare l’intolleranza razziale se non tenessimo conto degli atavismi (componente rilevante dell’etologo Levi), delle tracce che del mondo animale persistono nell’uomo civile? Se le frontiere ci rendono feroci è perché resta vivo in noi il bisogno bestiale di difendere il territorio, di considerare ogni estraneo come potenziale nemico. L’ebreo è il bersaglio “naturale”, il capro espiatorio ottimale di chi ha bisogno di marcare il terreno e demarcare i confini, perché il suo essere figura di frontiera, privo di appartenenza e dall’identità non unitaria (non riconducibile a classi, nazioni o stati), lo rende “vischioso”, dice Levi in un intervento sull’intolleranza razziale. I mirabili strumenti che abbiamo ereditato dal percorso dell’evoluzione, il linguaggio e il pensiero concettuale, tendono a ordinare la realtà ed i fatti storici secondo una logica manichea, anch’essa un atavismo radicato nel tempo dell’umanità cacciatrice: è “talmente forte in noi, forse per ragioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l’esigenza di dividere il campo fra ‘noi’ e ‘loro’”, che la bipartizione amico-nemico prevale su tutti gli altri modi di dare ordine al mondo. L’elementare logica agonistica ci induce a ridurre ogni relazione a scontro di opposti, al gioco della guerra da cui usciranno vincitori e vinti, servi e signori. Ma questo “biologico” impulso alla semplificazione, argomentano le pagine di I sommersi e i salvati, “rifugge dalle mezze tinte e dalle complessità: è incline a ridurre il fiume degli accadimenti umani ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro, gli ateniesi e gli spartani, i romani e i cartaginesi”.
L’attenzione al “tra”, al terreno in cui gli opposti si con-fondono, dove germinano ibridazioni e mescolanze, irriducibili ad ogni schematismo dialettico, fa di Levi un pensatore della complessità. Di qui ha origine la sua riflessione più feconda, quella condotta sulla “zona grigia”, la “fascia grigia dei Kapos e dei prigionieri insigniti di un grado”, la “classe ibrida dei prigionieri-funzionari” che formava l’ossatura e il lineamento più inquietante del Lager. Il tema della partecipazione delle vittime stesse all’opera dei carnefici, sviluppato in I sommersi e i salvati (1986), è già nella prefazione al romanzo La notte dei Girondini di Jacob Presser, storia di ebrei olandesi che collaborano alla gestione del campo di Westerbock (Adelphi, 1976, tradotto dallo stesso Levi). Certo, la distinzione fra vittime e persecutori non si cancella, ma lo spazio che li separa non è un deserto, è costellato di “figure turpi, miserevoli o patetiche (talora posseggono le tre qualità a un tempo), che è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una simile prova dovesse ritornare”. Di questa “fauna pittoresca” di scopini, guardie notturne, capi baracca, ecc., in cerca di protezione e privilegi, l’esempio più significativo è quello di Chajm Rumkowsky, decano del ghetto della città polacca di Łodz, in cui diede vita ad una sorta di monarchia assoluta che credeva illuminata. Figura ingenua ed assetata di potere, zimbello dei nazisti ma convinto di essere un messia e un salvatore, in Rumkowski ci rispecchiamo tutti noi, “poiché l’uomo, dice Thomas Mann, è una creatura confusa”: “la sua ambiguità è la nostra, connaturata, di ibridi impastati di argilla e di spirito”. L’immediata e traumatica esperienza di chi entrava in Lager era scoprire che il nemico peggiore stava fra i propri compagni di sventura, pronti a tutto nella lotta per la sopravvivenza: il nemico non stava sull’altra riva, “era intorno ma anche dentro, il ‘noi’ perdeva i suoi confini”. Nel finale di alcune poesie degli anni Ottanta, come Partigia (1981) e Sidereus nuncius (1984), il rifiuto delle rigide opposizioni giunge fino ad annullare ogni dualismo, o meglio a ritrovare il conflitto non fra gli individui ma all’interno di “ognuno”, pronome indefinito ad indicare l’umanità intera: “Ognuno è nemico di ognuno, / spaccato ognuno dalla sua propria frontiera, / la mano destra nemica della sinistra”.
Anche l’indagine di Levi sui campi di sterminio procede sulla soglia, oscilla fra storia e memoria, fra verità oggettiva e testimonianza personale. Spiegava l’etnologa Germaine Tillion, deportata nel Lager di Ravensbrück di cui ha ricostruito la storia (Fazi, 2012), che non si tratta, soprattutto quando si affrontano i drammi del mondo, di scegliere fra ragione e passione, semmai di criticare e completare l’una mediante l’altra. Bisogna saper coniugare “la grande luce bianca dell’indagine storica, che illumina da ogni parte i rilievi e i colori, con il raggio oscuro dell’esperienza che attraversa lo spessore della materia. Non la sola ragione, non la passione sola, ma l’una e l’altra insieme, che uniscono i loro insufficienti chiarori per esplorare questo abisso ignoto, la sventura degli altri”.







