Diario 5 / Rumori nella cassa toracica
La notte di lunedì non ho chiuso occhio. Sentivo un rumore appena fuori dalla stanza, un rumore che assomigliava allo scalpiccio di un animale intrappolato. All’inizio non capivo da dove provenisse, pensavo alle fronde di qualche pianta in giardino. Ma no, il rumore era più vicino. Col passare dei minuti ho cominciato a sospettare che l’animale si nascondesse in un’intercapedine del muro. Ho cercato di immaginare che animale fosse e ho subito pensato a un topo. Ma da queste parti topi non se ne sono mai visti. Solo una volta mia moglie ha avuto l’impressione di averne adocchiato uno in giardino. Ma non era sicura che fosse un topo. Poteva essere un merlo. A volte i merli, quando sono in cerca di cibo, vorticano tra le foglie morte. In ogni caso quella volta ho piazzato delle esche in giardino, ma le esche sono rimaste intatte. Se la bestia intrappolata nel muro non era un topo, allora cos’era?
La casa in cui vivo si trova in un quartiere in cui a ogni ora del giorno e della notte risuonano degli allarmi. Nella quasi totalità dei casi gli allarmi risuonano a vuoto, e la gente li lascia risuonare perché ormai sa che si tratta di falsi allarmi. Perciò dovrei dire che nel quartiere in cui vivo risuonano in continuazione dei falsi allarmi. Nella ricerca del più benevolo silenzio ho pensato che il rumore proveniente dal muro non fosse causato da un animale intrappolato, ma fosse la pulsazione che resta nell’aria quando smette di risuonare un allarme, uno di questi allarmi dal suono algido e violento che risuonano per niente. Dopo qualche ora il rumore è cessato.
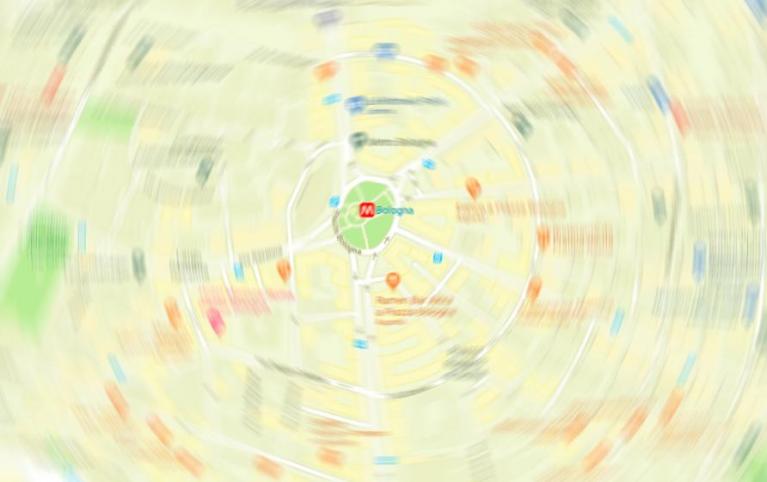
Tuttavia, quando ho creduto che ci fosse finalmente il silenzio giusto per dormire, un altro rumore è sopraggiunto a tormentarmi. Voltandomi sul fianco sinistro ho cominciato a sentire il rimbombo del mio cuore. Il suono era in tutto e per tutto simile al rumore dell’animale intrappolato. Circa un anno fa ho fatto una visita cardiologica durante la quale mi sono stati riscontrati una valvola difettosa e una lieve ectasia della radice aortica. I pareri medici sul grado di allarme che queste due cose dovrebbero procurarmi sono stati contrastanti. Così da allora, quando percepisco le pulsazioni del mio cuore, ho l’impressione che risuonino invano, come lo scalpiccio dell’animale nel muro, e come gli allarmi nel quartiere.
Sono rinchiuso in casa da marzo. Durante tutto questo tempo sono uscito al massimo un paio di volte alla settimana. A chi sto togliendo il sonno?

Una delle poche ragioni per cui esco di casa è la corsa. Ma da quando mi è stato diagnosticato il doppio problema alla valvola e alla radice aortica, devo rispettare un limite ridicolo di frequenza cardiaca massima sotto sforzo, un limite che di fatto mi impedisce di correre e che corrisponde a un’andatura molto blanda, meglio se alternata con delle camminate. Corro da quindici anni, la massima distanza che ho raggiunto è stata di ventuno chilometri, il corrispettivo di una mezza maratona. Ma non ho mai partecipato a una gara, neppure a una corsa non competitiva. Correre per me è un piacere del tutto privato, una solenne immersione nei recessi della mente.
Quando nel marzo di quest’anno è entrato in vigore il divieto di corsa per tutti (me incluso, a cui – come dicevo – era già stato, per altri motivi, quasi del tutto vietato) è come se mi avessero vietato, oltre che di correre, anche di pensare. È come se un intransigente gendarme si fosse impiantato nella mia testa per verificare che l’attività del mio cervello fosse ridotta alle funzioni essenziali, che non eccedesse in esecrabili occupazioni di natura speculativa. Ma poi, dopo due mesi, il divieto è stato rimosso, e la ciclabile sul fiume in cui di solito vado a correre è diventata l’area più affollata di Roma. In quei giorni la ciclabile era così affollata da togliermi il piacere di essere tornato dopo due mesi a correre (o meglio, a corricchiare), era così affollata da impedirmi non solo di correre, ma anche di immergermi nei pensieri. In quei giorni correvano tutti, era una specie di festa per la ritrovata libertà di poter correre. Ho pensato che se il divieto avesse riguardato lo studio della filosofia, in quei giorni la città si sarebbe riempita di improvvisati pensatori della domenica. Adesso che invece siamo a luglio la ciclabile è tornata ad avere il suo aspetto di sempre, l’aspetto di un luogo spopolato, riservato a pochi cultori, una specie di ombrosa e disabitata accademia di Atene.
Cos’è l’estate? Si è sempre approssimativi nella definizione delle cose. Per la maggior parte delle persone che conosco l’estate è una stagione felice. Per me non è felice né infelice. Per me è una stagione innaturalmente calma.

Se si prende una mappa di Roma e si osserva il quartiere Nomentano, assumendo come riferimenti il triangolo che ha per vertici Villa Torlonia, Villa Blanc e la stazione Tiburtina, si ha l’impressione di assistere al movimento vorticoso di un gorgo di strade, un mulinello che ha come epicentro piazza Bologna. È soprattutto questo gorgo che mi ha fatto venire voglia di andare a passeggiare per quelle strade, andare il venerdì mattina con la scusa di un appuntamento che avevo alle undici, andare alle dieci anziché alle undici proprio per percorrere quelle linee concentriche, per bighellonare in quell’abisso a forma di cono, sforzandomi di non scivolare verso l’epicentro del gorgo, ossia verso piazza Bologna, come invece fanno i pescatori norvegesi di Edgar Allan Poe nella Discesa nel Maelström. Ma in quel vortice di strade, in quel Maelström nomentano, ho trovato nient’altro che l’innaturale calma della stagione, e quel certo tipo di palazzine che sorgono da queste parti, quel tipo di palazzine eminentemente romane, dalle forme dolci, che assomigliano a succulente torte al limone. Quelle palazzine mi piacciono così tanto, soprattutto d’estate, quando i loro contorni dalle tinte zuccherine si appiccicano al blu profondo del cielo in un modo ostinato che sembra non vogliano distaccarsene più. Oltre alle palazzine però, non ho visto altro: solo una donna anziana con la busta della spesa che mi ha chiesto di aiutarla a scendere il gradino del marciapiede, un’altra donna seduta in macchina che suonava forsennatamente il clacson, un vecchio con un paio di sandali da cui spuntavano due ciuffi di peli bianchi, e una ragazza vestita di bianco, dello stesso bianco dei peli del vecchio coi sandali.

Ho guardato in tv un documentario sulla vita di un attore americano morto qualche anno fa in circostanze che si definiscono tragiche, il che presuppone che si possa morire anche in circostanze non tragiche. Nel documentario si racconta che l’attore all’età di sedici anni interpretò il ruolo di un uomo di sessantatré anni in modo del tutto credibile. Si trattava di una specie di recita scolastica, e si dice che coloro che assistettero alla recita tutti rimasero a bocca aperta. Credere di avere sessantatré anni a sedici anni è una circostanza tragica. Ma credere di avere sedici anni a sessantatré lo è ancora di più. In entrambi i casi però di solito non si muore. Il problema riguarda lo sfasamento, ossia vivere per lunghi momenti della propria vita credendo di essere qualcosa che non si è, o perlomeno qualcosa di molto lontano da ciò che effettivamente si è. In questi casi, se si muore, bisognerebbe dire che si è morti in circostanze sfasate. Ora, vivere un’intera vita nello sfasamento è sicuramente tragico. Diceva Rousseau: “Amerei la compagnia quant’altri mai, se non fossi certo di mostrarmi in essa non soltanto dal mio lato peggiore, ma del tutto diverso da quello che sono”.
Leggi anche:







