Carlo Formenti. Elettori / consumatori / Finanza, populismo e stupidità
Con La variante populista (2016) la riflessione di Carlo Formenti si sposta dall’analisi delle condizioni che hanno reso possibile l’avvento dell’economia digitale allo studio dei processi politici innescati dalle trasformazioni strutturali e tecno-organizzative del tardo capitalismo. Al centro di tale tragica trasformazione Formenti pone l’immane processo di finanziarizzazione che non rappresenta, come alcuni sostengono, una fase finale dell’accumulazione capitalistica, bensì, sulla scia del ragionamento di Arrighi, una tendenza ciclica che serve a rilanciare la speculazione assicurando maggiori introiti alle forze che un tempo guidavano l’internazionalizzazione fordista e che oggi dominano la globalizzazione. Questa classe capitalistica transnazionale è composta da “detentori di grandi patrimoni mobiliari e immobiliari, top manager, finanzieri e uomini politici di tutti i maggiori partiti tradizionali”, insieme rappresentano un “blocco sociale numericamente esiguo” dall’immenso potere e dalla crescente capacità di condizionamento delle politiche nazionali. Secondo Formenti gli obiettivi di massima perseguiti da questa nuova super élite sono: contenere e ridurre i salari reali; inasprire i tempi e i ritmi di lavoro nelle fabbriche e negli uffici; rinsaldare la disciplina e le gerarchie nella società e nelle aziende, demolire il welfare e i diritti sociali conquistati dai lavoratori nel corso del novecento. Lo strumento attraverso cui è possibile realizzare tali obiettivi è la finanza, che l’autore considera come una vera e propria “rivoluzione culturale” perché capace di trasformare la mentalità individuale e collettiva.
La finanziarizzazione dell’economia è descritta come un cambiamento radicale nella struttura del mercato e dei consumi. Le imprese non si concentrano più sulla produzione materiale e immateriale di merci, ma trovano molto più facile aumentare i propri guadagni attraverso l’equivalente astratto di tutte le transazioni, ovvero la moneta, che rappresenta pertanto la super-merce capace di generare profitti e al contempo di tagliare i costi produttivi, distributivi, promozionali ecc. L’impresa stessa non è più un “dispositivo” di produzione ma un “portafoglio di attività” che assicura livelli crescenti di “rendimento” agli investitori. L’epitome di tale processo di trasformazione è rappresentata dalla aziende della Silicon Valley, che non solo rendono più evanescente il rapporto tra capitale e lavoro, ma producono servizi, innovazioni, app che amplificano e accelerano il processo di polarizzazione tra le classi sociali, lo sgretolamento dei ceti medi e la frammentazione delle forme di lavoro sempre più precarizzate e sempre meno centrali nella definizione delle identità sociali. La guerra che secondo Gallino è stata dichiarata dai ricchi contro i poveri è forse il punto più controverso della questione. Non perché i ricchi per definizione dovrebbero operare per un mondo con meno poveri, ma perché, come anche Formenti sottolinea insieme ad altri autori che parlano palesemente di psicopatologia, si tratta di un meccanismo di stupidità che rasenta la follia e che genera un circolo vizioso in cui la disuguaglianza produce un aumento esponenziale della disuguaglianza.
Questa è la Wall-Mart Economy che Formenti riprende da Arrighi ma che è stata spiegata nei dettagli anche da altri studiosi americani, intenti a dimostrare che sfruttamento e de-sindacalizzazione imposta dalla corporation mira a “vampirizzare, sul lungo periodo, l’economia delle periferie americane”. In altri termini Wal-Mart ha innescato una spirale che induce gli operai americani impoveriti ad acquistare merci low-cost prodotte nel sud est asiatico, il cui consumo a sua volta incrementa l’impoverimento e la precarizzazione dei lavoratori delle periferie. L’incrocio tra la deregulation imposta dalla globalizzazione e dalle leve dell’economia del debito produce effetti che, nell’ottica di un certo determinismo tecnologico, possono essere considerati alla stregua di feedback positivi, ovvero effetti di retroazione che al posto di riequilibrare il sistema (come invece farebbero i feedback negativi), lo sbilanciano spingendolo verso il punto di catastrofe. Allo stesso modo i processi innescati dall’economia del debito impoveriscono gli stati, che per risanare i buchi di bilancio – determinati inoltre dalle politiche neoliberaliste di detassazione dei ceti più agiati – tentano di risanare il deficit indebitandosi. In tal modo “i super ricchi ottengono un duplice beneficio nel prestare soldi al governo, mentre noi cittadini paghiamo di tasca nostra sia gli effetti sul debito che gli effetti della crisi fiscale”.
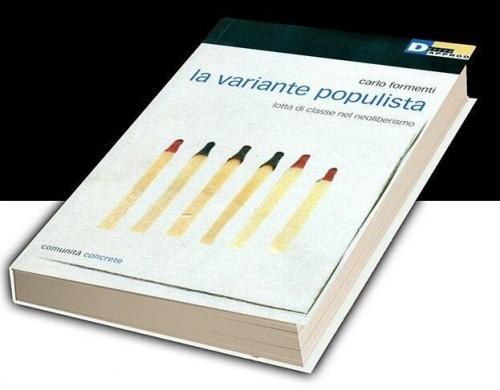
Alcuni temi affrontati dal libro di Formenti sono presenti nel film Io, Daniel Blake di Ken Loach (2016). Il combinato disposto tra una burocrazie sempre più oppressiva e gli interessi speculativi del capitale globale, si trasforma in un vero meccanismo diabolico che sfibra lentamente la resistenza del protagonista, fino al punto da eliminarlo fisicamente. Il lavoratore che tenta di ricostruire un senso di comunità e di solidarietà attraverso reti sociali informali, viene pertanto isolato, atomizzato e schiacciato dalla razionalità astratta del sistema che risponde sempre più alle esigenze del privato, sacrificando la dimensione dei diritti. Anche se attraverso un medium diverso, Loach condivide alcuni temi della critica al regime tecnocratico, la cui logica di funzionamento “neutrale” serve piuttosto a occultare i tagli del welfare e la soppressione dei diritti.
Il legame tra la “macchina” e le forme di reazione psicosomatica alle sue istanze di dominio, ovvero il populismo dei nostri tempi, viene considerato da Formenti come una sorta di effetto collaterale dei processi di destrutturazione, privatizzazione e de-ideologizzazione imposti dall’ideologia ordoliberista. In tal modo, quando passa all’analisi precipua del fenomeno, l’autore deve rispettare questo schema di analisi e considerare il populismo come una conseguenza, piuttosto che un brodo culturale che caratterizza la politica postmoderna. In tal modo la deriva postdemocratica ha trasformato la struttura stessa dei partiti dalla forma dei “cerchi concentrici” a quella dell’ellisse, in cui il leader politico si colloca in uno dei fuochi e irradia con il suo carisma gli elementi ormai destrutturati dell’organizzazione. Da un lato dunque la “crisi pupulista” è conseguenza della destrutturazione imposta dalla globalizzazione, dall’altro essa rappresenta la nuova struttura di potere nata dall’implosione della politica tradizionale, basata sull’opposizione destra/sinistra, alla quale viene sostituita la coppia popolo versus élite.
Tuttavia la critica al neoliberismo inteso da Paul Mason come (2016) immensa macchina di privatizzazione delle cose (“a machine privatizing stuff”), rischia di risultare spuntata se non si prende in considerazione la capacità di auto-occultamento di tale ideologia attraverso complessi espedienti culturali e comunicativi. È qui che diventa centrale l’uso della cultura e della comunicazione come strumenti che mirano a colmare la distanza sempre più abissale tra le classi sociali, sostenendo il legame sociale e impedendo ai conflitti di riemergere violentemente. Citando un articolo di Loris Caruso, Formenti sottolinea come la rottura populista (ovvero democratica), si caratterizzi, oltre che per l’opposizione tra un Noi e un Loro e tra élite e popolo, per “l’assenza di un’analisi sulla composizione di classe interna al Noi, per cui il conflitto è giocato sulle rappresentazioni politiche e simboliche più che su quello socio-economico”. Quel “simbolico” gettato all’interno di un discorso sulla composizione socio-economica di classe è in realtà il punto nevralgico su cui l’autore insiste per poche pagine, ad esempio esaminando lo svuotamento del lessico politico del populista, ma che a ben vedere meriterebbe una trattazione ben più sistematica.
Più che un mero svuotamento, il linguaggio del populismo tenta difatti di ripristinare una legame sociale e simbolico proprio lì dove la destrutturazione indotta dalla tecnologia e dal capitale ha sortito gli effetti più devastanti sulle comunità. Il populismo tenta di ricostruire disperatamente questo atroce senso di comunità all’interno della strada per il nessundove (direbbero i Talking Heads) asfaltata dal neoliberismo. Ma il liberismo stesso, nella sua fase più recente, tende a camuffarsi da populismo, grazie sostanzialmente alla terza via e alle sue strategie comunicative e culturali che tendono a ibridare elementi dei programmi di destra e sinistra. Dunque il populismo è una reazione drastica alla tecnocrazia e all’ibridazione della politica postmoderna, nonché alla triangolazione usata da Blair prima e da Cameron poi per saccheggiare i programmi della controparte, ma esso stesso procede nella medesima direzione del suo “nemico”, deideologizzando la dialettica politica e smantellando le identità delle classi sociali.
Nel Corso in "Political Communication" da me tenuto presso la Franklin University di Lugano, alcuni studenti si interrogavano sull’attualità e sull’utilità delle tesi sostenute negli anni settanta da Daniel Bell (1973) e da Alain Touraine, fondatori della riflessione sulla società postindustriale. In particolare sfuggiva loro la relazione tra quel tipo di società modificata dall’innovazione tecnologica, la centralità della conoscenza teoretica, l’affermazione di un design della società che caratterizza la visione tecnocratica e l’annosa “epidemia” di populismo che si diffonde oggi nel mondo. Quei due libri sono per me indispensabili per cogliere il senso della contrapposizione ideologica (vera o presunta) tra tecnocrazia e populismo. Dal momento in cui la tecnocrazia, creata dal processo di informatizzazione della società, incontra la deregulation della globalizzazione, diventa necessaria una nuova modalità comunicativa che è capace di rivestire la durezza del regime tecnocratico basato sul valore della “razionalità impersonale” con una patina cultural-emozionale che rende più umano e tollerabile il volto del leader politico. Come ho sostenuto altrove, il successo della terza via giddensiana non è tanto dovuto alla deideologizzazione (in atto anche in altri contesti) ma dal ribaltamento della relazione tra politico ed elettorato grazie alla forma del brand.

All’epoca della post-verità le argomentazioni razionali della vecchia politica cedono il passo a una sorta di design delle esperienze che si fonda sulla trasformazione del politico come brand nonché sulla trasformazione del programma in una superficie elastica e modulare capace di incorporare le istanze che vengono dall’elettorato (“Il programma è nella mente dell’elettore” dicono gli spin doctor di Clinton a Tony Blair, nel formidabile film I due presidenti). Questo “nuovo elettore”, sempre più simile al “nuovo consumatore”, viene posto al centro dell’agone politico come punto di riferimento assoluto (almeno nella retorica della comunicazione) di ogni iniziativa. Dunque da un lato il populismo è una reazione – Formenti discute di Sanders e Trump come due populismi da sinistra e da destra che reagiscono alla tecnocrazia e globalizzazione, dall’altro invece il populismo ispira persino le posizioni di centro e/o della terza via (come quello “dolce” proposta da Matteo Renzi). Del resto, nonostante la stampa americana abbia insistito sull’opposizione tra Trump e Clinton come una lotta tra populismo e tecnocrazia, in realtà entrambi rappresentano dosi o miscele diverse di populismo (il primo più programmatico l’altro più comunicativo).
Questa capacità melliflua e proteiforme del populismo di modificarsi a seconda di chi lo interpreta è una questione precipuamente culturale. Ben al di là dei ragionamenti di Alain Touraine sul rapporto tra tecnocrazia e forme di dominazione culturale agli albori della società postindustriale, andrebbe oggi esaminata la centralità della cultura, che rappresenta forse l’unico ambiente condiviso in una società che è sempre più spaccata o polarizzata dai processi di diseguaglianza innescati dalla globalizzazione. Laddove l’economia divide, la cultura continua a unire, anche se forse solo nella modalità (moderna) dell’imitazione delle élite da parte delle masse, o nello sfruttamento supplementare (postmoderno) da parte delle classi più agiate delle tradizioni e della presunta autenticità dei ceti popolari, secondo una “mentalità neototalitaria” che, alla luce dei fatti attuali, vale forse la pena di riprendere e rilanciare.









