Guerre contro il futuro: René Girard
“Albeggiava, e il villaggio era ancora immerso nel sonno. Nessuno aveva chiuso le imposte delle finestre o sprangato le porte. Non si udiva il benché minimo umore. Quando la nebbia iniziò a diradare, dai campi intorno al paese emersero delle figure spettrali, così all’improvviso che pareva fossero appena affiorate dal suolo. Si avvicinarono da tutti i lati e strinsero il cerchio. Il comandante diede l’ordine di attaccare”. Il copione del massacro degli abitanti di un villaggio, donne bambini uomini e vecchi – descritto da Wolfgang Sofsky nel suo Saggio sulla violenza – non concede troppe digressioni, ogni volta si ripete come l’assalto all’accampamento indiano codificato dall’epopea western.
Il massacro del villaggio – in Mali come in Ruanda, in Slavonia come in Bosnia – è ogni volta il segnale che dà il via alla mattanza. L’efferatezza dell’eccidio suscita il terrore che induce l’escalation della violenza, produce le vittime in nome delle quali d’ora in poi si combatte. Dopo l’eccidio si contano i corpi, si piangono i defunti, si impugnano le armi per vendicarli.
La guerra delle vittime di loro si ciba, attraverso loro si racconta. Ecco “il dolore delle vittime”, “il peso politico delle vittime”, “i desideri di vendetta delle vittime”, “la memoria delle vittime”. Ma se tutti sono vittime, la vittima, un capro espiatorio che possa salvare l’intera comunità dall’annientamento, non esiste. Il meccanismo sacrificale non funziona più, il numero delle vittime non risulta significativo, la spirale delle violenze può andare avanti all’infinito: “Di fronte a questa situazione, si può pensare che gli uomini saranno spesso tentati di restituire al rimedio tradizionale la sua efficacia perduta aumentando sempre più le dosi, immolando sempre più vittime in olocausti che vorrebbero essere sempre sacrificali ma che lo sono sempre meno” afferma René Girard in Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo (1983). Questo è stato molto evidente nel caso del conflitto inter-jugoslavo: le vittime civili erano trofei esibiti dai politici, i morti di Vukovar sembrava non fossero mai abbastanza se il fine era quello di convincere la comunità internazionale della necessità di riconoscere il neo-stato croato, a Srebrenica è seguito l’intervento della Nato. E il numero crescente dei morti civili ucraini è ancora un mezzo per potenziare la legittimità del conflitto in corso.

Quando ogni legalità svanisce, la vendetta privata può produrre una escalation interminabile, il meccanismo gira a vuoto. Non arriva mai il momento della pacificazione collettiva. Nemmeno il luogo della tomba, spesso una anonima fossa comune, riconcilia i vivi e i morti. Anzi, diventa il luogo da cui si diramano nuove violenze. Nel caso del conflitto inter-jugoslavo la costruzione del meccanismo vittimario è stata molto evidente; a volte è avvenuta in modo quasi spontaneo, favorita dalla struttura autoritario-familista della gerarchia delle nazionalità maggiori e minori, in altre occasioni è stata guidata “dall’alto”. Si sente vittima la Slovenia, in Croazia la vittimologia diventa ideologia ufficiale, e anche la Serbia “inventa” una tradizione di vittima.
È un circolo vizioso degli antichi, dice René Girard, che per noi, moderni e privilegiati, è sostituito dal sistema giudiziario – così anche l’esercizio della rappresaglia è affidato a un’autorità suprema preposta a ciò. Forse è possibile inventare nuovi riti di riconciliazione – un’esperienza coraggiosa di incontro tra vittime e carnefici è quella del Sud-Africa –, misure che prevengano la vendetta, riparino quanto è avvenuto.
Girard non propone il ritorno, storicamente impossibile, al meccanismo sacrificale, ma una rinuncia consapevole e totale alla violenza. Per Girard nulla di tutto ciò riesce però a essere davvero efficace. Lo sviluppo scientifico e tecnologico, legato alla desacralizzazione della natura, in un mondo in cui i meccanismi vittimari non valgono più, pone l’umanità davanti a un dilemma: o gli uomini si riconciliano per sempre, “senza intermediari sacrificali”, oppure devono rassegnarsi all’estinzione. Rinunciare alla violenza si imporrà, sostiene Girard, “come condizione sine qua non di sopravvivenza per l’umanità stessa e per ciascuno di noi”.
Questo significa anche abbandonare l’idea di comunità umane chiuse in se stesse: le ideologie che si sono succedute e combattute nel corso del ventesimo secolo sono fondate sempre su una sorta di razionalizzazione mostruosa, ancorché inefficace, dei meccanismi vittimari. In “Gli stereotipi della persecuzione”, contenuto in Il capro espiatorio (1987), Girard descrive il criterio di selezione vittimaria proprio di ogni società, ma transculturale nel suo principio. “Non c’è, quasi, società che non sottometta le proprie minoranze, i propri gruppi mal integrati o anche semplicemente distinti, a certe forme di discriminazione se non di persecuzione”. È l’ebreo la protovittima con la quale identificarsi – si sentono “ebrei” della Jugoslavia, i serbi, come se le vicende della prima e della seconda guerra mondiale avessero impresso su di loro stimmate eterne.
Stabilita l’esistenza di una crisi politica o sociale, individuato un episodio di violenza, è possibile, a partire da una testimonianza orale o scritta, potremmo aggiungere mediale, rintracciare gli stereotipi ricorrenti nella sua ricostruzione. Mettendo a confronto i testi di persecuzione che propone Girard con i testi di comizi politici, manuali scolastici, articoli di giornale, telegiornali, incontriamo il “vocabolario dei pregiudizi” che così ardentemente trasformano l’Altro in Straniero, lo straniero in apolide, l’amico in nemico, tutto ciò che è vicino in lontano. Perché, conclude Girard, ciò che si rimprovera alle minoranze, non è tanto la loro differenza specifica, quanto invece il “non differenziarsi in modo opportuno, al limite di non differenziarsi affatto”. La creolizzazione della popolazione globale incita i persecutori che temono l’indifferenziazione. “Non è mai la loro differenza specifica che si rimprovera alle minoranze religiose, etniche, nazionali; si rimprovera loro di non differenziarsi in modo opportuno, al limite di non differenziarsi affatto”. È il narcisismo delle piccole differenze di cui parla Freud in Il disagio nella civiltà (1929-1930), che ben si adatta a descrivere la situazione contemporanea di meticciato globale dove l’eccesso di rivalità tra diverse culture risulta spesso pericoloso.
Io non cerco di circoscrivere esattamente il campo della persecuzione; non cerco di determinare con precisione dove comincia e dove finisce l’ingiustizia. Contrariamente a quello che pensano alcuni, dare buoni o cattivi voti all’ordine sociale e culturale non mi interessa. La mia sola preoccupazione è quella di dimostrare l’esistenza di uno schema transculturale della violenza collettiva, facilmente delineabile. L’esistenza di uno schema è una cosa, il fatto che questo o quell’avvenimento determinato vi si inserisca è un’altra cosa. Talvolta è difficile decidere, ma la dimostrazione cui tendo non ne è intaccata. Quando si esita a riconoscere uno stereotipo persecutorio in questo o quell’aspetto particolare di un determinato avvenimento, non bisogna cercare di risolvere il problema soltanto al livello di quell’unico aspetto, isolato dal suo contesto, ma bisogna domandarsi se accanto a esso si presentino gli altri stereotipi.
Faccio due esempi. La maggior parte degli storici pensa che la monarchia francese non sia senza responsabilità nella Rivoluzione del 1789. L’esecuzione di Maria Antonietta è dunque esterna al nostro schema? La regina appartiene a diverse categorie vittimarie preferenziali; non è soltanto regina, è anche straniera. La sua origine austriaca ritorna continuamente nelle accuse popolari. Il tribunale che la condanna è fortemente influenzato dalla folla parigina. Il nostro primo stereotipo è anch’esso presente: si ritrovano nella Rivoluzione tutti gli aspetti caratteristici delle grandi crisi che favoriscono le persecuzioni collettive. Gli storici non hanno certo l’abitudine di trattare i dati della Rivoluzione francese alla stregua di elementi stereotipati di un solo e identico schema persecutorio. Non pretendo che questo modo di pensare debba sostituirsi dappertutto alle nostre idee sulla Rivoluzione francese. Esso tuttavia getta una luce interessante su un’accusa spesso passata sotto silenzio, ma che figura esplicitamente nel processo alla regina: quella di aver commesso un incesto con suo figlio.
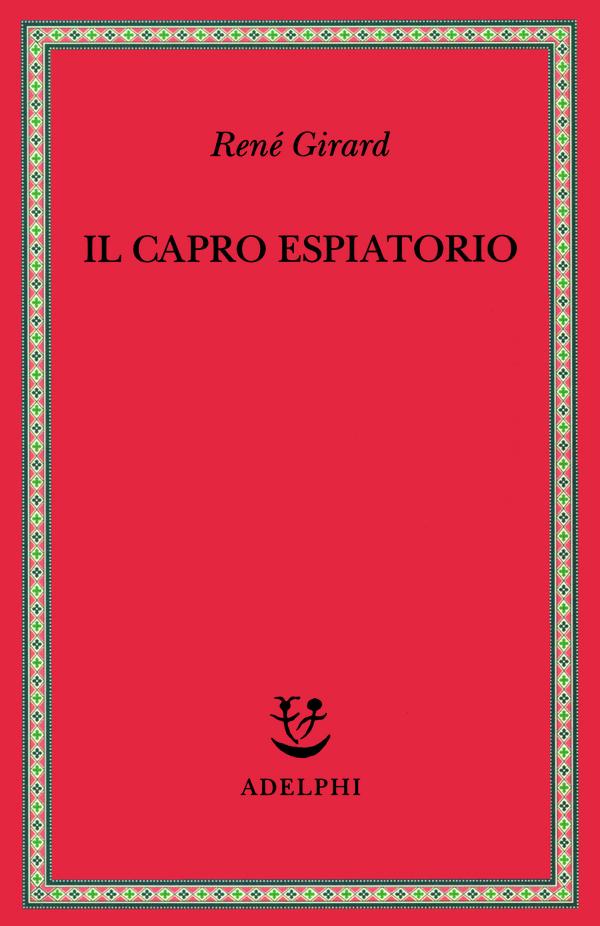
Prendiamo adesso per esempio un altro condannato: egli ha realmente commesso l’atto che scatena contro di lui le violenze della folla. Il Negro ha realmente violentato una donna bianca. La violenza collettiva cessa di essere arbitraria nel senso più evidente del termine. Essa sanziona realmente l’atto che pretende di sanzionare. Si potrebbe immaginare, in queste condizioni, che non vi siano distorsioni persecutorie e che la presenza di stereotipi della persecuzione non abbia più il significato che le ho dato. In realtà le distorsioni persecutorie sono presenti e non sono incompatibili con la verità letterale dell’accusa. La rappresentazione dei persecutori resta irrazionale. Essa inverte il rapporto tra la situazione globale della società e la trasgressione individuale. Se tra i due livelli esiste un legame di causa o di motivazione, esso non può procedere dal collettivo all’individuale. La mentalità persecutoria si muove in senso contrario. Invece di vedere nel microcosmo individuale un riflesso o un’imitazione del livello globale, essa cerca nell’individuo la causa e l’origine di tutto ciò che la ferisce. Reale o no, la responsabilità delle vittime subisce lo stesso ingrandimento fantastico. Per quello che ci interessa, insomma, non c’è molta differenza tra il caso di Maria Antonietta e quello del negro perseguitato.
Esiste un rapporto stretto, lo abbiamo visto, tra i due primi stereotipi. Allo scopo di riferire alle vittime l’“indifferenziazione” della crisi le si accusa di crimini “indifferenziatori”. Ma in realtà sono i loro segni vittimari che designano queste vittime per la persecuzione. Qual è il rapporto di questo terzo stereotipo con gli altri due? A prima vista i segni vittimari sono puramente differenziali. Ma anche i segni culturali lo sono. Devono esserci, dunque, due modi di differenziare, due tipi di differenze.
Non vi è cultura all’interno della quale ciascuno non si senta “differente” dagli altri e non giudichi legittime e necessarie le differenze. Lungi dall’essere radicale e progressista, l’esaltazione contemporanea della differenza non è che l’espressione astratta di una maniera di vedere comune a tutte le culture. In ogni individuo esiste una tendenza a sentirsi “più differente” di ogni altro rispetto agli altri e parallelamente, in ogni cultura, una tendenza a ritenere se stessa non solo come differente dalle altre, ma come la più differente di tutte, poiché ogni cultura alimenta negli individui che la compongono questo sentimento di “differenza”.
I segni di selezione vittimaria non manifestano la differenza in seno al sistema, ma la differenza fuori dal sistema, la possibilità per il sistema di differenziarsi dalla propria differenza, cioè di non differenziarsi affatto, di cessare di esistere in quanto sistema.
Lo si vede bene per le infermità fisiche. Il corpo umano è un sistema di differenze anatomiche. Se l’infermità, anche accidentale, inquieta, è perché dà un’impressione di dinamismo destabilizzante. Sembra minacciare il sistema in quanto tale. Si cerca di circoscriverla, ma non si può; essa sconvolge attorno a sé le differenze, che diventano mostruose, precipitano, si comprimono, si mescolano e, al limite, minacciano di abolirsi. La differenza fuori del sistema è terrificante perché fa intravedere la verità del sistema, la sua relatività, la sua fragilità, la sua mortalità.
Le categorie vittimarie sembrano predisposte ai crimini indifferenziatori. Non è mai la loro differenza specifica che si rimprovera alle minoranze religiose, etniche, nazionali; si rimprovera loro di non differenziarsi in modo opportuno, al limite di non differenziarsi affatto. Gli stranieri sono incapaci di rispettare le “vere” differenze; non hanno buoni costumi o non hanno gusto, secondo i casi; non capiscono bene il differenziale in quanto tale. Barbaros non è chi parla un’altra lingua, ma chi mescola le sole distinzioni veramente significative, quelle della lingua greca. Dappertutto il vocabolario dei pregiudizi tribali, nazionali ecc., esprime l’odio non per la differenza, ma per la sua mancanza. Non è l’altro nomos che si vede nell’altro ma l’anomalia; non è l’altra norma ma l’anormalità; l’infermo si muta in deforme; lo straniero diventa apolide. In Russia non è bene passare per cosmopolita. I meteci scimmiottano tutte le differenze perché non ne hanno. I meccanismi ancestrali si riproducono di generazione in generazione nell’inconsapevolezza della loro riproduzione, spesso d’altronde, bisogna riconoscerlo, a un livello meno letale che nel passato. Ai giorni nostri, per esempio, l’antiamericanismo crede di “differenziarsi” da tutti i pregiudizi precedenti perché adotta tutte le differenze contro il virus indifferenziatore di provenienza esclusivamente americana.
Dovunque sentiamo dire che la “differenza” è perseguitata, ma questo discorso non è necessariamente proprio solo delle vittime, è il sempiterno discorso delle culture, che si fa sempre più astrattamente universale nel rifiuto dell’universale e che non può più presentarsi se non con la maschera ormai indispensabile della lotta contro la persecuzione.
Anche nelle culture più chiuse gli uomini si credono liberi e aperti all’universale; il loro carattere differenziale fa sì che i campi culturali più stretti siano vissuti dall’interno come inesauribili. Tutto ciò che compromette questa illusione ci terrorizza e risveglia in noi la tendenza immemoriale alla persecuzione. Questa tendenza prende sempre le stesse strade, sono sempre gli stessi stereotipi che la attuano, è sempre alla stessa minaccia che risponde. Contrariamente a quello che si ripete intorno a noi, non è mai la differenza che ossessiona i persecutori, ma è sempre il suo indicibile contrario, l’indifferenziazione.
Gli stereotipi della persecuzione sono indissociabili e la maggior parte delle lingue, fatto notevole, non li dissocia. Questo è vero per il latino e per il greco, per esempio, quindi per il francese e per l’italiano che ci obbligano a ricorrere continuamente, nello studio degli stereotipi, a parole imparentate: crise, crisi; crime, crimine; critère, criterio; critique, critica, parole che risalgono tutte alla stessa radice, allo stesso verbo greco, krino, che significa non solo giudicare, distinguere, differenziare, ma accusare e condannare una vittima. Non bisogna mai fidarsi troppo delle etimologie, e io non ragiono mai partendo da esse. Ma il fenomeno è così costante che non credo sia vietato osservarlo. Fa intravedere un rapporto ancora dissimulato tra le persecuzioni collettive e il culturale nel suo insieme. Se questo rapporto esiste, nessun linguista, filosofo o politico lo ha mai spiegato.
Si ringrazia Adelphi Edizioni.
© 1982 Éditions Grasset & Fasquelle
© 1987 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano









