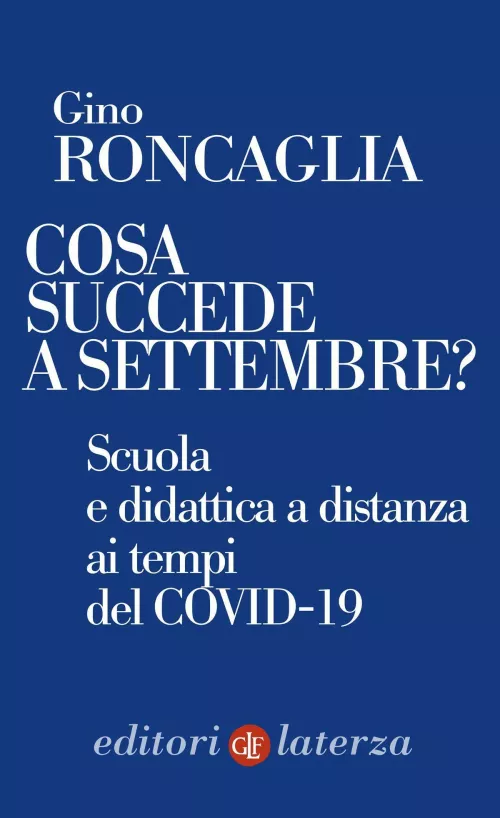Un libro di Gino Roncaglia / Il settembre caldo della scuola digitale
Con Cosa succede a settembre? Scuola e didattica a distanza ai tempi del COVID-19 (Laterza 2020, 74 pp.) Gino Roncaglia si inserisce in un dibattito già ricco tracciando un bilancio dell’esperienza della scuola italiana durante la chiusura e indicando alcune direzioni per il futuro, ed è un contributo che merita attenzione sia per la sua sistematicità, sia perché l’autore è da tempo una delle voci più equilibrate e ascoltate per l’ambito delle tecnologie digitali applicate all’insegnamento-apprendimento (si tratta in realtà di una anticipazione: questo breve scritto entrerà a far parte della nuova edizione, prevista per settembre, dell’Età della frammentazione: cultura del libro e scuola digitale, pubblicato per Laterza nel 2018). Roncaglia considera il COVID-19 uno spartiacque epocale: nel libro si distingue tra scuola del passato, scuola dell’emergenza, scuola della convivenza con il virus (quella ormai alle porte) e scuola del futuro. Se si restringe il campo alla didattica a distanza questo è indubbio: c’è un prima e un dopo. Per la scuola nel suo insieme mi sembra invece che l’assunto sia meno scontato (ma lo stesso Roncaglia ribadisce più volte il carattere provvisorio di quanto scrive, vista la sostanziale incertezza della situazione).
C’è una tendenza antica e ricorrente, tra chi si occupa a diversi livelli di politiche scolastiche (anche all’interno del MIUR), ed è quella di considerare tutto ciò che riguarda il digitale (strumenti, ambienti, metodologie) come una sorta di deus ex machina o di ariete per far breccia nel fortino anacronistico della scuola. Questo naturalmente con differenze anche marcate e a diversi livelli di consapevolezza critica (l’epoca in cui si pensava che bastasse introdurre dispositivi digitali in classe per risolvere pressoché ogni problema è fortunatamente finita, e Roncaglia ha avuto un ruolo non trascurabile in questa presa di coscienza); ma alla fine la convinzione di molti che il digitale debba avere un ruolo dirompente e salvifico non passa, si è rafforzata in questi mesi ed è comprensibile, perché sembra che la scuola non si rinnovi se non quando è sotto assedio. La didattica digitale integrata, che prevede momenti in presenza e a distanza, caratterizzerà a quanto sembra anche la scuola di settembre, ed è giusto che se ne parli. Tuttavia, al netto di emergenze, io credo che sia sbagliato considerare le tecnologie digitali come l’unica leva, o la migliore, per suscitare il cambiamento (qualunque cosa si intenda con questa parola). Per essere chiari, la considero una battaglia di retroguardia.
Si fa spesso notare che anche una penna, una lavagna, un libro o un banco sono tecnologie, a loro tempo innovative: un’opposizione pregiudiziale all’introduzione di strumenti digitali nella scuola è ottusa o dimostra quantomeno scarso senso storico. Se questo è vero, è altrettanto evidente, e Roncaglia lo dice, che le tecnologie non sono tutte uguali: un quaderno non è uno smartphone e una lavagna non è paragonabile a un ambiente di videconferenza. Ho usato e userò ancora un termine generico e a rigore improprio, “digitale”, per intendere tutto ciò che riguarda dispositivi, software, piattaforme che operano attraverso il web; questo perché il digitale non è una tecnologia, ma un ecosistema complesso che contiene al suo interno tecnologie diverse e legate fra loro. Se una penna è una penna, quando utilizziamo un dispositivo digitale è come se tirassimo un filo che si porta dietro tanto altro, e il più di questo “altro”, che ha il potere di influenzare e anche distorcere l’ambiente di apprendimento, è fuori dalla scuola: qualunque tentativo di sceverare (ad esempio vietando l’uso del cellulare in classe, come è stato fatto) si scontra con difficoltà oggettive e più spesso con il buon senso.
Semplificando un discorso ben più articolato, le tecnologie digitali permettono sia di fare meglio (in maniera più efficiente ed efficace) quello che già si fa, sia di fare cose completamente diverse. Nessuno contesta, mi sembra, il fatto che la scuola debba recuperare quanto al primo punto un ritardo poderoso, e che l’esperienza obbligata del digitale sia quantomeno un’occasione da non sprecare; ma neppure da mitizzare. Nei mesi passati grazie alla didattica a distanza è stato possibile garantire la continuità scolastica, ma come nota Roncaglia il modo di fare scuola non è cambiato di molto: tranne eccezioni, si sono fatte le stesse cose con strumenti diversi (lezioni sincrone o registrate, assegnazione di compiti, verifiche e così via). Roncaglia si augura, se non ho frainteso, che l’esperienza emergenziale sia un punto di partenza per realizzare una “scuola del futuro” più moderna, efficace e inclusiva, e questo per lui significa, prima di tutto, introdurre strumenti e metodologie nuove, ridurre la centralità del gruppo classe e pensare a un’organizzazione degli spazi più flessibile e modulare. Non c’è niente in tutto questo che io ritenga sbagliato, ma ho qualche dubbio sulle priorità. In particolare, sono convinto che il punto centrale non debba essere il rinnovamento delle pratiche didattiche tradizionali, che nel complesso continuano a svolgere piuttosto bene il loro compito, pur tra difficoltà che non riguardano tanto i processi, quanto i contenuti e i programmi. Prioritario invece a mio parere è che gli insegnanti sviluppino competenze (reali, e non “scolastiche” in senso deteriore) su cosa significhi e cosa comporti utilizzare tecnologie che fuori dalla scuola sono ormai pervasive, che sappiano cosa stanno utilizzando, per cosa lo vogliono utilizzare e cosa questo utilizzo comporta, vale a dire quali legami ci sono tra una determinata tecnologia e il suo contesto digitale in relazione ai fini; ed è altrettanto prioritario che la scuola si faccia carico, più e meglio di quanto fa ora, di formare gli studenti all’uso consapevole dei nuovi strumenti e delle nuove forme di comunicazione. È un compito enorme, che si lega al tema della cittadinanza. Presuppone che l’aggiornamento della scuola non si traduca in un puro e semplice allineamento con il mondo esterno, e che venga garantito, protetto e ridefinito il suo carattere alternativo e anche antagonistico, non per creare una frattura o una “bolla” dalla quale escano giovani impreparati a tutto, che dovranno fin da subito ricominciare a imparare (anche se parlerei più di addestramento), ma per sviluppare in un ambiente protetto le competenze critiche indispensabili per gestire l’iperconnessione e non subirla. In una parola, l’educazione ai nuovi media viene prima dell’educazione con i nuovi media; si tratta, come scrive Marco Gui, di “costruire un contesto culturale in cui l’innovazione può avere effetti benefici, il che implica una riflessione sui fini desiderabili”.

Per Roncaglia, il problema comune a tutte le attività svolte a distanza in questi mesi è legato alla persistenza di un rapporto asimmetrico tra docente e studente (vale a dire al mantenimento del modello trasmissivo tipico della presenza, con l’insegnante come attore principale e gli studenti che ascoltano in posizione subordinata) e alla scarsa rappresentanza di attività più sofisticate, principalmente di tipo attivo e collaborativo. Ho più di un dubbio su questa impostazione del problema. Mi sembra che la didattica a distanza, pur in una situazione eccezionale, abbia ottenuto i risultati migliori quando gli insegnanti hanno saputo tradurre tecniche e metodi educativi già sperimentati nella didattica in presenza in un canale diverso senza porsi programmaticamente l’obiettivo di fare “qualcosa di nuovo”. Il nuovo è semmai venuto da una rimediazione spontanea e graduale del vecchio: si sono rimodulati, per quanto possibile, i contenuti, sono state utilizzate risorse disponibili in rete e in molti casi si è “capovolta” la didattica senza saperlo. Gli insegnanti di maggior esperienza hanno fatto in sostanza un lavoro pragmatico, improntato al massimo di razionalità ed efficacia possibili. È vero che è stata mantenuta la centralità della lezione, ma se devo giudicare dal mio limitato punto di osservazione, quanto più questa continuità è stata avvertita dagli studenti tanto più è stata apprezzata, anche, ma non solo, come elemento di stabilità rispetto al disorientamento generale: bisognerebbe parlare anche con loro per capire cosa è successo e che insegnamenti ricavarne, e lo si fa troppo poco. Le difficoltà maggiori, oltre agli aspetti tecnico-organizzativi e alla necessità di completare il programma in un contesto tanto difficile, hanno riguardato semmai gli aspetti della valutazione, che del resto, nella forma feticistica della media matematica, è discutibile e discussa al di là e ben prima del digitale. Roncaglia ha infatti ragione nel dire che la didattica a distanza più che creare nuove criticità ha fatto emergere quelle preesistenti, sia relative alla scuola nel suo complesso che ai singoli insegnamenti (problemi organizzativi, carenze strutturali, debolezze pedagogiche e relazionali, diseguaglianze nel gruppo classe etc.). Dico questo, lo preciso, pensando soprattutto al secondo ciclo di istruzione (la scuola del primo ciclo ha caratteristiche particolari e andrebbe valutata a parte), e sono convinto che il quadro più o meno ottimistico che molti tratteggiano della didattica a distanza sperimentata nei tre mesi di chiusura possa essere messo facilmente in crisi se si restringe e focalizza l’ambito di osservazione: c’è una differenza enorme tra licei, istituti tecnici e istituti professionali, così come tra liceo e liceo, tra istituto e istituto.
Quanto all’osservazione che replicando online il modello della lezione classica si sia riaffermato un rapporto di tipo asimmetrico tra docente e studente, se nella forma è stato così nella maggior parte dei casi, nella sostanza questa asimmetria, con la passività e la distanza che presuppone, in questi mesi si è in realtà ridotta: all’aula, spazio neutrale e spesso asettico (ripeto, parlo del secondo ciclo), si è sostituita una pluralità di spazi intimi fortemente caratterizzati, e questo setting inedito ha influenzato anche il modo di relazionarsi gli uni con gli altri. Studenti e insegnanti hanno condiviso allo stesso modo una situazione difficile, fatta di stress, paure, emotività; l’elemento personale è entrato prepotentemente all’interno della routine scolastica: molti insegnanti sono “scesi dalla cattedra” e hanno sperimentato con i propri studenti modalità informali di comunicazione e ascolto; nei casi migliori è emersa l’importanza dell’elemento soggettivo dell’apprendimento, l’autonomia interpretativa, la rilevanza per sé stessi di ciò che si studia. Proprio la distanza sociale e psicologica tipica della didattica in presenza, che non è solo metodo, ma atteggiamento e controllo dello spazio, paradossalmente con la didattica online si è sgretolata, tanto che io credo sarà difficile tornare in classe come se nulla fosse successo: in questo caso la pandemia è stata davvero uno spartiacque; ma il digitale ha solo attivato un processo, e nessuno si augura di ripetere l’esperienza.
Del resto, ho molte perplessità anche su cosa si intenda per “lezione frontale” e sulla sua demonizzazione a priori. La lezione frontale nella sua forma più pura e deteriore (io parlo, tu ascolti e prendi appunti) resiste strenuamente nelle aule universitarie ed è molto diffusa nella formazione professionale: negli ambiti cioè in cui io davvero credo che andrebbe fatta una rivoluzione metodologica (non per eliminarla, ma per subordinarla a un percorso non puramente trasmissivo). Non è un caso che molte università abbiano adottato esclusivamente la formula della lezione registrata (ma meglio sarebbe chiamarle “conferenze”), e nessuno si è accorto della differenza. Nella scuola invece la lezione è un ibrido imposto sostanzialmente dal vincolo del programma (bisognerebbe dunque partire dal mettere in discussione quello, prima ancora dei metodi); ma è comunque un ibrido: l’insegnante ascolta la voce della classe e dei singoli e imposta la lezione di conseguenza; gli studenti durante la lezione intervengono, non solo con domande ma con riflessioni personali, ne indirizzano lo svolgimento ed espongono il proprio punto di vista dialogando con l’insegnante e con gli altri studenti della classe; talvolta vengono stimolati a esporsi in forme di peer education, e non di rado i momenti di verifica orale sono gestiti con la formula delle interrogazioni programmate, a cura e sotto la responsabilità organizzativa degli studenti. Dietro l’etichetta di “lezione frontale” si nascondono dunque una pluralità di approcci e strategie empiriche che possono essere anche molto diverse tra loro, e che hanno in comune un’idea della classe come comunità che apprende. È vero che l’insegnante ha saldamente il controllo del processo formativo, non è un facilitatore né un osservatore, ma un educatore in senso pieno, secondo un modello sostanzialmente istruttivista. È anche vero che la dimensione collaborativa, ma meglio sarebbe dire cooperativa, prende raramente forme strutturate (Roncaglia accenna al lavoro per gruppi di progetto con ruoli definiti) ed è più spesso limitata alle forme di socialità e supporto reciproco descritte sopra. Ma davvero è così urgente introdurre a scuola la didattica collaborativa propriamente detta? e davvero il compito di avviare e governare questa rivoluzione dovrebbe essere affidato alla didattica digitale? Più che auspicare una rottura metodologica si dovrebbe lavorare per migliorare l’ibridazione già esistente e limitare le forme più obsolete di didattica trasmissiva, che sono prima di tutto il frutto di una mentalità sbagliata; ma il vero pericolo per quanto mi riguarda è la dispersione cognitiva indotta dalla pluralità sempre maggiore di contenuti, attività, stimoli esterni e interni alla classe: rispetto a questo, la centralità del docente che sceglie e guida è oggi ancora più necessaria rispetto al passato. La didattica digitale può offrire spunti e buone pratiche (e anche numerosi esempi di improvvisazione e pessime pratiche, comunque utili per capire cosa non fare), ma questo deve avvenire rispettando i tempi e le caratteristiche degli insegnanti e della classe, assecondando la naturale evoluzione del fare scuola (cosa che sta già avvenendo, seppure, per alcuni, in tempi troppo lenti), valorizzando le competente esistenti e dando la priorità allo sviluppo di nuove competenze teorico-pratiche che permettano di scegliere e sperimentare tecniche diverse, soprattutto in presenza, con piena consapevolezza e non per seguire la moda pedagogica del momento. Ciascun insegnante dovrebbe essere libero, salvo vincoli non prevedibili, di scegliere cosa fare, quando farlo e come farlo.
Quanto alla didattica collaborativa, nelle varie forme (fin troppe) che prende in letteratura, non la si può considerare di per sé un’evoluzione delle metodologie didattiche e per principio migliore della didattica trasmissiva: è un’altra tipologia di insegnamento, da utilizzare, con cautela e misura, in base ai contenuti disciplinari, agli obiettivi didattici, alla fase formativa, al profilo degli studenti: non tutti i momenti e non tutti i contesti sono adeguati, e anzi l’ambito di applicazione, nelle modalità più formalizzate e vincolate, è piuttosto specifico. Presuppone ad esempio elevate competenze metacognitive, tanto che funziona meglio, le evidenze lo dimostrano, nella formazione degli adulti, all’interno di gruppi di apprendimento omogenei per interessi ed esperienze professionali, con obiettivi ben definiti legati a percorsi di crescita consapevoli e autonomi: è in questi ambiti ad esempio che trova maggiore spazio il modello della Community of Inquire, che prevede lo svolgimento di attività di gruppo costruite attorno a situazioni problematiche. Esistono delle condizioni di contesto che rendono la didattica a distanza, integrata o anche pura, la scelta più opportuna o addirittura obbligata anche in assenza di pandemie: quando serve a garantire la formazione permanente, vale a dire il diritto (ma più spesso è un obbligo, se si vuole essere “competitivi”) di realizzarsi personalmente e professionalmente lungo tutto l’arco della vita. Si tratta di separare il grano dal loglio, di saper riconoscere la differenza tra un’offerta digitale predatoria (costruita per rispondere nella maniera più rapida ed economica a obblighi formativi o per assecondare le ambizioni dei cacciatori di titoli e CFU) e un’offerta virtuosa, basata su modelli testati empiricamente e validati scientificamente. Anche la formazione professionale degli insegnanti rientra in questa tipologia, ed è anzi proprio in questo ambito che la didattica digitale obbligata segnerà molto probabilmente un cambiamento strutturale. Nei mesi passati anche i corsi di aggiornamento si sono svolti interamente a distanza, e io credo che da questa esperienza non si tornerà indietro: sempre più scuole adotteranno la formula online per la formazione dei propri insegnanti, perché si è dimostrata nel complesso efficace e funzionale. In molti casi (quando il criterio di scelta non è solo quello economico) questi corsi sono fatti bene, e sono un’occasione importante per sviluppare quelle competenze digitali di cui ho parlato sopra: si unisce alla formazione di merito la pratica di strumenti, ambienti e metodologie nuove, e queste esperienze potranno, gradualmente, trovare spazio anche nella pratica didattica quotidiana.
Concludo con qualche parola su un tema al quale Roncaglia accenna appena: il ruolo che hanno avuto le grandi aziende informatiche come fornitrici di servizi essenziali durante la chiusura delle scuole, e quello che presumibilmente avranno in futuro. La didattica a distanza, a maggior ragione se svolta massivamente, ha bisogno di infrastrutture potenti e funzionali per gestire le lezioni e il lavoro delle classi. Tranne scelte residuali, la maggioranza delle scuole ha utilizzato la suite di strumenti di Google e in misura minore quella di Microsoft, che hanno fin da subito offerto i propri servizi gratuitamente (ma nella sostanza già lo erano: sono state estese le licenze d’uso). Il ministero ha per così dire “preso atto”, accettando e anzi incoraggiando il più imponente ingresso di aziende private all’interno del sistema di istruzione. Il fatto che queste aziende abbiano risolto un problema non esime dal farsi qualche domanda: l’ambiente online nella didattica a distanza equivale all’aula fisica, e dunque affidarlo a privati significa privatizzare la scuola pubblica. Anche tralasciando questioni di principio (che sono però sostanza), quali sono le conseguenze? quali i rischi? E prima ancora: si deve lasciare il campo alla concorrenza tra privati (ma in realtà a un quasi-monopolio) o è lo stato che deve farsi carico di fornire la piattaforma abilitante? In passato, quando il tema era poco più che accademico, tra gli addetti ai lavori se ne è discusso a lungo. Oggi invece non se ne parla, tranne una nota nel Piano scuola 2020-2021, pubblicato lo scorso 26 giugno, espressa con la classica indeterminatezza procrastinatoria dei documenti di questo tipo: «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito per la progettazione di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio». Si parla a dire il vero solo di contenuti, e non di strumenti; ma al di là del caso specifico sono piuttosto sicuro che nessuna piattaforma, pubblica o privata, possa cambiare nella sostanza il quadro che si è delineato nel passato anno scolastico, e che si consoliderà ulteriormente nel prossimo: o si sceglie di imporre una determinata soluzione – ma non è questa la linea seguita dal Miur né quella che personalmente auspico – o competere con Google e Microsoft è velleitario (e saranno per primi gli insegnanti a non voler cambiare). Al punto in cui siamo, credo sarebbe quantomeno opportuno stipulare accordi nei quali si metta nero su bianco che i dati raccolti dalle piattaforme private debbano essere utilizzati unicamente a scopi di utilità pubblica. Non mi riferisco soltanto alla tutela della privacy, formalmente richiesta nelle Linee guida per la Didattica digitale integrata. Per fare un bilancio della scuola dell’emergenza Roncaglia cita alcune indagini: quella del 7 aprile di CISL Scuola, quella svolta dal CENSIS tra il 10 e il 27 aprile, quella sempre di aprile di MTV, il monitoraggio del ministero del 25 marzo. Sono rilevazioni parziali, non aggiornate, ricavate perlopiù da questionari. Eppure c’è qualcuno che questi dati li ha, completi e sempre aggiornati, nella loro forma quantitativa: sono appunto le aziende che gestiscono le piattaforme su cui si è fatta scuola in questi mesi. Forse sono distratto, e chiedo scusa in anticipo, ma non mi sembra che i dati di tracciamento siano stati messi a disposizione del ministero, né ho letto che il ministero li abbia chiesti. Magari lo ha fatto e arriveranno, non lo so; ma al momento non mi risulta che siano pubblici, e dunque Google sa cosa è successo nei mesi scorsi molto meglio di noi e soprattutto del Miur, che deve affidarsi a rilevazioni parziali.
Non è poi vero, come alcuni dicono, che queste aziende di queste informazioni non sanno cosa farsene, e dunque almeno in parte si tratterebbe di un falso problema: le aziende mirano al profitto, e questa specifica tipologia di aziende il profitto lo fa, direttamente o indirettamente, con i dati comportamentali raccolti fornendo servizi gratuiti. Si può ulteriormente obiettare che da sempre il privato ha interessi nella scuola: qual è la differenza tra Google e l’azienda che vende banchi o l’editore che riempie gli zaini di libri di testo? Anche tralasciando le dimensioni, c’è una differenza fondamentale: l’editore scolastico ha nella scuola l’unico centro della sua attività, e quindi il suo interesse è, per così dire, centripeto; a Google interessano le persone viste come mercato, nel senso più ampio del termine: il suo raggio d’azione è centrifugo. Durante l’emergenza, queste corporation hanno ottenuto un risultato che prima sarebbe stato semplicemente inimmaginabile: posizionarsi strutturalmente all’interno delle istituzioni scolastiche, inserirle in un ecosistema commerciale e contestualmente raccogliere, nell’immediato e in prospettiva, una quantità enorme di dati su un target preziosissimo: i giovani e giovanissimi che vivono in rete e influenzano i consumi e i comportamenti delle famiglie. Chi lavora in questo ambito sa bene che insegnanti e studenti sono da sempre nei pensieri di Google, Microsoft, Amazon, Apple, per dire le maggiori; ma una cosa è stata sempre chiara ai meno ingenui: queste aziende concepiscono la scuola principalmente come un mezzo per arrivare a qualcos’altro. Il fatto che abbiano offerto i propri servizi gratuitamente non deve porci in eccessiva riverenza: quello che hanno ottenuto è molto più di quello che hanno dato. Come sempre nella storia, i mecenati sono una categoria di cui diffidare a priori.