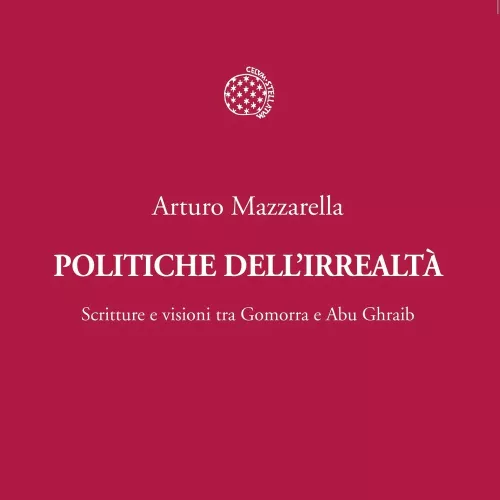"Politiche dell’irrealtà" di Arturo Mazzarella
Pubblichiamo in anteprima un estratto del libro Politiche dell'irrealtà di Arturo Mazzarella, in uscita presso l'editore Bollati Boringhieri il 19 maggio, qui commentato in esclusiva per doppiozero da Andrea Cortellessa.
L’opera del fantasma
Questo libro si presenta uno e bino. Il libro numero Uno – che contrappone la poetica di Roberto Saviano (la poetica, si badi, più che l’effettivo esito testuale di Gomorra) a quella di altri autori di non-fiction di lui meno condizionati dalle retoriche della testimonialità (dal prototipo di Capote, A sangue freddo, ai più recenti esempi del Franchini dell’Abusivo e del Balestrini di Sandokan, passando per un’innovativa lettura di Sciascia – giustamente indicato quale archetipo italiano del genere) – animerà senza dubbio le discussioni più virulente e, c’è da scommettere, meno interessate alla prospettiva teorica che spinge l’autore, invece, almeno quanto la sua vis polemica e il suo gusto per la provocazione intellettuale (entrambi indubbi). Il libro numero Due, che si annida all’ombra del pamphlet con pagine di grande penetrazione intellettuale, è invece un saggio di estrema novità oltre che intelligenza: che appunto meriterebbe discussioni ben più approfondite e spregiudicate. Proprio la spregiudicatezza intellettuale è del resto, e non da ora, la divisa di Arturo Mazzarella: saggista proverbialmente poliedrico e multitasking, in grado di spaziare con sovrana agilità fra le nuove frontiere della ricerca letteraria, l’orizzonte dell’immagine nel panorama delle nuove tecnologie e le più appuntite posizioni filosofiche e teoriche.
È una posizione concettuale, la sua, che si va chiarendo con coerenza invidiabile ormai da un quindicennio almeno. Suo vero punto di partenza è infatti da indicare in un libro che parrebbe ancora appartenere alla sua “archeologia” di italianista (ma, si badi, della scuola più originale che questa disciplina abbia potuto vantare negli ultimi decenni, quella napoletana e poi pisana di Giancarlo Mazzacurati), I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni (Liguori 1996) – e che invece mette in atto un corpo a corpo senza quartiere, di taglio squisitamente teorico e filosofico, col vero feticcio del nostro tempo: quello della realtà. L’«arido vero» e appunto i «dolci inganni» entrano, nel pensiero e nell’opera del nostro primo autore moderno, in una dialettica serrata: che non consente contrapposizioni moralisticamente manichee né, tanto meno, scorciatoie neopositiviste oggi ritornanti. Non è un caso che il successivo La potenza del falso. Illusione, favola e sogno nella modernità letteraria (Donzelli 2004) metta in relazione di nuovo Leopardi, e il suo madornale laboratorio lo Zibaldone di pensieri, con opere “parenti” come i frammenti di Novalis e i Cahiers di Paul Valéry. Al centro dell’indagine è il concetto di finzione: che già nell’etimo mostra il proprio inscindibile legame con qualsiasi forma di elaborazione letteraria e, al contempo, svela la propria necessaria relazione dialettica col concetto di verità. Se è con la finzione che la letteratura da sempre fa cenno al vero, al di là delle apparenze fenomeniche, vorrà dire che la censura cui la finzione viene sottoposta – censura certo non nuova, nella storia dell’estetica, ma mai risoluta come nel nostro tempo – non fa fare un solo passo avanti, alla stessa ricerca della verità.
Nella Grande rete della scrittura. La letteratura dopo la rivoluzione digitale (Bollati Boringhieri 2008), lo sguardo d’improvviso si allarga sino ad annettere i più complessi intrecci intermediali e multiculturali che rivestono la sfera del nostro presente infinitamente interlacciato: inseguendo autori al centro della discussione letteraria contemporanea (da Celati a DeLillo, da Kundera a Ellis, da Ballard ad Amis) ma soprattutto mettendo la letteratura – al di là di ogni stereotipo autocommiseratoriamente minoritario – al centro del più vasto panorama mediale e tecnologico. Sicché non più di finzione ma di virtualità si parla: ancora una volta evitando di contrapporla a una realtà che invece da tante parti, assurdamente, si pretende già data e immodificabile, univoca e rigida. Quando invece il realismo più consapevole non può che essere, come insegna l’estetica contemporanea, relazionale e processuale: cioè in necessaria tensione dinamica, mobile, multiprospettica.
Con questa storia intellettuale il passo compiuto con Politiche dell’irrealtà, si diceva, è di grande coerenza; ma segna pure, al contempo, un evidente salto di qualità. Segnalato – come la lettera rubata nell’apologo di Poe caro a Lacan e Derrida nonché allo stesso Mazzarella – sin dal titolo. La questione, toccando i fenomeni a specchio delle esibizionistiche torture nel carcere di Abu Ghraib e la tecnica delle videoesecuzioni degli ostaggi da parte dei terroristi afgani e iracheni, va al di là della stessa dimensione estetica e gnoseologica per mostrarsi, infatti, nel suo più scottante rilievo politico. Che la partita decisiva del nostro tempo si giochi sul terreno mediale, e che la posta in gioco dipenda dalla gestione delle immagini, e delle immagini più violente in particolare, lo dimostra con insolente evidenza, e tempestività persino perturbante, la vicenda delle fotografie e dei filmati dell’uccisione di Osama Bin Laden che l’amministrazione statunitense – che dall’avvenuto ha tratto un bonus di popolarità senza precedenti – non pare abbia alcuna intenzione di divulgare. Una scelta in significativa controtendenza, rispetto alla tradizione moderna qualche tempo fa ricostruita da Giovanni De Luna (Il corpo del nemico ucciso, Einaudi 2006), di uso propagandistico e appunto politico dell’immagine macabra.
Le due fotografie di “riflesso” di quest’evento invisibile ma in tutti i sensi decisivo – quella del Presidente Barack Obama, del Segretario di Stato Hillary Clinton e del loro staff che seguono live lo svolgersi dei fatti, preoccupati e quasi atterriti, proprio attraverso quelle immagini che ora negano ai loro concittadini; e quella dello stesso capo terrorista che, sepolto vivo nel proprio tugurio in Pakistan, catatonico scorre sul video le immagini gloriose dei suoi clamorosi videomessaggi passati – ci dimostrano la giustezza dell’assunto di Politiche dell’irrealtà: lungi dall’essere una forma di evasione dalla realtà, o di sua ludica o interessata cancellazione (come alternativamente temuto o auspicato dai maggiori pensatori della prima stagione postmodernista, quali Jean Baudrillard da Mazzarella ampiamente discusso), l’immagine riprodotta è parte integrante di quella realtà e, soprattutto, anche al di là delle intenzioni di chi la manipola essa consegue macroscopici effetti di realtà (non, si capisce, nel senso del celebre concetto di Barthes qui pure ricordato).
È vero infatti che le videoesecuzioni sono opera di agenti del terrore in tutto simili e assimilabili a fantasmi, così come è vero che all’atto di nascita del nostro tempo mostra caratteri analoghi lo stesso attacco dell’11 settembre 2001 – grande «opera d’arte», disse allora Karlheinz Stockhausen subito equivocato; cioè grande spettacolo intimidatorio, Grand Macabre che per la propria riuscita contava sulla massima copertura mediatica; con ciò davvero ritorcendo contro l’avversario occidentale le sue stesse armi di distrazione di massa – ma è altresì vero che quelle azioni fantasmatiche hanno conseguenze dolorosamente, disastrosamente reali. Gli ostaggi decapitati in diretta dagli uomini di Al Qaeda muoiono davvero, come davvero sono morti a migliaia coloro che lavoravano nel World Trade Center, e nei mesi e anni successivi sono morti davvero, per ritorsione, decine di migliaia di incolpevoli cittadini afgani e iracheni.
Del resto una ragione ci deve pur essere, se i fantasmi – da che mondo è mondo – ci incutono terrore.
Andrea Cortellessa

Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà. Scritture e visioni tra Gomorra e Abu Ghraib (copyright 2011, Bollati Boringhieri Editore, Torino)
Uno spettatore che, per assolvere fino in fondo il suo compito, si converte in attore costituisce un’ambiguità davvero stridente, soprattutto se pensiamo che essa è connaturata alla fisionomia del testimone. Figura divisa, lacerata come poche. Può rimanere fedele all’obbligo di tramandare gli eventi ai quali ha assistito solo tradendo la propria attendibilità: trasformando l’assoluta singolarità dell’avvenimento in una sequenza narrativa che, per risultare comprensibile alla più estesa comunità di lettori e di ascoltatori, deve necessariamente utilizzare gli artifici basilari del racconto. Jacques Derrida, in uno dei suoi saggi dedicati al concetto di «segreto», è riuscito a evidenziare con inappuntabile linearità il circolo di contraddizioni entro cui si snoda la testimonianza (un tema da lui affrontato, con la radicalità che lo contraddistingue, anche in altri lavori):
Se la testimonianza richiede l’istante – osserva Derrida –, una tale condizione di possibilità è distrutta proprio dalla testimonianza, nella misura in cui la percezione oculare, uditiva o tattile del testimone dev’essere un’esperienza che connette tempi diversi, non limitandosi, di conseguenza, all’istante. Nel momento del bear witness, del rendere testimonianza, si esige una connessione temporale – per esempio, quella delle frasi –, e soprattutto che le frasi promettano di essere ripetute. Quando mi impegno a dire la verità, mi impegno a ripetere la stessa cosa, dopo un istante, dopo due istanti, il giorno dopo e, in qualche modo, per l’eternità. Proprio questa ripetizione porta l’istante fuori di sé.
È questo il presupposto in base al quale – continua Derrida – «non si potrà mai provare che una testimonianza è autentica». Aggiunge, infatti, di lì a poco aprendo Dimora. Maurice Blanchot: «Il testimone “giura di dire la verità”, promette l’autenticità. Ma persino laddove non cede allo spergiuro, l’attestazione non può non intrattenere una torbida complicità con la possibilità, almeno, della finzione».
Saviano, animato dalle incrollabili certezze che sembrano sostenerlo in ogni pagina, non riesce a reggere il peso di una simile ambiguità. Risolverla, per lui, è decisivo. Ne va di mezzo la sua integrale concezione della verità. E, dunque, la struttura stessa di Gomorra. La strategia scelta per aggirare l’ostacolo si dimostra di una semplicità quasi sconcertante, come rivela il ricorso brusco e immediato ai processi di rimozione. A Saviano basta allontanare il più possibile da lui uno dei due poli intorno a cui ruota la testimonianza: il polo narrativo, appunto; offuscato progressivamente, nel corso di Gomorra, dall’indiscutibile primato attribuito alla pura registrazione dell’evento (strano che Alessandro Dal Lago, nella sua dettagliata analisi di Gomorra, abbia frainteso profondamente questo scambio tipologico operato da Saviano).
Certo, è una scelta stravagante per un narratore. Ma chi ha detto che egli debba sempre presentarsi come tale? Il guardaroba a disposizione dei narratori è talmente attrezzato da contenere trucchi, maschere e travestimenti di qualsiasi genere. Al suo interno troviamo anche i procedimenti adatti a svestirsi dei panni dello scrittore per indossare gli abiti del cronista. Di cosa? La risposta di Saviano, al solito, non conosce esitazioni: cronista della realtà. Fermata, fissata, nella sua incontestabile evidenza. E poi affidata all’unico potere che Saviano effettivamente riconosca: il potere della denuncia, al quale – se vuole – la parola è in grado di appellarsi. Esso sì che «è davvero infinito», ribatte Saviano nel suo ultimo pamphlet, La parola contro la camorra. Ne consegue che sarà la denuncia, alcuni mesi dopo, l’estenuante Leitmotiv di ogni puntata del fin troppo fortunato programma televisivo – diventato anche libro – Vieni via con me, ideato e condotto da Saviano in collaborazione con Fabio Fazio.
Sul potere della denuncia Capote e Sciascia, due scrittori di sicuro agli antipodi, hanno nutrito molti dubbi: tanti da sottolineare rispettivamente, attraverso una concordia inattesa, che la «realtà» e i «riflessi» formano una vera e propria endiadi, come, d’altronde, i «fatti» e i «fantasmi». Saviano, pur situandosi al centro di un’ipotetica convergenza tra i due – tra la pura seduzione affabulatrice e la necessità di attribuire alla narrazione uno spessore conoscitivo –, non è certo di questo avviso. La realtà, ai suoi occhi, per manifestarsi compiutamente non ha bisogno di riflessi; né, tanto meno, di fantasmi. Lo dimostra lo sguardo vorace, in costante fibrillazione del testimone: soprattutto di un testimone capace di fondare il suo resoconto su un numero ragguardevole di prove.
L’ubiquità del narratore-testimone è impressionante. Come Donnie Brasco (il celebre agente dell’FBI infiltratosi negli anni settanta tra gli ambienti della mafia di New York), riesce a spostarsi dovunque, con incredibile rapidità: dal porto di Napoli arriva all’hinterland settentrionale della città, poi lo troviamo a Secondigliano e Scampia, di nuovo a Napoli – per la precisione nei dedali di Forcella – e, dopo non molto, a Casal di Principe, a Mondragone, prima di concludere il suo itinerario nella «terra dei fuochi», tra le discariche della campagna napoletana. Riesce sempre a trovarsi, con una regolarità sorprendente, là dove la ca morra sta per celebrare, o ha da poco celebrato, qualcuno dei suoi funesti rituali. È il riscontro più efficace del valore della testimonianza. Prima ancora che il lettore si senta garantito dalla veridicità delle fonti (atti processuali, inchieste giudiziarie o articoli di giornale), il corso degli eventi risalta con vigore indelebile in ogni pagina del romanzo grazie all’invadente protagonismo assunto dalla presenza del narratore. I tratti tipici del processo di autodesignazione da parte del testimone – su cui necessariamente si fonda la testimonianza – sono sottoposti da Saviano alla massima amplificazione. Se la testimonianza esiste perché, ci ricorda Ricoeur, «è il testimone a dichiararsi, innanzitutto, come testimone», l’autore di Gomorra, in nome della propria credibilità, vuole reiterare senza sosta questa investitura.
È l’atto completamente assente nei due romanzi che possono vantare senza dubbio una primogenitura tematica rispetto a Gomorra: L’abusivo di Antonio Franchini, pubblicato nel 2001, e Sandokan di Nanni Balestrini, apparso nel 2004. Entrambi, conoscendo le insidie e le contraddizioni che minano il non-fiction novel, escludono qualsiasi riferimento a un testimone oculare per servirsi, con felice disinvoltura, delle mediazioni offerte dalla letteratura.
Sia per Franchini sia per Balestrini la presenza della camorra, al centro dei loro due romanzi, ha essenzialmente il valore di un repertorio di immagini: vere, perché appartenenti alla cronaca, ma, nello stesso tempo, false; al pari di ogni finzione, di ogni dilatazione degli eventi prodotta dalla scrittura letteraria. Alle cui strategie Franchini e Balestrini – tra loro molto lontani per formazione e intenti – si consegnano senza reticenze: non per sottrarsi alla realtà, piuttosto per sondarne la trama invisibile. Riferendosi a Giancarlo Siani, il giornalista napoletano protagonista dell’Abusivo, ucciso dalla camorra nel 1985 a ventisei anni, Franchini rovescia tutti i luoghi comuni che si affollano intorno alla figura della vittima, pur ricostruendone minutamente il profilo attraverso testimonianze di prima mano suffragate dal suo stesso intervento in qualità di voce narrante e di personaggio-chiave del romanzo. Ma è una presenza che, al contrario del narratore di Gomorra, non mira a rischiarare gli eventi, a ordinarli, riportandoli entro coordinate prestabilite. Agisce in modo inverso. Sceglie di confondere i fatti, di aggrovigliarli; di proiettarli su uno scenario nel quale risalta la loro incompiutezza.
Franchini vorrebbe anche indossare i panni del testimone oculare, se non fosse consapevole della divaricazione che esiste tra i fatti e le parole. Mai all’altezza, queste ultime, di restituire la vivida pregnanza di ciò che è accaduto:
E invece era proprio così, era proprio questo: Giancarlo Siani è morto per aver scritto. […] La chiave del mistero stava proprio in mezzo ai suoi articoli, tra quelle colonne di testo frugate e rifrugate centinaia di volte dagli inquirenti, dai suoi amici, dai suoi colleghi, da qualsiasi dilettante volesse cimentarsi col caso. Giancarlo è morto per aver scritto e per non essersi accorto, per non aver capito fino in fondo che cosa stava scrivendo.
Si può morire, come nel caso di Giancarlo Siani, a causa delle parole scritte e, successivamente, si può tentare, da parte dei giudici, di ripristinare con le parole la verità. Rimangono, tuttavia, degli sterili tentativi, incapaci di uscire da quella che Franchini definisce la «commedia dell’assurdo». «L’unico senso, il solo elemento che conta è la sentenza “non può continuare a vivere”; tutto il resto – prosegue Franchini – è l’inutile sensibilità alle parole», la loro inguaribile fragilità. Che, però, può ribaltarsi anche in una risorsa – la medesima risorsa conoscitiva alla quale si rivolgono sia Capote, sia Sciascia ed Ellroy –, solo dopo essere stata accettata come una marca originaria del logos, a partire da cui esso è destinato a dispiegarsi. Ci troviamo di fronte a un orizzonte che, ancora una volta, non abbraccia i fatti, ma quanto di più friabile e caduco contiene la parola: congetture arrischiate, ipotesi improbabili, combinazioni enigmatiche. Proprio quelle che Balestrini manipola, da quasi cinquant’anni, con sicura maestria.
Nella premessa alla nuova edizione di Sandokan, pubblicata nel 2009, se ne accorge lo stesso Saviano, costretto a fare i conti con un romanzo che, attraverso la saga del clan dei casalesi, anticipa uno tra i principali nuclei tematici di Gomorra. Ma l’affinità tematica serve solo, in questo caso, a mettere in risalto la profonda distanza che separa le due opere: «Sandokan – scrive Saviano, rielaborando una recensione del 2004 – non è un romanzo sulla camorra, neanche un reportage narrativo, né un’inchiesta; è un flusso d’esperienze e riflessioni, una traccia diuturna, una fenomenologia della vita al tempo della camorra. È infatti un racconto senza punteggiatura, come può essere l’oralità di una discussione scambiata in un bar di provincia nella desolazione di un pomeriggio».
Quello a cui il Sandokan di Balestrini non può in alcun modo aspirare è proprio il valore della testimonianza, vuole suggerire implicitamente Saviano. Il discrimine rispetto a Gomorra è netto, preciso. «Un racconto senza punteggiatura» elude i criteri basilari sui quali si fonda la veridicità della testimonianza, presentandosi all’insegna della pura letterarietà, anche se riscattata dall’impegno etico-civile che il tema richiede.
Ecco, in poche parole, l’esito raggiunto implicitamente da Saviano nella breve prefazione che apre Sandokan. Si tratta di una considerazione coerente, a patto, però, di valutare – secondo le intenzioni di Saviano – la testimonianza quale vertice categoriale di una genealogia conoscitiva interdetta al linguaggio letterario. Proprio il «flusso di esperienze e riflessioni» – come le definisce l’autore di Gomorra – a cui si affida Balestrini con Sandokan (ultima prova di una trafila che, nell’ambito della prosa, parte da Vogliamo tutto per arrivare ai Furiosi e Una mattina ci siam svegliati) denota l’inattendibilità di un ragionamento del genere. L’opzione a favore di un linguaggio radicalmente anti-mimetico non implica certo, da parte di Balestrini, un brusco congedo dalla realtà.
Almeno dal 1956, anno in cui viene tradotto in italiano Mimesis di Erich Auerbach, diventa finalmente patrimonio di tutto il ceto colto la consapevolezza che l’aderenza alla realtà non è una questione tematica, ma squisitamente formale. È sempre una determinata impronta stilistica a proiettare un testo letterario sullo sfondo dell’ordine discorsivo «realista». Altrimenti come potrebbe rientrare al suo interno Al faro di Virginia Woolf (da cui Auerbach prende le mosse nel capitolo finale di Mimesis)? Un romanzo, cioè, interamente rivolto a illustrare i moti e le oscillazioni che compongono il tempo interiore dei personaggi, il tempo della loro esperienza vissuta: trasposto da Virginia Woolf in un registro stilistico rarefatto, pieno di intermittenze e accavallamenti; perciò, per Auerbach, integralmente realistico, del tutto aderente alla stratificazione dei tempi che di fatto scandiscono la vita della coscienza.
Di ingorghi conoscitivi, di esperienze frantumate nel corso del proprio divenire torna a parlare Balestrini attraverso Sandokan. Anche questi sono gli effetti prodotti dalla camorra: organizzazione dalla concretezza ineccepibile, nella logica del profitto economico che la ispira, e, insieme, dalla inafferrabilità impalpabile – come Saviano sa bene –, perché il suo radicamento e la sua riproduzione chiedono un costante investimento nel campo dei simboli, delle immagini, del feticismo generalizzato. L’economia criminale globale – ha intuito il sociologo catalano Manuel Castells in Volgere di un millennio, uno dei volumi della monumentale trilogia dedicata all’età dell’informazione – deve oggi il proprio potere a una cultura alimentata soprattutto dal flusso capillare dell’immaginario mediatico. Un flusso difficile da regolare e prevedere, secondo un processo ricorrente nel nostro contorto e conflittuale spazio globalizzato in ogni suo segmento. In una versione imbastardita e degradata questo flusso sembra corrispondere a uno dei nuovi streams of consciousness modellati dalle frange più emarginate della società attuale. Per conoscerlo da vicino, Balestrini ha capito che Sandokan vi si doveva immergere completamente, affondare nella sua accesa fantasmagoria senza alcuna ricerca di prove.
Per Saviano, al contrario, la conoscenza è sempre il prodotto di una verifica operata dal soggetto. Senza il ricorso martellante alla testimonianza diretta del narratore, alle funamboliche acrobazie attraverso le quali, spezzando la linearità della trama, egli interviene in prima persona nel racconto, il contributo informativo delle fonti utilizzate da Saviano, si diceva, avrebbe un rilievo minore. Il testimone di Gomorra deve, infatti, la sua infallibilità alla propria onnipresenza: prima e inconfutabile prova di una conoscenza che non ammette smentite (ma Franco Cordelli, nel Duca di Mantova, aveva già dimostrato che non basta partecipare in prima persona a una vicenda tratta dalla cronaca politica per risultare attendibili).
Saviano adopera un ampio ventaglio di strategie per ottenere questo vero e proprio straripamento dell’io narrante, in atto fin dalle prime pagine del romanzo: là dove il narratore perde immediatamente la sua neutralità, per diventare a tutti gli effetti il personaggio principale. È una metamorfosi realizzata con notevole abilità.
[…]
Il paradosso è quasi clamoroso. Noi, gli ultimi eredi in ordine di tempo del razionalismo che l’Occidente porta inciso tra i suoi valori supremi, non riusciamo a comprendere la pregiudicata strumentalità con la quale un manipolo di fanatici religiosi dimostra di adoperare le immagini. Purtroppo è così. Il moralismo di Saviano e di Susan Sontag o l’etica della vulnerabilità invocata da ampie schiere di intellettuali ci rendono sempre più estranea la natura dell’immagine: considerata ancora nei termini di un supplemento che va ad aggiungersi alla realtà e non, viceversa, come il principio costitutivo della realtà stessa.
Al Qaeda e le altre sigle che la fiancheggiano hanno capito meglio di chiunque altro quale sia attualmente lo statuto dell’immagine. Hanno capito che essa possiede una tale plasticità da lasciarsi modellare e manipolare dovunque: anche negli anfratti più sperduti dove operano i militanti islamici. «Non esiste uso buono dei media, i media fanno parte dell’evento, fanno parte del terrore». Come dare torto a questa apodittica affermazione pronunciata da Jean Baudrillard nello Spirito del terrorismo?
I media fanno parte dell’evento. Baudrillard ha ragione, nonostante il suo inconfondibile, e talvolta eccessivo, pathos apocalittico. In queste brevi sequenze di morte, per esempio, la presenza dello spettatore rimane il presupposto implicito, ma fondamentale. Si pensi a una tra le più note: l’esecuzione dell’imprenditore americano Olin Eugene Armstrong, avvenuta il 20 settembre 2004. I corpi inquadrati nel video appaiono simili a sagome dai contorni incerti, che l’evidente sgranatura dell’immagine e il nero delle uniformi vorrebbero rendere ancora più irriconoscibili. La vittima sacrificale è seduta a terra, con una benda sugli occhi, le mani e i piedi legati. Davanti vediamo una schiera di ombre. Eppure ciascuna di loro manovra la realtà con padronanza assoluta. È l’ambivalenza tipica del fantasma, di tutti i fantasmi: «Non c’è fantasma – scrive Derrida in Spettri di Marx –, non c’è mai divenir-spettro dello spirito, senza almeno un’apparenza di carne, in uno spazio di visibilità invisibile. […] Perché ci sia fantasma, è necessario un ritorno al corpo, ma a un corpo più che mai astratto». Le sagome che solcano la scena delle videoesecuzioni non sono, infatti, inerti. Letta la sentenza, in pochi istanti passano all’azione. Senza perdere la rigidità di una posa quasi ieratica, diventano gli esecutori della decapitazione: uno tra i rituali di morte più arcaici, imbevuti di una polisemia simbolica che, secondo la ricostruzione offerta da Julia Kristeva, non ha mai smesso di esercitare una profonda suggestione.
Come non essere d’accordo, allora, con Artaud quando, nel passo riportato in precedenza, suggerisce che «l’immagine di un delitto presentata in condizioni teatrali adeguate sia per lo spirito infinitamente più terribile della realizzazione di quello stesso delitto»?
Ancora una volta, quando la sovranità sale alla ribalta per esibire la propria potenza, i fantasmi – nel caso delle videoesecuzioni gli attori di una scena in apparenza priva di contorni reali – rivendicano il loro naturale protagonismo: quasi a volere offrire un riscontro materiale all’ipotesi profilata da Derrida, per il quale la sovranità si fonda sempre su un principio di ordine fantasmatico (un «principio-fantasma arcaico», lo definisce nel discorso pronunciato in occasione della laurea honoris causa conferitagli dall’Università di Atene nel 1999, poi pubblicata in italiano con il titolo di Incondizionalità o Sovranità). Non per questo, però, privo di consistenza. Anzi, reale; tanto reale da essere riproducibile innumerevoli volte. Il fantasma, nella sua originaria etimologia sottolineata più volte da Jean-Pierre Vernant, non coincide forse con la pura apparenza, con l’arco di sembianze assunte dall’intero universo sensibile nell’atto del suo manifestarsi?
Régis Debray, pensatore per nulla sedotto dalle sofisticate acrobazie che il disincanto in genere consente, circa venti anni fa è arrivato a un passo dall’anticipare, nella sua ampia panoramica sulla storia dello sguardo in Occidente, gli esiti di questo inglobamento della realtà all’interno del regime onnicomprensivo dell’immagine: «Finché c’è morte, c’è speranza estetica», osserva Debray, per aggiungere poco più avanti: «Se la morte è all’inizio, si comprende che l’immagine non abbia fine». La morte richiede sempre un’immagine che l’attesti, la ricordi o la celebri. Senza immagini anche la morte perde il proprio significato di evento cruciale, irrompendo con una brutalità muta ed enigmatica.
La possibilità di generare una sequenza di immagini a partire dalla morte vale, per i registi delle videoesecuzioni, quale garanzia dell’effetto di realtà prodotto dalla messa in scena. Senza di essa l’evento in questione non esisterebbe. La riproduzione dell’evento, infatti, nella pratica delle videoesecuzioni, precede sistematicamente l’esistenza dell’evento medesimo. Se non ci fosse la ripresa video, diffusa globalmente, non ci sarebbe neanche l’esecuzione. Si produce un evento perché c’è un numero imprecisato di spettatori che lo guarderà, attraverso la gamma più diversificata di tonalità emotive: è questa la svolta impressa dalle videoesecuzioni nei processi di raffigurazione della realtà.
Non c’è niente di nuovo, niente che non sapessimo. Forse non pensavamo che la realtà rivelasse in modo così spudorato la sua natura artificiale, la sua assoluta dipendenza dall’immagine che la raffigura: medium indispensabile di rivelazione, non già veicolo di occultamento. Siamo oltre, molto oltre, i principi che regolano la società dello spettacolo analizzata, nella seconda metà degli anni sessanta, da Guy Debord. Definire oggi l’immagine – sono parole scritte da Debord in apertura della Società dello spettacolo – «il luogo dell’inganno dello sguardo e il centro della falsa coscienza» risulta del tutto anacronistico. Dobbiamo solo all’immagine la possibilità di attribuire un senso e di assicurare una permanenza al flusso di eventi che compongono la realtà.
Sono questi i motivi per cui, dovendo azzardare una classificazione, la maggior parte delle immagini che circolano nel nostro presente andrebbero assegnate non più all’ordine delle testimonianze – attestazioni che rientrano ancora nella sfera di un protagonismo individuale – ma al registro dei documenti, intesi nell’accezione proposta di recente da Maurizio Ferraris: tracce che «crescono e si auto-alimentano in base a un sistema di iscrizioni che, permettendo la fissazione degli atti, contribuiscono alla creazione di ciò che, nel mondo sociale, appare come significativo». Ma la traccia, per quanto dotata di un supporto materiale, è caratterizzata da una duplicità che le appartiene per natura. Rimane sospesa tra presenza e assenza, poiché la sua funzione consiste nel rinviare puntualmente – osserva Ferraris – «a qualcosa di non presente».
Ogni traccia, dunque, non si esaurisce mai nella sua semplice evidenza. Sta lì, con i suoi contorni nitidi, per poi lasciarsi rimpiazzare dall’elemento evocato. Davvero ambigua la sua fisionomia. Molto simile a quella degli attori che danno vita alle videoesecuzioni: volti mascherati che si stagliano su uno sfondo granuloso e sfocato; pronti a sparire appena eseguita la sentenza, salvo ripresentarsi all’improvviso. Ecco perché siamo nel regno dei fantasmi. Ha ragione Derrida (da sempre l’interlocutore privilegiato di Ferraris): la nostra esistenza sociale è circondata da fantasmi, da figure assenti che non smettono di essere presenti. «Anche quando il vecchio fantasma della sovranità perde di credibilità» – afferma Derrida in Stati canaglia, un’opera rivolta a un serrato confronto con il nuovo ordine politico e sociale – continua l’assedio dei fantasmi. Adesso, però, non tentano di celare la propria presunta onnipotenza; anzi si impegnano a ostentarla con premeditata consapevolezza: forse per dissimulare la loro vulnerabilità, per rimuovere una reale impotenza.
Duplici, ambigue, si presentano tutte le immagini del terrore (le scene catastrofiche dell’11 settembre quanto il theatrum delle videoesecuzioni). Se, da un lato, conservano una spregiudicata sofisticazione mediatica, dall’altro non riescono a occultare la «potenza senza finalità» di cui si alimentano – così la definisce Alain Badiou in un saggio sull’11 settembre. Per non rimanere vittima della propria autodistruzione, una potenza del genere può solo mostrare, attraverso il fantasma del terrore, la possibilità di continuare a riprodursi. «In fondo, lo spettro – ribadisce Derrida in Spettri di Marx – è l’avvenire, è sempre a venire, non si presenta se non come quel che potrebbe venire o ri-venire».