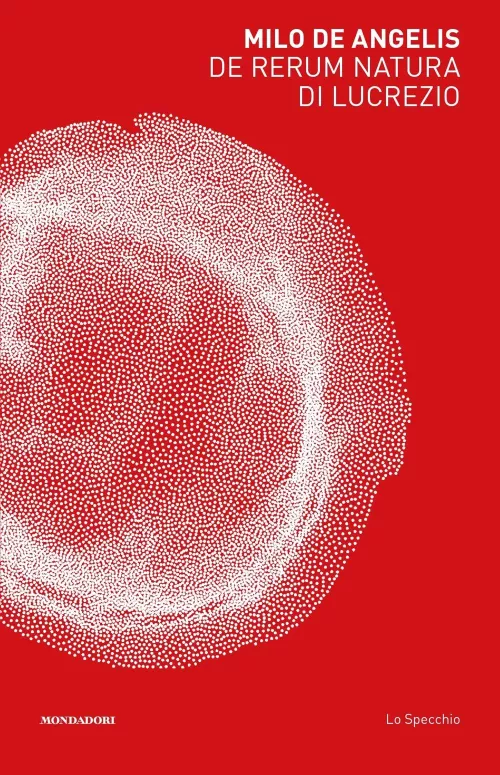Milo De Angelis: il nuovo De Rerum Natura
Lucrezio è il più misterioso e inafferrabile degli autori latini, eppure sembra il più vicino a noi, quasi contemporaneo nella sua visione della natura, nella sua forza introspettiva capace di addentrarsi nei chiaroscuri dell’anima, di esplorare le zone più buie e vertiginose dell’esperienza umana.
Dopo lunghi anni di lavoro sul testo, Milo De Angelis, tra i nostri maggiori poeti contemporanei, ha dato in questi giorni alle stampe per Mondadori una nuova versione del De Rerum Natura, “il poema dell’infinita tempesta”, come lui stesso l’ha definito prendendo in prestito le parole di Giovanni Pascoli.
Un lavoro imponente e complesso, un vero e proprio corpo a corpo con l’opera e la lingua del grande poeta-filosofo dell’Antica Roma, autore di un solo libro (diviso in sei volumi), che, come pochi altri, è riuscito a marcare a fuoco il pensiero e la poesia occidentale dei secoli successivi, fino ai giorni nostri.
Questa vigorosa traduzione di De Angelis restituisce, con una lingua viva, briosa, piena di guizzi e un’adesione poetica unica, tutta la potenza gnoseologica e cosmica del poema lucreziano, ricreandone fedelmente lo spirito e la tensione interna.
Nel testo introduttivo del volume spieghi che questa traduzione nasce da un lungo sodalizio con Lucrezio: “Un lungo tragitto fatto insieme, tante strade percorse e tante visioni comuni, quasi delle nozze poetiche, con promesse solenni, contrasti, riprese, abbandoni, ritorni”… Insomma, l’opera di questo autore ti accompagna da sempre. Ma quando hai incontrato per la prima volta Lucrezio e cosa da subito ti ha colpito?
Mi ha colpito la sua solitudine. Mi ha impressionato il suo dialogo ininterrotto con i grandi maestri greci del passato e il rifiuto degli scrittori a lui contemporanei, quasi ci fosse una distanza di anime, qualcosa di cruciale che impediva tra di loro un legame duraturo. Mi ha poi colpito, leggendo i suoi versi al liceo, la forza imperativa e infinitamente vitale del suo furioso nichilismo, la certezza che l’anima è mortale, gli dei sono indifferenti al nostro dolore e l’Ade è un mucchio di storielle a buon mercato per avvelenare la nostra esistenza sulla terra: nulla esisteva prima di noi, nulla esisterà dopo di noi, siamo sospesi tra un vuoto che ci precede e un vuoto che ci attende, ma proprio per questo la vita ha un valore inestimabile.
Forse è solo attraverso la traduzione che hai potuto davvero “soggiornare nella dimora del poeta”, per usare le tue parole. È così?
Può essere suggestiva l’immagine del traduttore che abita nella dimora del poeta e guarda dalla finestra le stesse cose viste da lui. Ma certo non basta una suggestione, uno sguardo in comune o una scena vista da entrambi per creare un vero rapporto tra il poeta e il traduttore. Diciamo che è solo un buon punto di partenza. Occorre poi un duro lavoro sul testo, uno strenuo corpo a corpo sui dettagli e sulle ampiezze, sulla singola immagine e sul respiro totale della sua opera, naturalmente.
Più in generale cosa significa per te tradurre dagli antichi?
Di fronte all’antico continuo a provare un’adesione e insieme un turbamento, l’impressione di essere di fronte a una natura doppia, divaricata. Nell’antico c’è qualcosa di finito, drammaticamente finito, confinato nel suo tempo, come la breve avventura di Ifigenia, sgozzata proprio in quel giorno, solo in quel giorno di primavera in Beozia… Ma al tempo stesso c’è qualcosa di incessante, qualcosa che supera tempi, luoghi, secoli e millenni e occasioni storiche, riesce a mantenersi intatto e a giungere fino a noi.
Lucrezio è considerato il più misterioso degli scrittori latini, eppure sembra il più vicino al tempo che stiamo vivendo. Tutti noi ricordiamo per memoria scolastica le formidabili scene in cui la natura si manifesta in tutta la sua catastrofica potenza: pestilenze, incendi, uragani, terremoti, forze immense che sovrastano l’uomo e lo schiacciano, povera canna al vento. Penso in particolare al libro VI del De rerum natura, nel quale viene affrontata la peste di Atene…
Lucrezio è sempre attuale perché in lui convivono l’anima etica e quella cosmica. Anche quando affronta un problema contingente – la peste di Atene del quinto secolo – riesce a proiettarlo in una visione eterna, mescolando le scene più cruente alla potenza dell’archetipo. Nel lungo racconto finale della pestilenza le forze della morte celebrano la loro apoteosi e di fronte a esse appare in tutta la sua evidenza la nullità dell’uomo, ma anche la sua abiezione, il panico che lo spinge a comportamenti infami, la sete di salvezza che lo porta a uccidere come una belva, la perdita di ogni dignità e di ogni pudore, trasformando l’intera città in un immane macello, in un carnevale di inganni e di massacri. E tutto questo è rappresentato da Lucrezio con una violenza espressionista, con un tono partecipe e allucinato ben lontano dalla descrizione “oggettiva” del suo modello greco, lo storico Tucidide, che aveva raccontato la pestilenza prima di lui.
Alcuni, vedendo con angoscia di essere sulle soglie della morte,
sceglievano di restare vivi amputandosi con una lama il membro
mentre parecchi altri rimanevano in vita senza le mani
e senza i piedi e altri ancora erano ormai privi di occhi:
a tal punto era penetrato in loro il terrore potente della morte!
(VI, 1208-1212)
Ma il De rerum natura è anche un’opera in cui l’uomo viene scrutato in ogni suo aspetto, con affondi mirabili nelle zone più buie e drammatiche della sua vita interiore, come vediamo nelle pagine del IV libro dedicate all’amore, tra le più crudeli che siano mai state scritte su questo tema grandioso e che la tua traduzione rende ancora più vivide…
Indubbiamente è così: il finale del quarto libro contiene alcune delle pagine più terribili che siano mai state scritte su questo argomento: gli amanti vengono descritti in una dimensione onirica, allucinata, da incubo. È come se combattessero un duello all’ultimo sangue, un affrontamento letale, nel tentativo di rubarsi qualcosa l’un l’altro, di sottrarsi delle parti di vita e di farle proprie, di rubare all’altro degli atomi, come potete leggere nel brano riportato qui sotto (e notate al verso 1113 la presenza di un verbo potente come abradere, “raschiare”, che ricorda l’abrasione, la ferita, la pelle lacerata o tumefatta). Qui non c’è mai tenerezza o commozione. Ci sono solo questi corpi che disperatamente cercano il piacere e a un certo punto si guardano incerti e smarriti, non capiscono nemmeno più cosa vogliono davvero, hanno perso la meta del loro desiderio. Perché di questo si tratta in Lucrezio: un desiderio senza oggetto, che vortica furioso su se stesso e non ha pace.
Quando finalmente riescono a congiungersi e godono del fiore
della giovinezza, quando entrambi presagiscono il piacere
e Venere è sul punto di seminare il campo della donna,
incatenano avidamente i loro corpi, mescolano le loro salive,
confondono i loro respiri, mordono a sangue le labbra.
Invano: non possono raschiare nulla dall’essere amato,
non possono penetrare in quel corpo con tutto il loro corpo,
come invece sembra pretendere il desiderio, che li spinge
a combattere, ferocemente avvinghiati nei lacci di Venere,
mentre le membra si sciolgono, fiaccate da un piacere violento.
Alla fine, quando il desiderio accumulato nei nervi si libera,
la loro furia scatenata conosce una breve pausa. Ma subito
torna la stessa rabbia, la stessa frenesia. Ne sono travolti,
gli amanti: cercano di capire cosa vogliono davvero,
ma non riescono a trovare un rimedio per questo tormento.
Sono smarriti. E si consumano così, nella loro ferita segreta.
(IV, 1108-1120)
Con il De rerum natura Lucrezio intende trasmettere e insegnare la filosofia epicurea. Eppure in questa sua opera sono presenti molte contraddizioni rispetto al pensiero del filosofo greco. Per esempio, se Epicuro vuole insegnare all’uomo come ottenere una vita serena dando una visione positiva della realtà, Lucrezio all’opposto riflette sul fatto che nel mondo non c’è alcuna provvidenza e l’uomo si trova a sopravvivere faticosamente, deve combattere contro le calamità della natura, le malattie e le bestie feroci, ovvero la natura non sembra proprio essere fatta per l’uomo, tanto che in alcuni suoi versi dice che il bambino appena nato piange perché bisognoso di ogni cura e quasi presagendo le disgrazie e i dolori che lo aspettano… Come ti spieghi questa apparente contraddizione con “la calma impassibile” del suo maestro Epicuro?
Si tratta di una contraddizione profonda e insanabile che percorre l’intero poema e che è stata oggetto di numerose riflessioni. Come spiega il grande latinista Luciano Perelli (Lucrezio poeta dell’angoscia, La Nuova Italia, 1969), da un lato il poeta si dichiara seguace di Epicuro e lo fa con un pathos apostolico, con un’adesione volontaristica e gridata. Ma dall’altra c’è qualcosa in Lucrezio che va nella direzione opposta e lo conduce ad esplorare zone oscure e tumultuose dell’essere, zone drammatiche e laceranti della psiche; lo conduce insomma ben oltre il messaggio di Epicuro, così infarcito di precetti e di raccomandazioni, così proteso a perimetrare la ricchezza ardente della vita dentro una contemplativa voluptas. Lucrezio è impregnato di questa aporia, che porta il nome del suo maestro, Epicuro. Per Lucrezio Epicuro è un pensatore immenso, l’unico in grado di smantellare l’edificio fraudolento della religio, uno spartiacque tra il bene e il male, ha diviso la storia in due stagioni: prima e dopo di lui. Eppure Lucrezio tradisce Epicuro, continuamente e fortunatamente. Già il fatto di scrivere in versi, e soprattutto di scrivere un poema, è una smentita alla dottrina epicurea, che condannava la poesia come portatrice di passioni superstiziose, tollerandola solo nella forma breve dell’intrattenimento: versi leggeri e divertenti, capaci di suscitare una facile edoné. Ma la contraddizione più significativa sta nell’essenza stessa del poema. Lucrezio dichiara di voler guarire con la sua opera l’umanità dal peso della paura, si accende di entusiasmo per Epicuro e per il potere rasserenante della sua dottrina, eppure il De rerum natura risuona continuamente di macabre, terrificanti e catastrofiche riflessioni sull’angoscia innata della condizione umana.

Lucrezio ha una visione tragica dell’esistenza e del destino dell’uomo. Tuttavia come scrivi nel saggio introduttivo: “Il tragico per esistere ha bisogno di luce e di gioia. Lucrezio conosce questa luce e questa gioia e dunque la caduta nel vuoto che descrive è ancora più profonda”. Spiegaci meglio…
Il tragico non ha nulla a che fare con la depressione e nemmeno con l’esperienza del lutto. Piuttosto riguarda il passaggio dalla luce all’oscuro, dal grido di gioia al grido di terrore. E d’altra parte Lucrezio non è una natura depressa. Tutt’altro: ci incalza continuamente con la forza e l’urgenza delle sue certezze, ci mostra – e mostra a se stesso – l’infinita potenza dei fenomeni naturali, del vento, del fulmine, della tromba marina, delle nuvole che ci sovrastano e incombono su di noi, delle vette altissime da cui possiamo ammirarle. Lucrezio possiede il senso dell’infinito e lo celebra continuamente. Per questo la sua caduta, quando avviene, è ripida, subitanea, verticale, senza scampo, lo conduce nei territori dell’incubo, fa deragliare all’improvviso la percezione naturale delle cose e le fa precipitare nella loro mortalità.
“Patrii sermonis egestas”, così Lucrezio definiva la lingua latina, che considerava non appropriata a trattare argomenti filosofici, a lui invece molto cari. L’autore risolve questo problema creando nuovi termini, nuove perifrasi o usa vocaboli latini con nuovi significati. Tutto questo rende la sua lingua viva e vigorosa…
Come spiega perfettamente Ivano Dionigi in Il presente non basta – la lezione del latino (Mondadori, 2016), la lingua latina per rimediare alla propria povertà lessicale ha inventato la callida iunctura, la quale potenzia ed estende il significato delle parole, intervenendo nell’ordo verborum e creando uno straniamento oppure unendo in un’unica espressione concetti contrastanti. E in questo è maestro Orazio, con la sua celebre aurea mediocritas o con la stenua inertia della prima Epistola. Anche Lucrezio, come lui, avverte l’insufficienza lessicale di questa lingua, l’origine agreste di tanti termini (compreso il “verso” della poesia, dal vertere dell’aratro che ritorna sul proprio solco) e cerca di ampliarla, arricchirla, affinarla, caratterizzarla con nuovi innesti. E lo fa in un altro modo rispetto a Orazio. Lo fa da una parte attraverso il recupero di parole arcaiche e dall’altra attraverso l’invenzione di neologismi come i termini composti di tradizione omerica (frugiferentis, frondifer) e soprattutto attraverso l’uso continuo dell’anafora, che mi ha davvero impressionato, con la ripresa martellante della stessa parola o dello stesso gruppo di versi in zone differenti del poema. Questo dice di una personalità ossessiva assai marcata e io per tante ragioni mi sento fratello di tutti i poeti ossessivi.
Per lo stesso motivo la sua lingua è piena di insidie per un traduttore. Quali sono stati i nodi più difficili da superare in questo tuo lavoro di traduzione?
Forse il nodo principale è stato mantenere in un verso italiano molto lungo (dalle quattordici alle ventisei sillabe) la potenza ritmica del verso latino, che si avvale di “strumenti” espressivi intraducibili, come i diversi tipi di cesura o le frequentissime allitterazioni. Ho così cercato di giungere a un equivalente italiano attraverso la maggiore o minore cadenza percussiva degli accenti: maggiore nelle parti più scientifiche, dottrinarie oppure oratorie e minore in quelle più liriche, con increspature, dissonanze, chiaroscuri e varietà di toni. Ma quello che più mi stava a cuore era rendere il testo latino in una lingua italiana viva, mobile, accesa e attuale, lontana dai troppi arcaismi delle traduzioni scolastiche, che immergono la poesia lucreziana nell’atmosfera stantia di una biblioteca polverosa, senza brio e senza guizzo.
Rispetto alle tue precedenti versioni – penso in particolare a Sotto la scure silenziosa uscita da SE nel 2005 – questa è senz’altro poetica ma non libera. Si avverte una maggiore fedeltà al testo, anche dal punto di vista filologico…
Il testo latino a fronte mi ha costretto a una maggiore precisione letterale, ma ho cercato di mantenere vivo il pathos della traduzione precedente, aggiungendo il pathos ulteriore insito nel verso e nell’andare a capo, cosa che prima mancava in quei trentasei frammenti del 2005, tutti in prosa: prosa poetica, certo, con una forte impronta prosodica, ma pur sempre prosa. Ho poi chiesto alla Mondadori di scrivere la prefazione e anche le note (faticosissime!) per mantenere l’unità stilistica dell’intero volume.
Tra i poeti “innamorati di Lucrezio”, come li definisci nell’introduzione, ci sono Shelley, Foscolo e Leopardi. La visione del poeta latino sembra avere plasmato soprattutto il pensiero di quest’ultimo, che non a caso nel suo “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” citando i versi 222-227 del libro V del De Rerum natura, dice: “Nasce l’uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa; e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell’esser nato”. Cosa lega Lucrezio e Leopardi?
Con Leopardi le analogie sono impressionanti e il discorso della Natura, nel terzo libro, sembra scritto dal poeta di Recanati, tanto viene sottolineata l’indifferenza della Natura riguardo alle sofferenze umane e tanto sono incalzanti e indiscutibili i suoi rimproveri alla sciocca vanità dell’uomo comune, che pensa di essere padrone della sua esistenza e si lamenta quando gli viene sottratta: “la vita è data in prestito a tutti ma non è proprietà di nessuno” (v. 971). E c’è un altro grande motivo che accomuna Lucrezio a Leopardi, ossia la ferma convinzione che l’anima è mortale e la ferma opposizione a ogni credenza religiosa sulla sua sopravvivenza e sul presunto giudizio divino. In entrambi la religio è sinonimo di sciocchezza e dannosa superstizione:
non c’è nessun dubbio: tutti i tormenti che la gente immagina
negli abissi dell’Acheronte avvengono in realtà nella nostra vita.
(III, 978-979)
Quali poeti del Novecento appartengono, per usare la tua espressione, alla “stirpe” di Lucrezio?
La cosiddetta “fortuna” di Lucrezio, ossia la sua eredità attraverso i secoli e i millenni, è una delle questioni più complesse e controverse della letteratura latina, anche perché il De rerum natura è stato a lungo ignoto e ignorato, prima del celebre ritrovamento del suo manoscritto ad opera di Poggio Bracciolini nel 1417. Tutti gli studiosi hanno sottolineato la sua enorme influenza durante l’epoca rinascimentale e nei secoli successivi, fino all’Ottocento di Foscolo, Leopardi e Tennyson. Pochi invece – forse nessuno – hanno osato andare oltre e indagare la sua presenza nella poesia novecentesca e attuale. Persino il libro di Lisa Piazzi (Il “De rerum natura” e la cultura occidentale, Liguori, 2009), che rimane la studiosa più informata in proposito, si ferma alle soglie del secolo scorso e si limita ad alcuni accenni ai tempi più recenti. Per quanto mi riguarda, ho tentato nella nota introduttiva di azzardare qualche nome, rendendomi conto che non era importante segnalare gli autori “curiosi” di Lucrezio, bensì quelli seriamente affini all’anima lucreziana. Voglio dire che anche Italo Calvino o Giorgio Orelli hanno fatto osservazioni acute su Lucrezio, ma non per questo sono davvero lucreziani, non per questo hanno celebrato delle nozze di sangue con il poeta latino, mentre credo che per esempio Cesare Pavese o Kostas Kariotakis abbiano accolto nelle loro profondità qualcosa di essenziale del suo messaggio.
Come Lucrezio ha invece direttamente agito sulla tua poesia?
Per un poeta sostanzialmente lirico quale io sono, Lucrezio è stato un maestro di prospettiva, mi ha insegnato il respiro ampio e poematico, il passo regolare del maratoneta, capace di affrontare le lunghe distanze, di cadenzare la sua corsa sul ritmo saggio e lungimirante di un traguardo lontano. Il mio prossimo libro sarà certamente un poema.