Chandra Candiani: imparare a morire
Voglio imparare a tremare, dice Chandra Livia Candiani. Voglio essere sveglia.
Parole coraggiose. Le stesse pronunciate da James Hillman negli ultimi giorni della sua vita: voleva stare sveglio, rimanere “pensante” fino all’ultima soglia dell’essere.
In questo nuovo, commuovente, lavoro, I visitatori celesti, la poetessa ci fa incontrare gli angeli della tradizione buddista che portano un messaggio che risveglia e apre a significati ignorati.
Chi sono questi visitatori celesti? Vecchiaia, malattia e morte. Quelli che tutti fuggono, che nessuno vorrebbe mai accogliere. Parole tabù.
C’è poi un quarto messaggero, un monaco errante – “chi dedica tutta la sua vita a percorrere il sentiero nascosto che porta a trascendere ogni sofferenza, a scoprire la realtà suprema” – che ci indica una strada diversa dalla rimozione.
Chandra ci aiuta a inoltrarci nella sconosciutezza: lontani dal mondo, vicini alla terra e al cielo.
Il bosco aiuta: “nel bosco è impossibile camminare senza vedere l’abbraccio aggrovigliato di vita e morte, la danza non macabra ma vitale dello scambio di visioni, di notizie, di moti”. Non si tratta di scappare dal mondo, ma di comprendere la complessità del nascere-vivere-morire-trasformarsi. Visto con uno sguardo antropocentrico, il bosco appare come un luogo violento, “ma se lo sguardo è decentrato e vede l’interdipendenza, l’indivisibilità di luce e ombre, di tenerezza e di violenza, la morte non si chiama più ‘morte’ ma ‘realtà delle cose’”. Lasciare andare, abbandonarsi. Difficile per noi occidentali che vogliamo avere tutto sotto controllo: l’assenza di azione, sforzo e prestazione ci spaventano.
Aprendo le pagine di questo libro dobbiamo essere disponibili a sentirne la vertigine, per poter raccogliere perle. Già in Il Silenzio è cosa viva la poetessa ci invitava a non aver paura, a non fuggire il dolore lasciandoci attraversare. In Questo immenso non sapere ci aveva invitato a guardare le ferite in un modo nuovo e fecondo: “non lasciarle sole, sperdute nell’idea fissa della medicazione e della guarigione. Bisogna interrogare le ferite e aspettare le risposte. La risposta alla ferita siamo noi. […] Perdere una ferita significa perdere una segnaletica importante per un viaggio dentro le orme dell’esistenza, un viaggio che ci accomuna e ci distingue”.
I visitatori celesti si presentano continuamente nelle nostre vite, sono mutamenti inscritti nella nascita, e ci chiedono di familiarizzare con loro “e hanno forma di briciole e frammenti, sparsi un po’ ovunque nel tempo e nello spazio del nostro vivere”. Ci presentano un’altra visione del sorgere, sostare, svanire. Quante cose finiscono in una giornata qualunque. Ascoltare e osservare i passaggi consente di vivere la morte in piccole dosi.
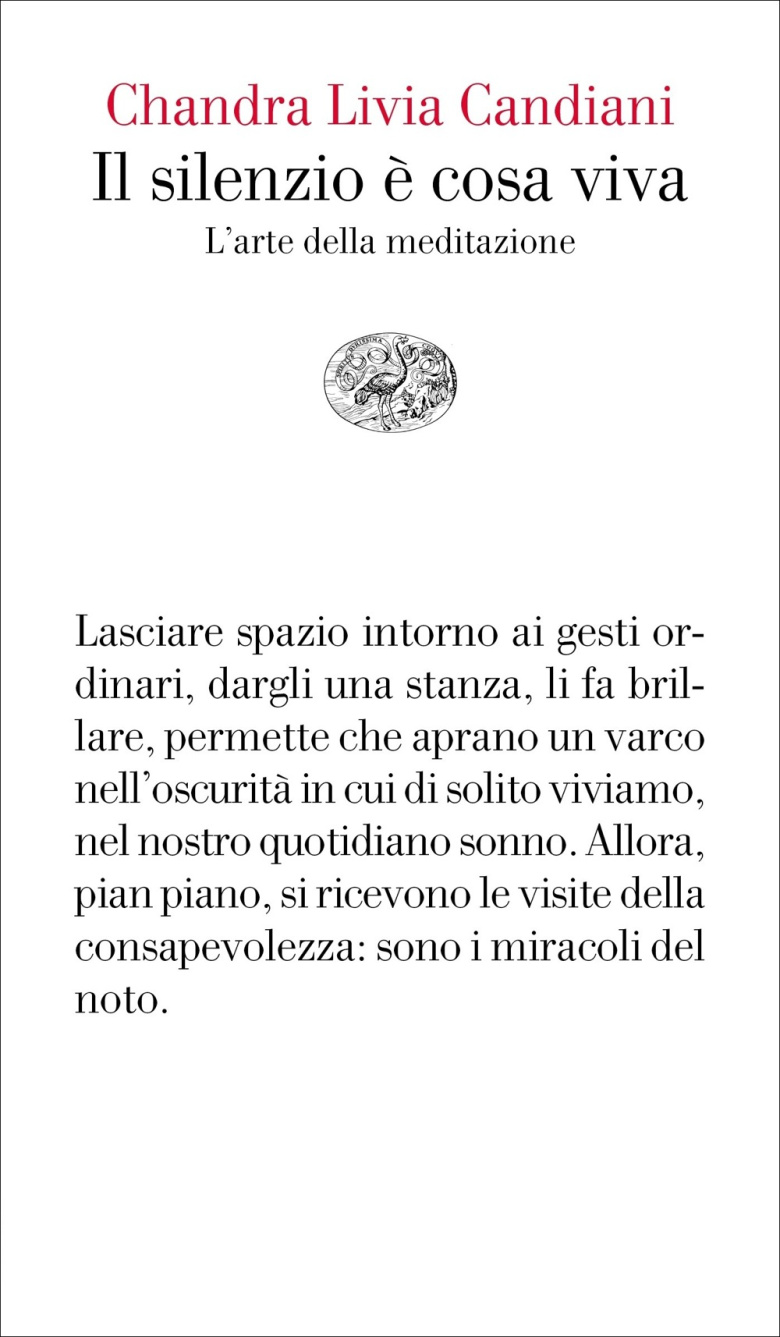
Ci siamo mai chiesti quale morte la vita sceglierà per noi? Scrive Delphine Horvilleur: “Potremmo dunque dire così: dopo la morte ognuno di noi cade nella domanda e lascia gli altri senza risposta”. Cadere nelle domande, “averle care”, come ha scritto Rilke; e Chandra lo segue: “occorre restare con il non-so, con l’ignoto che ci propone e ci invita a incamminarci. Il non-conosciuto è una Via su cui inoltrarsi”. Stare con quello che capita, i mulinelli della vita, anche il male, la malattia, i sintomi: “più entriamo in intimità con qualcosa e più sconfiniamo dai suoi bordi”, diventiamo il narratore silenzioso di noi stessi, e anche quello che scavalca la condizione in cui siamo: “Ascoltare se stessi è come ascoltare un gatto: si sa che qualcosa resterà per sempre misterioso […] è necessario imparare a interrogarlo, a saper stare nel suo silenzio e nella sua grammatica sensoriale di battiti, bruciori, strutture, evanescenze, fitte, spiragli, allagamenti, ghiacciai e incendi”. Quel che accade è che cambiano le nostre priorità, spesso contano cose piccolissime, e lo sfondo viene in primo piano, diventa figura.
Aprire il cuore alla sconosciutezza e ai drammi dell’umano, non rimanere chiusi e protetti nelle nostre certezze. Si narra che Siddharta, che aveva vissuto ignaro dei drammi della vita umana, uscito dalle mura del palazzo incontrò questi messaggeri che lo turbarono profondamente al punto da fargli lasciare il palazzo per inoltrarsi nella foresta della sua vita interiore. Bisogna perdere la propria vita per ritrovarla, dice il Vangelo, nello stesso modo in cui i sintomi – che ci fanno deragliare – ci chiamano a intraprendere la strada della ricerca interiore per scoprire la via verso il simbolo, che è nascosto e custodito dentro: “spesso la loro visita rimane solo un passaggio, un transito; sono considerati disgrazie da subire o da combattere”. Non riusciamo ad accogliere il dono della trasformazione “dell’invisibile continuità di senso”. Accogliere i sintomi come simboli di trasformazione.
Chandra ha saputo stare seduta come drago – dopo anni di psicoterapia e meditazione: “sentire il fuoco che brucia nel petto e in gola e aspettare, aspettare, ascoltando, assaporando il mio respiro infuocato”. Ha saputo ascoltare le ragioni del drago, farle sue, liberando il tesoro, il simbolo, facendolo cantare e trasformandolo in poesia. La ferita in fondo l’ha salvata. Le ferite possono salvarci, essere un’occasione. Perché questo accada non dobbiamo perderle ma interrogarle.
Come Milarepa con i suoi demoni: dopo aver fatto di tutto per scacciarli ci rinunciò, “dunque vivremo qui tutti insieme”. Se ne andarono tutti tranne uno. Allora Milarepa prese il demone, lo introdusse nella bocca e disse: “divorami, se è questo che vuoi”. A quel punto se ne andò anche l’ultimo demone. La morale della storia – scrive Chandra – è che quando se ne va la resistenza, se ne vanno anche i demoni. È l’integrazione dell’Ombra di cui ha tanto parlato C.G. Jung: lavoro necessario per non esserne posseduti e per non proiettarla sugli altri. Tutte le volte che ci assumiamo una parte di male, non resistiamo o non diciamo “è colpa sua”, il male si depotenzia.
I visitatori celesti sono intermediari tra i mondi, spesso sono “animali, alberi, creature minuscole e nascoste, esseri che non contano”. Chandra, come Anna Maria Ortese, è attenta alle piccole creature, al loro sguardo e al loro insegnamento, e si rivolge alle piante e agli animali. Conosce il loro linguaggio. Li ascolta. Chi vive vicino alla natura lo sa. Un giardiniere, alla mia ingenua domanda se il fico piantato da qualche anno avrebbe fatto i frutti l’anno seguente, mi ha risposto che bisogna chiedere al fico cosa vuole fare. Tutto ha voce. Può essere un rospo raccolto sulla strada, falciato dall’urto di un’auto, che mentre Chandra raccoglie dall’asfalto e depone sull’erba “a riposare e a disfarsi”, grida: “Chi mi sta amando?” Lei risponde con la stessa sprovvedutezza con cui aveva accompagnato i suoi cari alla soglia: “Il mio compito è restare, il tuo partire. Abbandonati”. Un corpo sente di essere amato se la nostra intenzione è di onorarlo anche solo seppellendolo, anziché abbandonarlo. Abbandonarsi insieme a quello che per entrambi era mistero.
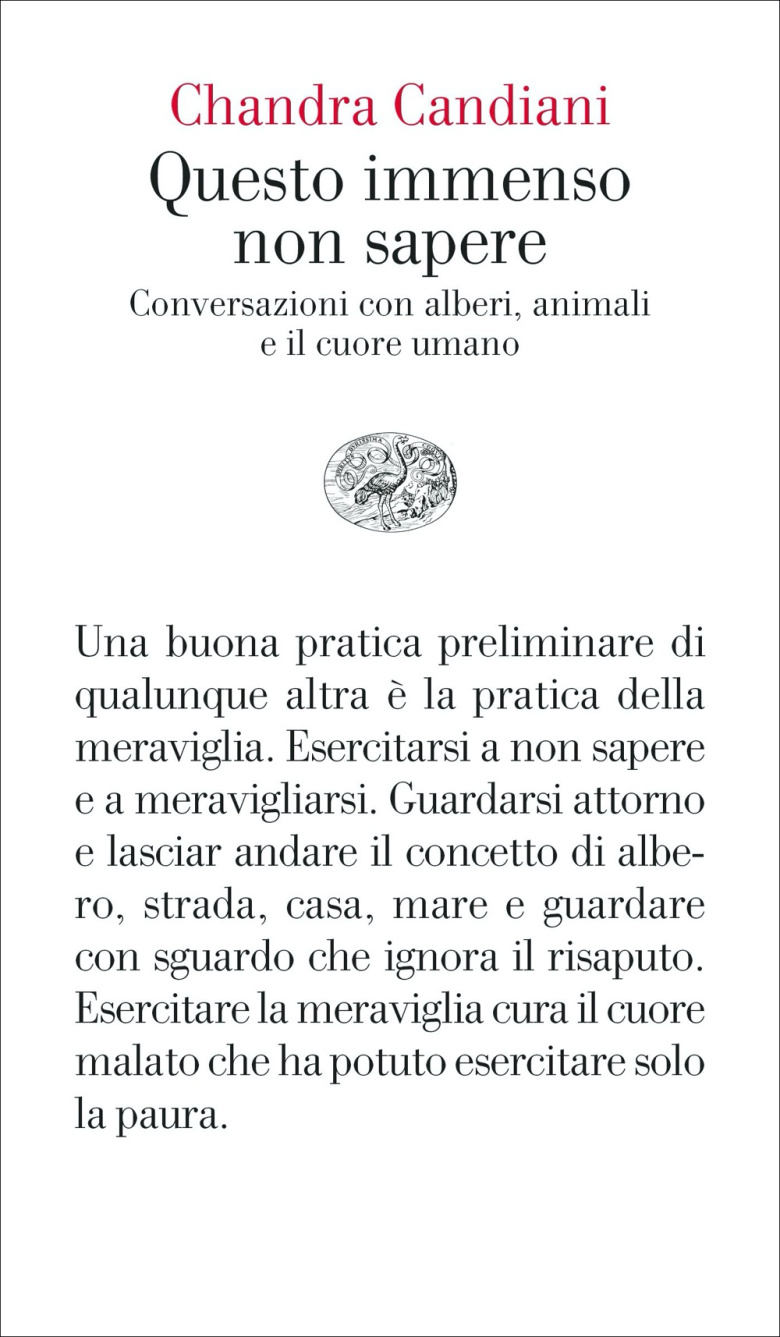
La morte è un altro genere di nascita, scriveva la poetessa in Il Silenzio è cosa viva. “L’ho visto, non solo nel corpo di chi muore che così spesso diventa simile a un feto, ma anche in chi resta, si nasce di nuovo, si cambia pelle.” Quando veniamo a questo mondo lasciamo una pelle – la placenta – perché il nostro corpo possa nascere. Forse morendo lasciamo la nostra pelle-corpo perché qualcosa d’altro possa nascere altrove? Si interroga, e ci interroga: “perché dovrebbe essere meno misterioso il manifestarsi della dissoluzione?”
Chandra ci riporta al tempo ciclico della natura, perché la ciclicità “inietta a poco a poco nel sangue l’idea del ritorno, la sensazione attesa del letargo e del risveglio”.
Questo nuovo lavoro in prosa, che profuma di poesia, costituisce, a mio parere, una sorta di trittico, insieme a Il Silenzio è cosa viva e Questo immenso non sapere. È prosa in forma di romanzo aperto perché domanda. Frammenti. Perché su certi argomenti possiamo solo provare a dire, balbettare: “Scrivere della paura, scrivere in poesia, la lingua delle schegge, dei frammenti, mi ha reso immaginabile l’inimmaginabile, togliendo peso, ha ridato gravità”.
I Visitatori Celesti si possono leggere aprendo la pagina e scegliendo un paragrafo, come fosse una poesia. La vita di Chandra diventata un libro di testo, anche per noi. “L’autobiografia non è quel che facciamo della nostra vita ma quel che la vita fa di noi”. Sapersi fatti dalla vita, scritti dalla vita. Si fa servitrice di “una fatica di vivere e di comunicare che disegna fragili sentieri verso il male di vivere degli altri, sgomberando le reticenze e i giudizi delle cornacchie interiori”. Parole vissute, incarnate, scolpite, legnose, dove contenuto e contenitore coincidono come nell’alchimia. Questo è già cura, perché crea una risonanza, una vibrazione che muove e commuove. Il modo in cui dico la cosa, cambia la cosa.
Chandra trova parole delicate e poetiche sulla vecchiaia.
Quando confessa la sua paura a un tronco di ciliegio, paura di fare un viaggio per un dolore alla schiena, il ciliegio, rimasto un po’ in silenzio, le ha poi detto: “imparerai la vita delicata”. Quella lezione l’ha accompagnata per tutta la vita. Il corpo, invecchiando, diventa sempre più inabitabile, ma questo, forse, non è solo un male, è un modo per accompagnarci più o meno gentilmente all’uscita? La progressiva inabilità del corpo ci spinge a lasciarlo, come una madre uccello porta al bordo del ramo l’uccellino e con una spinta di sussurra “e adesso, vola”.
Ci abbiamo messo molto tempo per imparare ad abitare il nostro corpo. Morendo – si chiede la poetessa – dovremmo lasciare la tana del corpo. Cosa sentiremo allora? “Forse la coscienza è oltre il corpo, noi siamo più del corpo. Quando respiriamo consapevolmente, possiamo seguire l’espirazione, seguire il respiro che lascia il corpo e percepiamo anche la pausa dopo ogni espirazione e inspirazione e siamo vivi lo stesso, anche in assenza di respiro”.
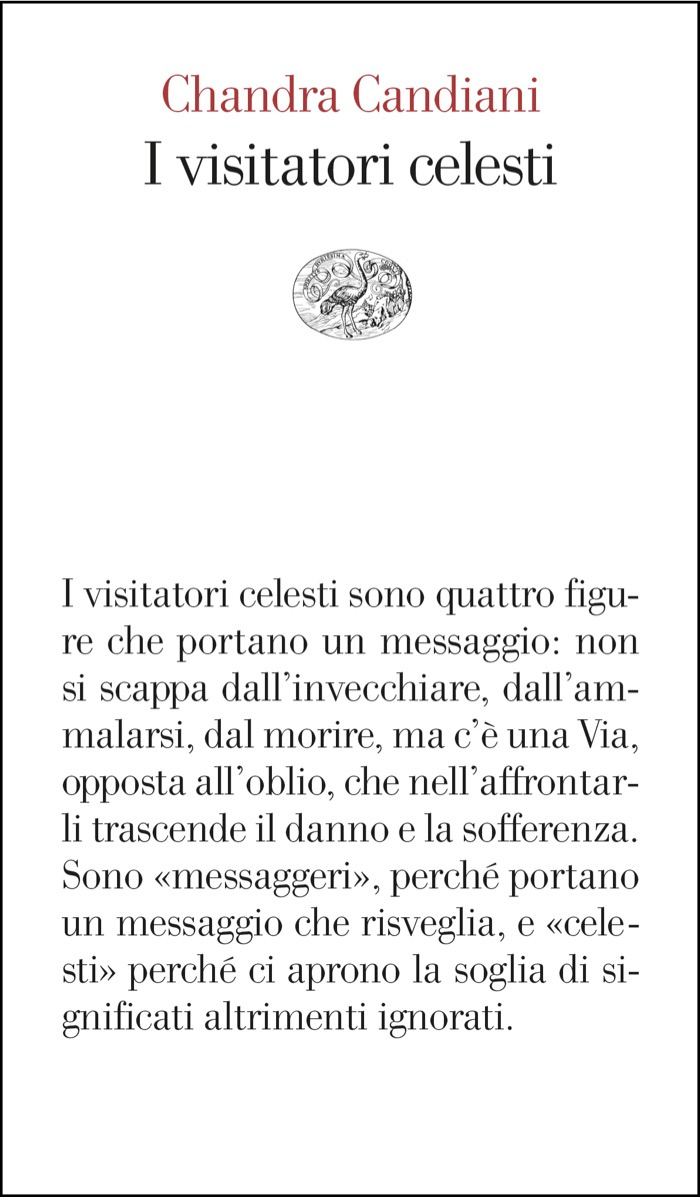
E dopo la morte c’è quel che non sappiamo, e lì “ecco, qui mi sento a casa, la vastissima casa del non-sapere. E mi accuccio”.
Sostituire la corsa verso la meta, al galleggiare verso la fonte, assecondando la corrente.
La sottrazione, e scoprire un nuovo vuoto, può far battere il cuore. Assaporando qualcosa che di solito scartiamo il cuore salta su un abisso.
Nell’affresco di Giotto la Crocifissione nella cappella degli Scrovegni si trova un angelo in volo inarcato all’indietro. Il suo volto è segnato da una smorfia di dolore e le mani scostano la veste come per aprire il petto, per donarlo alla perdita, renderlo più vasto per ricevere il male dell’addio.
Il cuore si deve fare vasto per accogliere il dolore. La vecchiaia non sa di più ma contiene di più. Chandra le attribuisce uno sguardo largo, contiene alberi, animali, rospi, caprioli, cervi e anche “le persone che non sanno fare, che faticano vivere, e gli arroganti da calmare”.
I vecchi sono come i poeti che non trovano le parole. Con parole straordinarie Chandra parla dell’angoscia che si prova quando i nomi non si ricordano più. “Fa spavento. Ma ho cominciato a non cercare disperatamente il perduto e sostare invece ai bordi dell’abisso buio, della cortina di silenzio […] fa sentire diseredati, strappati via dalla terra del linguaggio, soli davanti a un nero fitto”. “Ci sarà un tempo senza parole?” Come quando da neonati, non sappiamo nominare le cose? Cosa resterà? Nascerà un nuovo linguaggio? Sarà poesia? La poesia cerca le parole, e abitua alle “veglie disperate davanti alle parole che non visitano”, sarà così nella vecchiaia?
Forse questo vacillare della coscienza ci avvicina più al mondo vegetale e animale. Ci rende più aperti e spaziosi. Uno sguardo che ci fa guardare all’afasia dei vecchi in modo nuovo: la mia mamma, quando non trova le parole, ne inventa di nuove, le usa in modo bizzarro. È poetica.
“La vecchiaia non è di per sé saggezza; è l’interrogazione […] Non subire la vecchiaia e non negarla, ma interrogarla, sbucciare il suo guscio spinato e duro, accucciarsi in ascolto”.
Quale ascolto? È possibile ascoltare bene solo quando si tollera di non capire: “ascoltare una voce dice di più della persona che ascoltiamo che non ascoltare il contenuto delle sue parole, ci connette con un sottotesto che permette un ascolto più profondo”, scriveva in Il Silenzio è cosa viva.
Siamo stati traditi abbandonati e feriti milioni di volte, eppure esiste, scrive Chandra, una fiducia originaria che canta nelle cellule e ci visita: “ma senza aprirci al dolore, al suo misterioso bussare e radere al suolo, non possiamo nemmeno aprirci alla trascendenza […] l’impero della chiarezza, della ragione, ha tolto accesso alle verità del buio, del sogno, dell’assenza, dell’oscuro. Una perdita terribile che ci sottrae vastissime zone del sapere, dello sperimentare, del vivere pienamente”.
Questo nostro mondo ha bisogno della capacità negativa, di cui ci ha parlato il poeta John Keats, di saper attendere, qualità essenziali di cui anche un terapeuta deve essere capace. Il vivente implica il negativo. Tutto è occasione di trascendenza. Dice la poetessa: “il vero miracolo non è la guarigione ma sapere come stare con il male”.









