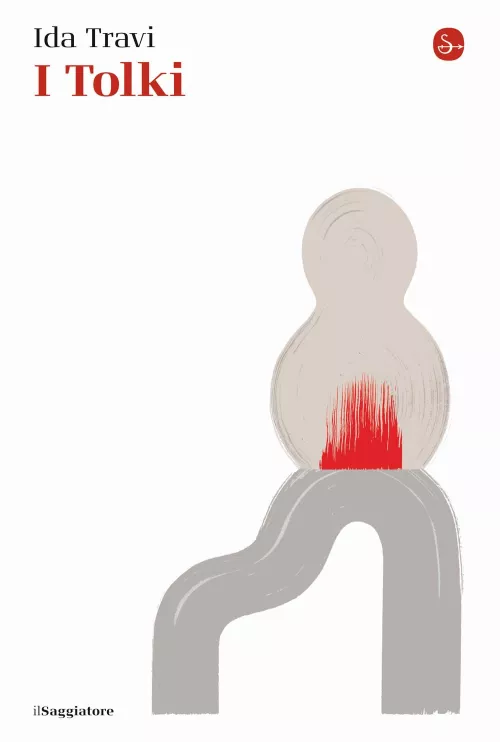Ida Travi: come saremo mille anni fa
“Proiettati sulla terra da qualche amore” – otto libri in uno, oltre quattrocentocinquanta pagine di poesia – i Tolki di Ida Travi sono usciti quest’anno in un’unica raccolta e hanno vinto due premi, il Napoli e il Dessì (Ida Travi, I Tolki, Il Saggiatore, Milano, 2024).
Aggregatisi nel corso di tre lustri – il primo libro, Tà. Poesia dello spiraglio e della neve, era stato pubblicato nel 2011 per Moretti & Vitali – gli otto libri costellano oggi l’esperimento in atto di una singolare “serie” poetica. Una “speciale cinematografia” in cui figure e sequenze, pur dandosi ripetutamente a vedere, restano a qualche grado inaddomesticabili rispetto alla categoria dell’identità e alle coordinate dello spazio e del tempo: “così come fu nel Mito”, scrive l’autrice nella nota introduttiva, “episodi indifferenti alla successione, così come a un inizio e a una fine”.
Certo il volume dispone di un suo ordine manifesto che fa strada al lettore come la torcia nella sala buia di un cinema: non solo gli otto libri si susseguono con espliciti e impliciti rimandi, ma sono anche preceduti da una lampeggiante prosa introduttiva che, via via, tiene la rotta custodendone il mistero.
Chi sono, dunque, i Tolki? Da dove vengono? Quale azione poetica, o atto politico, li ha sospinti fino a noi in forma di scrittura?
Reiterati e fulminei sono gli “scatti” con cui Ida Travi ci ha rese familiari, nel tempo, queste figure “sacre e miserabili”: “post studenti, ex-lavoratori, viandanti. Uomini e donne trasfigurati dalla poesia”. Sembrano una famiglia ma non lo sono, piuttosto si tratta di “solitari vaganti da un libro all’altro, in un tempo che va dal bianco allo scuro. (…) Si muovono in una specie di bagliore cementato in grigio. (…) Aspettano, ma cosa?”. Per certo i Tolki abitano un “fuori zona” del tempo convenzionale e da lì si arrischiano nel nostro presente: “sentivo forte il peso del tempo, l’impero dell’ora, dell’attualità come istante da cui prendere congedo. Sentivo l’ala contemporanea volare avanti in un disastroso consumo, assistevo a una continua comparsa e scomparsa di merci nell’attimo, libri compresi”. Sulla scia di questa ricerca, che sogna una parola “fuori dal consumo”, viene proprio da pensare come un Tolki e chiedersi:
Ma quali provviste, Olin
La merce siamo noi
noi siamo la merce che può fare acquisti.
Una neve perenne imbianca queste pagine fino a silenziare ogni sguaiato tentativo di confezionare le emergenze umane in pseudo-miti. Qui, tra i Tolki, ci troviamo in “una continua rinuncia”, e “più la parola è poetica – cioè autenticamente politica – più stretta è la porta da cui riesce a passare. Stretto è il passaggio da cui esce la parola, stretta è la parola finché qualcuno non la spalanca in chiacchiera” (Poetica del basso continuo, Moretti & Vitali). Stretti e misteriosi sono, del resto, gli accessi dischiusi da quest’opera. Interstizi sensibili alla grazia e prodighi di altrettante vie d’uscita, varchi che ogni lettore può trovare da sé: “ognuno salverà il libro trovando un suo montaggio” (Poetica del basso continuo).
Ecco, allora, un’ipotesi di montaggio che combina provvisoriamente alcune delle immagini parlanti evocate dai Tolki: la funzione benedicente del nome proprio; il disarmo intellettuale; il risveglio della coscienza al cospetto del bambino e dell’animale; il baluginare della redenzione.
Quali aperture configura, per cominciare, l’onomastica poetica di Travi? I Tolki “vivono incollati al loro nome”, scrive l’autrice nel secondo libro (Il mio nome è Inna. Scene dal casolare rosso). È Inna il primo “parlessere” che proclama il suo nome proprio, ed è lei che fa apparire il nome collettivo della banda trasognata: “‘Chiamiamoci Tolki’, disse. ‘Noi siamo i Tolki’. Disse i Tolki perché ricordava l’antica parola inglese talk”. Prima di ogni inscrizione sancita dal patronimico, i nomi propri dei Tolki paiono emergere, uno per uno, dal battesimo della lingua materna, a un passo dal vocalizzo festoso, a un passo dall’abisso dolente:
I nomi scrosciavano, io cercavo
d’asciugarli col respiro
Stringevo i lacci, li stringevo
come una pazza, per necessità
solo per un pettine d’osso
per un grembiulino decente
Su per la nebbia d’argento
sopra la testa di Sàr, correva
correva – fulmine altissimo –
la nostra bianca infelicità.
Ricevere il nome dalla voce creatrice mantiene i Tolki in una provvisorietà costitutiva, li aiuta a “scendere dall’affresco” dell’intitolazione:
“Me ne stavo addossata al muro
E ora sono scesa dall’affresco”.
La protezione del nome non rende i Tolki semplicisticamente e definitivamente buoni: incappano, pagina dopo pagina, in ogni sorta di micro-incidenti apocalittici, agiscono e accusano prepotenze, patiscono l’indifferenza degli dèi, nessuna crudeltà umana risulta loro estranea. Ma non giungono mai a pietrificarsi in un codice. Continuano a pulsare, e di tanto in tanto a pregare e a rinascere, nelle scalfitture del testo. Non a caso, chiamandosi per nome, si rivolgono continuamente domande e non concludono mai il discorso: “Zet, cosa può fare / la prima della fila / che riparo ha?”; “Cosa cerchi, Vre, con la testa / tra le nuvole, con le nuvole / in testa… cosa cerchi Vre?”; “Sullo schermo passano i nomi / ti ricordi i nomi, Kraus?”.

Talvolta si radunano in tanti, sulla pagina, a formulare l’interrogativo:
“Zet, Sunta, Kraus, Katarina…
E Os, e Ur, e Lisabeta, e tutti gli altri
E Dora e Inna, Antòn,
e il piccolo Sasa, dove?”.
Dove? Fino a quando? Una pietà instancabile curva le domande dei Tolki e forma un arco – baleno! – tra memoria e profezia. Giungono a noi i respiri - mai ingessati in busto, mai “morti in testa come un cappello” – delle maestre e dei maestri indiretti della poetessa: Omero, Eschilo, Julia Kristeva, Meister Eckkart, il Tao e chissà quante altre e altri (L’aspetto orale della poesia, Moretti & Vitali). Notiamo, allora, che la devota ed esercitata intimità dei Tolki col mistero del tempo – finitudine e infinitezza –, dismette la recitazione dei nomi illustri, smorza ogni appetito di sovranità intellettuale: “Dì pure al tuo caro cugino / che non mi interessano i discorsi, / preferisco parlare coi cani”. Il “cugino”, che da alleato della panica quest giovanile si è trasformato in maschera accademica, è il sembiante che abbiamo già incontrato in prosa: “Mettiti comodo, cugino, qui, sul gradino, dove un tempo parlavamo con gli dèi. (…) Tu hai avuto la tua celebrità. Tutti quegli scritti, tutti quegli allievi… (…) non ti ha spinto troppo lontano quel continuo parlare a ritroso, quel continuo voltarti indietro senza guardare il tempo, senza vedere veramente il paese?” (Poetica del basso continuo). Quanti “cugini” (e cugine) hanno voltato le spalle al senso del tragico per sottoscrivere l’installazione?
E dillo al tuo caro cugino. Se torna
deve inzuppare le fasce nel pianto
una per una, deve inzupparle nel pianto
le bianche lunghissime fasce, tutte nel pianto.
Non si tratta di stagliare il dolore contro il sapere, ma la libertà del pensiero sorgivo di Travi tesse un ponte nuovo tra studio e scrittura, tra teoria e voce, tra intelletto e amore; un ponte che unisce lo sgomento dei viventi al “linguaggio-benda” della poesia: “In basso, nel pericolo e nella fragilità comincia la rivoluzione del linguaggio poetico. (…) È il linguaggio più vicino all’agire. Lì succede qualcosa… (…) C’è qualcosa di vivente” (Poetica del basso continuo).
In un capogiro di dolorosa bellezza ci sono, infatti, l’infanzia e l’animale. Un libro dopo l’altro assistiamo a una sorta di infant-adult-animal observation insieme etologica e spirituale che non cede a dogmi psicopedagogici né a scorciatoie sentimentali.
E cosa hanno, in comune, l’infanzia e l’animale? L’essere in balìa, l’essere sempre a rischio di sacrificio per mano dell’adulto corazzato:
Il bambino e l’animale
sembrano fratelli, sono uguali
aspettano così tranquilli
Li chiamo e non girano la testa
sono d’oro, sono nel tempo d’oro
io non li stacco dalla loro eternità
Dovrebbero farci scuola, dovrebbero
dirci cosa c’è nell’oro
perché io l’ho perduto l’anello
e tu?
A registrare la maestà dell’infanzia è la forse giovane Katrin, l’“abitante” e “paziente” del terzo libro: “E adesso?”. Messa all’angolo da questa domanda iniziale “Katrin si raccoglie in preghiera”, “la testa si china appena / sopra il colletto nero / sopra le mani giunte”. Perché è difficile prendere atto del miracolo del bambino quando non si è la madonna: “La vedi quella nuvola nera? / quella è la nuvola di Katrin”. I fantasmi, i terrori e le suppliche di un’acerba “funzione materna” sembrano darsi appuntamento nel libro di Katrin e farci segno come “saluti dalla casa di nessuno”: quanta solitudine può circondare una culla! Neomadri e capostipiti “ripetono il canto” della nascita e dell’accudimento, della folle fatica e della folle pena, della colpa e del riscatto. Ogni pagina un baratro, ogni verso un orlo che salva:
I figli sono fiori
Un giorno si levano il berretto.
Non sfuggono, al misericordioso grandangolo dei Tolki, le vicissitudini delle generazioni, la caduta all’indietro, il risvegliarsi nel buio. Cosa avviene, per esempio, nel libro Marie. Canta la famiglia del secolo. Il settimo libro dei Tolki, i parlanti (il sesto s’è perduto)? Qui vive la sempre odierna famiglia del “non sappiamo chi siamo” in cui il babbo Vlad “non è altro che lo zio Vlad”, la madre Lisabeta “non è altro che la prima cugina”, Os è “solo il patriarca” e Zet è il fratello “che poi non è nessuno”. Cosa impedisce alla “famiglia del secolo” di riconoscersi nella discendenza? Perché non vi appaiono i bambini? “Qui nessuno sa più cos’è un documento (…) si fa presto a dire sono un Tolki, un parlante, ma poi bisogna vedere dove sta scritto”. Nella silloge successiva, Muscèt parla col cane, si prova forse a trattare questa estraniante amnesia transgenerazionale riammettendo l’infanzia e l’animale. Vi “sta scritto”, infatti, che i suoi piccoli protagonisti, Muscèt, il cane Rot e un bambino, sono idealmente “residenti” nel sesto volume, nel libro di cui si è persa memoria. E vi sta anche scritto che il nome Muscèt s’intona alla tredicenne protagonista di Mouchette, tutta la vita in una notte, il film di Robert Bresson.
Sì, tutta la vita può sprofondare in una notte se qualcuno non la scrive. Se qualcuno non la legge.
Allora leggiamo in lungo e in largo, avanti e indietro, leggiamo anche a ritroso sulle tracce di Tasàr. Animale sotto la neve, libro quinto. Rifugiati tra queste pagine troviamo alcuni giovani e meno giovani Tolki, l’asinello Tasàr, un cane e il bambino Antòn che “ha l’occhio fondo come l’animale”. È importante tornare al libro di Tasàr per riorientarsi ogni volta, per rinascere alla carità. Ci aiuta Sunta, una donna a metà della vita, che sembra conoscere con chiarezza struggente molte impossibilità e alcuni spiragli. “Ogni tanto, nello stridere degli uccelli, nel loro volare basso, scorre tra queste oscure creature un fremito felice. (…) È un sussulto, un salto, come il risveglio d’un bambino. Il bambino porterà la conoscenza”.
Lungo tutta l’opera si inseguono i sussulti del ravvedimento, speranza cosmica e minuscola, il baluginare della redenzione. Certo “sarebbe troppo comodo se Dio si occupasse di tutto”, recita qualcuno nel “borgo scuro”, cioè nella prosa introduttiva all’ultimo libro, Janì. L’ora della cancellatura. Anche “nell’ora della cancellatura”, quella che mostra più crudamente la strettoia dei tempi (si sentono scricchiolare le assi, si sommano le raffiche, i tumulti, le dichiarazioni di guerra), occorre aiutare Dio quando “bussa la luce”: appare “uno venuto col suo ramoscello / camminava che pareva il messia”, appare Fontén ansimando: “scappate, scappate” (Un condannato a morte è fuggito, ancora Bresson, 1956). E appare un uomo, sbucato di corsa dalla campagna. Dice: “ecco la vergine alzare il suo sguardo infantile /sopra l’umana vergogna”.