Jung e il suo doppio
Che farai, Dio, se io muoio?
È un testo “straordinariamente complesso, e vi regna un caos infernale”. Così esordì Jung alla prima conferenza del suo seminario su Così parlò Zarathustra di Nietzsche, tenuto a Zurigo dal maggio del 1934 fino al febbraio del 1939 quando i venti funesti che annunciavano la Seconda Guerra Mondiale ne imposero la conclusione anticipata. Aperto a una ottantina di partecipanti di diversa nazionalità e professione, scandito in 86 conferenze bimestrali la cui trascrizione copre quasi 1700 pagine (C.G. Jung, Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario tenuto nel 1934-1939, Bollati Boringhieri, Torino 2011-2013), il seminario vide Jung misurarsi in un palpitante confronto con lo stesso filosofo che, appena oltrefrontiera e proprio in quegli anni, veniva spacciato dal nazismo come il profeta della propria delirante ascesa.
Cimentarsi nel seminario sullo Zarathustra significò, dunque, per Jung, “un immane tentativo di esorcismo nei confronti della minaccia che incombeva allora sull’Europa e sulla civiltà occidentale” e rappresentò lo sforzo “per certi versi eroico di confrontarsi con un interlocutore cruciale come Nietzsche”. Così Paolo Paolozza, nel suo recente libro Jung e il suo doppio. L’ombra del funambolo nei seminari sullo Zarathustra di Nietzsche (Castelvecchi, 2022, da cui provengono tutte le citazioni non altrimenti segnalate), ci introduce a una originale rilettura dei temi portanti che, attraverso il commento analitico di Jung, possono aiutarci a illuminare alcuni nessi tra i mutamenti disgreganti ed epocali profetizzati dal grande filosofo tedesco, il confronto con l’inconscio sviluppato dalle psicologie del profondo, in particolare dalla psicologia analitica, e l’inquietante scenario planetario per come oggi arriviamo a percepirlo, a temerlo e a immaginarne una cura.
Il percorso narrativo scelto da Paolozza si snoda in una concatenazione sintetica e fluida di più livelli riflessivi: c’è il piano dove ci presenta alcune delle figure incontrate da Jung nelle pagine magmatiche dello Zarathustra: il vegliardo, il superuomo, il funambolo, il pagliaccio, il pazzo, assieme ai vertiginosi costrutti del tramonto, dell’ultimo uomo, della folla inerte, del “sì” alla terra, delle “colonne di fuoco”; c’è il piano delle corrispondenze possibili tra le teorie centrali di Nietzsche e le teorie centrali di Jung alla luce della loro vita vissuta: morte di dio e Sé; superuomo e individuazione; volontà di potenza ed energia psichica totipotente; eterno ritorno e archetipi (Cfr. R. Màdera, Jung e Nietzsche, in A. Carotenuto, a cura di, Trattato di psicologia analitica, Utet, Torino, 1992); c’è, infine, il piano degli interrogativi “attuali” dell’autore, psichiatra e psicologo analista, che riflette sull’orizzonte di senso che il “caso Jung”, al cospetto del “caso Nietzsche”, configura e consegna al nostro tempo in una prospettiva etica e spirituale capace di fare i conti con l’inconscio e con l’ombra, “al limite fra filosofia e psicologia” (p. 59).
Ad arricchire la ricerca, dopo il capitolo conclusivo, la sorpresa di “un libro nel libro”, quasi ottanta pagine di note ragionate per chi desideri inoltrarsi nella rete dei rimandi fittissimi implicati dalla pluralità di saperi che si addensa nei seminari. Qui, effettivamente, Jung spazia, in tono colloquiale e con erudita passione, dalla filosofia all’alchimia, dalla storia delle religioni alla letteratura, dall’antropologia alla mistica e sempre sostenendo il suo discorso teorico con una messe copiosa di esempi tratti dall’esperienza quotidiana e dalla pratica analitica tra frammenti di storie cliniche, smascheramenti di pregiudizi del senso comune, riletture di sogni propri e altrui, connessioni tra eventi storico-politici e dimensioni inconsce della vita collettiva.
Già dal primo capitolo, intitolato “Vigilie”, al plurale, Paolozza ci porta a sentire la tormentosa risonanza che in Jung dovevano suscitare le più ustionanti anticipazioni e intuizioni nietzschiane; ci segnala, infatti, come su di lui pesasse, sin dall’inizio dei seminari sullo Zarathustra, il ricordo di una precedente, drammatica congiuntura: quando, alla fine del 1913, egli aveva dato forma al turbato presentimento della Grande Guerra nelle prime visioni di Il libro Rosso. Da una “vigilia” all’altra “sembra quasi che egli abbia coltivato la speranza di non trovarsi di nuovo impreparato all’approssimarsi della tempesta incombente”, scrive Paolozza. “Leggere questi seminari può aiutare a comprendere il senso di un tentativo disperato di mantenere accesa la luce della coscienza, di porre una diga alla morte e alla sofferenza” (p. 7-8).
Ed è qui il caso di sottolineare che tali “vigilie” furono rese particolarmente “vigili”, per Jung, proprio dal confronto costante, coltivato sin dalla giovinezza, con le opere di Nietzsche, con la vita e con la personalità di Nietzsche, con il fuoco epocale acceso dalla penna di Nietzsche e divampato nel secolo breve come denuncia conclamata della “morte di dio”.
Il serrato “anima ad anima” tra i due giganti, del resto, non illumina soltanto il buio degli anni e dei giorni – “troppo vicini, troppo lontani” – in cui il seminario si svolgeva; leggerlo oggi significa cogliere i bagliori che quella ricerca ancora propaga sul tempo presente, sull’umanità che dunque siamo, quella della pandemia, del disastro ecologico, delle guerre vicine e lontane: “il fascino della trascrizione di quegli incontri sta forse anche nell’intreccio di destini che sembra giungere fino ad oggi, intatto, come un annuncio del terribile alle porte” (p. 7). Nell’estensione temporale di tale intreccio, pervasa di inquietudine, ricordi e presagi, Paolozza disegna un asterisco autobiografico nel quale tanti della sua e della mia generazione potranno riconoscersi: “Devo ammettere che il mio primo contatto emotivo con quell’annuncio fu dovuto a una canzone degli anni Sessanta intitolata, appunto, Dio è morto.
Ero un ragazzo ed ebbe su di me un effetto potentissimo. Non avevo ancora studiato Nietzsche, in seconda liceo, e fu Guccini a bucare la corazza della mia educazione cattolica e borghese” (p. 9). E forse, come Paolozza si augura, Nietzche non “si sarebbe adontato nel vedere riproposta la sua sentenza” in uno scenario musicale e giovanile del Novecento. Perché la caratteristica di Nietzsche è quella di “filosofare in una dimensione più ampia di quella puramente filosofica”, di guardare “al mondo nella sua esistenza variegata (…), agli orientamenti sociali, artistici e culturali più vari, al sentire quotidiano dell’uomo europeo”; di “cogliere sinteticamente e creativamente il senso unitario di eventi disparati altrimenti non relazionabili”; e di poter intercettare, sebbene attraverso il paradosso di una solitudine totale e di un “filtro apparentemente unilaterale del mondo”, lo spirito del tempo (p.19-21).
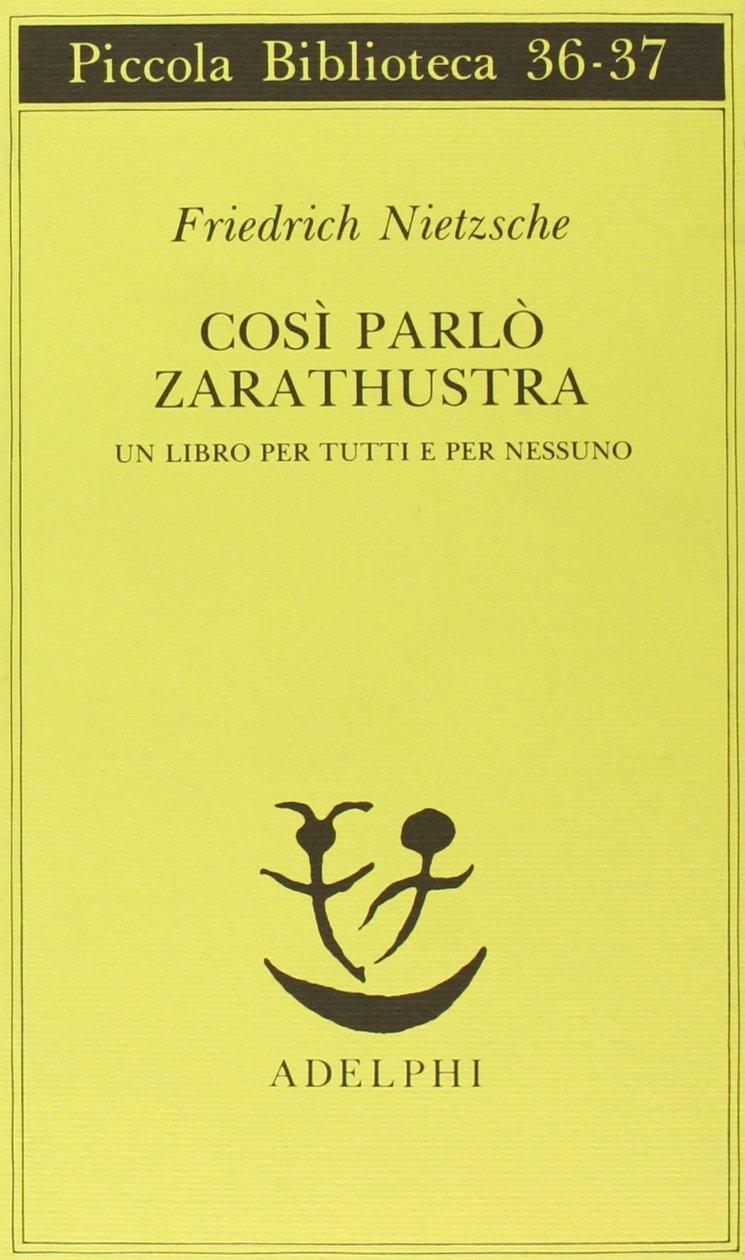
Del resto è proprio nell’intersezione consapevolmente lavorata tra circostanze storico-biografiche e confronto con l’inconscio che Jung situa le sue risonanze e le sue obiezioni – talvolta feroci – a Nietzsche; una fascinazione, e al tempo stesso una tensione atterrita e pervasa da dubbi perché, dètta nelle sue memorie, “mi tratteneva il celato timore che potessi somigliargli” (nota 18, p.91). È, d’altra parte, quello di Jung e Nietzsche, un terreno comune – erano entrambi figli di un pastore protestante – ciò condizionando intimamente il loro “legame con il cristianesimo della Riforma e con la crisi di questo riferimento nel mondo moderno, fino alla sua progressiva uscita di scena di fronte all’emergere estremo della soggettività come orizzonte dell’umanità contemporanea di cui pure la Riforma aveva rappresentato una tappa fondamentale (p. 25). “Una circostanza familiare”, osserva Romano Màdera, che “rimanda a problemi che caratterizzano un’epoca intera. (…) Jung come Nietzsche aveva sperimentato che il mondo cristiano nel quale il padre si sforzava di credere era ormai privo di vita, ridotto a parole e riti sclerotici, vuoti di senso” (nota 18, p.91).
Jung riconosce, insomma, di condividere molto con Nietzsche ed “è difficile sottrarsi alla suggestione che il destino di quest’ultimo rappresenti l’Ombra della vicenda junghiana”, scrive Paolozza al cuore della sua riflessione su “Jung e il suo doppio”. Soprattutto se si giustappongono le loro due distinte esperienze di vita: Jung “ebbe una madre sufficientemente buona, non fu allievo di un collegio come quello di Pforta (dove massacrarono l’adolescenza di Nietzsche), si radicò nella medicina e non nella filologia e poi in un lavoro che lo mise a contatto con una realtà umana e con possibilità culturali e pratiche alle quali Nietzsche non ebbe accesso. Infine la sua idealizzazione di Freud ebbe un esito per lui meno catastrofico di quella di Nietzsche per Wagner. Potremmo continuare; ma comunque sia, il risultato finale delle loro vite fu opposto” (p.24-25). Perché il filosofo tedesco, commenta Jung lungo tutti i seminari, non poté riconoscere la radice inconscia e il significato archetipico delle immagini interiori, operatrici di forza psichica autonoma, con le quali sarebbe stato necessario e salvifico che l’io non si identificasse, per canalizzarne simbolicamente e terapeuticamente la potenza numinosa e non restare annichilito dall’inflazione e dalla follia.
A fronte delle intuizioni folgoranti che per lui assumevano il carattere di “rivelazioni” Nietzsche finì per ritenersene, magicamente e illusoriamente, l’acrobatico proprietario. Sarebbe stato assai meglio assumere una posizione critica e “discutere la questione con Dio” come facevano i profeti, osserva Jung nella conferenza del 4 marzo 1936 (C.G. Jung, p. 933). Altrimenti, in questi casi, giunge fatalmente al posto della coscienza critica, una “spinta che viene dall’inconscio e genera una azione” scrive Paolozza: così accade nella scena del funambolo, episodio dello Zarathustra “dove la metafora assume un valore simbolico in quanto affonda le sue radici nell’inconsceità di Nietzsche, ma anche in parte di Jung, e seppure a distanza di tanti anni, nella nostra incapacità di esplicitarne completamente il significato.
A ciò si deve il suo fascino e la capacità di esprimere la condizione rischiosa e precaria dell’umanità contemporanea” (p. 54). Il funambolo “cerca di protrarsi oltre il vuoto tenendosi in equilibrio su una fune” tesa tra due torri: si tratta, secondo Jung, del “tentativo compiuto da Nietzsche si trasformarsi in superuomo” ma ecco che il funambolo “a metà del suo cammino” vide saltare fuori “una specie di pagliaccio dai panni multicolori” che urlandogli contro e sorpassandolo gli fece perdere l’equilibrio “e, più rapido ancora del bilanciere che aveva lasciato cadere, precipitò in basso, in un mulinello di braccia e di gambe” (F. Nietzsche, Così parò Zarathustra, Adelphi, 1968, pp.13-14). Nella sua “interpretazione del pagliaccio come l’Ombra di Zarathustra e di Nietzsche” Jung ci aiuta a capire che la prospettiva da cui Nietzsche “guarda la condizione umana è incapace di generare una soluzione alla crisi che pure gli riconosce di avere per primo registrato” (p. 57).
E lo psicoanalista svizzero ci aiuta a cogliere in questo episodio “una narrazione profetica per sé e per la storia a seguire, dove il semplice avventurarsi oltre il simbolo cristiano sembra implicare un equilibrio impossibile fra opposti: la metafisica al suo tramonto da un lato, la trasmutazione dei valori della Volontà di potenza dall’altro” (pp. 58-59). Sull’orlo di questo abisso la prospettiva di Jung è quella di “dissolvere la catastrofe integrandola soggettivamente” come avviene nel lavoro con i sogni: “Quando l’immagine di un sogno è impossibile o assurda, veicola l’idea che ciò che si sta facendo è assurdo, ma al tempo stesso indica la strada” (C.G. Jung, conferenza del 20 giugno 1934, p. 126).
Una strada in cui il conflitto interiore deve venire assunto come un dilemma indispensabile per la vita della psiche dato che l’Ombra è necessaria “per la realizzazione della totalità di una personalità: nessuno è completo in mancanza delle sue qualità negative” (C.G. Jung, p. 131). Una indicazione che giunge potente fino ai nostri giorni quale farmaco capace di disintossicarci dalla retorica proterva della leggerezza a tutti i costi e a depotenziare quel maligno “passare oltre” che disprezza l’uomo collettivo e deride ciò che ancora non comprende. “Al culmine di questa possibilità”, conclude Paolozza “c’è il valore della stessa Psicologia analitica come prospettiva, coerente con lo sviluppo filosofico e scientifico contemporaneo, da cui attingere alla totalità del Sé” (p.65).
Torsione del ravvedimento, allora, e devoto riconoscimento della miseria dell’io in cui si scopre che “il filo non è ciò che si immagina” come confessa Philippe Petit nel suo Trattato sul funambolismo. “Non è l’universo della leggerezza, dello spazio, del sorriso. È un mestiere sobrio, rude, scoraggiante” (p. 68). Ma anche un mestiere mite e capace di benedire la vita, aggiungerei, se si tratta di un “funambolismo consapevole” che non smette di “discutere con Dio” fino a rivolgergli, con Rainer Maria Rilke, la più sovversiva e calda delle domande: “Che farai, Dio, se io muoio”?









