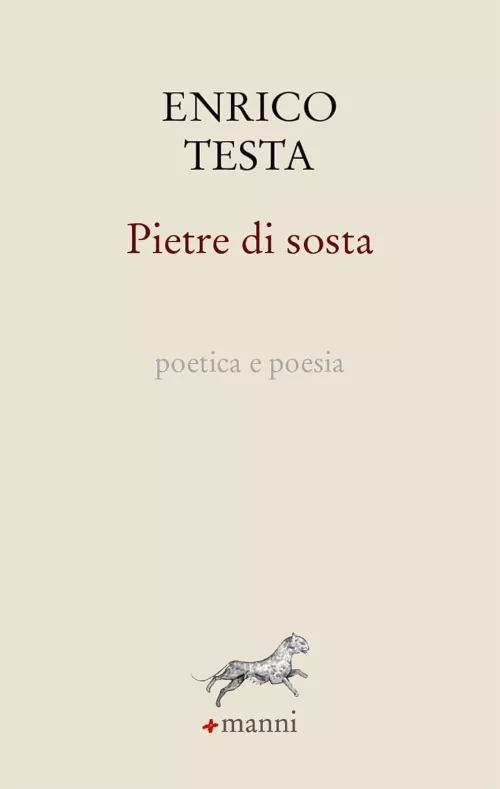Enrico Testa da sé a sé
Pietre di sosta, (Manni, 2024) nuovo libro di Enrico Testa, con quarta di copertina di Antonio Prete, è composto da una parte iniziale di testi inediti e traduzioni e da una seconda di versi scelti, dallo stesso autore, dal suo importante e lungo lavoro poetico, che ha avuto inizio formalmente nel 1988 con Le faticose attese (San Marco dei Giustiniani). Ma a precedere gli inediti e traduzioni raggruppati sotto il titolo Albergo sul dirupo, vi sono anche delle pagine in prosa molto rilevanti in cui prende forma una riflessione profonda su cosa sia davvero fare poesia, di come quest’arte pervada, nel suo farsi, sommamente la vita e di come senza gli accadimenti di quest’ultima, soprattutto quelli non augurabili, essa prenderebbe il contenuto di una lettera morta. E nelle pietre di sosta appunto, luoghi simbolici di molti sentieri montani, è come se si materializzassero, nella pausa del cammino, i tanti fugaci pensieri dei passanti. Proprio lì la fluida voce del libro, incontra uno spirito che potremmo forse pensarlo come l’altro da sé, colui che gli è dentro e fuori al tempo stesso; forse la sua parte in ombra, che inizia ad avere con “l’altro” un botta e risposta senza esclusioni di colpi, a partire dal senso stesso della vita: “Vorrei convincerti – e convincermi – che nella scrittura c’è anche qualcos’altro dalla solitudine e dalla bruciante condizione della singolarità di cui parlavamo prima … Un narrare che risveglia cose che sembravano dimenticate; una relazione che ha sempre da misurarsi con la figura dell’altro; una ferita coincidente con la voragine di solitudine aperta dalla follia; lo spazio e la possibilità, infine, di una condivisione…”.
Libro, questo, di suggestioni, chiavi di volta, che assalgono il lettore; difatti nelle stesse pagine iniziali, la pietra, il sentiero brullo, la particolarità del luogo, l’incombenza metafisica dell’entità anzidetta, mi hanno rimandato istintualmente al can barbone del Faust che segue e costeggia per dossi, fino allo studio, il professore avido di verità imprendibili. Ma quello spirito vuole appunto corrompere il dottore per le fiamme eterne, qui invece è meno audace, ma non per questo meno sottile; vuol solo smontare e dichiarare la parzialità di quelle verità esistenziali prima che poetiche, che la voce narrante riflettendo, gli va esponendo. È quindi chiarissimo sin dall’inizio, come il momento dialogico, sia in questo libro, la pietra angolare di ogni vita; certo da intendersi nelle sue forme più varie.
E la prima che salta all’occhio è quella linguistica, che lega i testi dell’autore con quelli di memorabili poeti da lui letti e tradotti, quali solo per ricordarne alcuni nel libro, Ted Hughes, Gerard Manley Hopkins, Octavio Paz, Thomas Hardy, Philip Larkin. Pagine quindi legate le une alle altre da un sottilissimo filo, di là di ciò che si descriva e prenda forma nel verso; è quel certo sentire, quei certi racconti di esistenze perse, di ombre ritornanti, che legano le poesie, che quasi talvolta sembrano un’unica pagina che parla di una certa pietas, di là del nome dell’autore. Ecco allora affiorare l’amore estremo di Enrico Testa per la lettura, prima ancora che per la scrittura: è proprio in questo estremo sentire, che il poeta può poi concepire il suo verso, come umile risposta, pegno, ai grandi scrittori immessi tra le pagine: “capita, in sogno, di piangere/disperatamente per te/come mai accadde/– né poté accadere –/nella realtà di fronte a te:/…/Chi sogna ha una ben strana sorte:/trovarsi insieme a persone vive e morte./La scena è interrotta/dall’arrivo del prete:/non prega ma bestemmia,/non porta quiete ma ci gela e scaccia/e minaccia botte con l’aspersorio/…”.

Il filo della relazione, cuce anche la seconda parte del libro dal titolo Selva; qui però il dialogo cambia un destinatario. La voce testuale ripesca un sé lontano e allora l’arco dei tempi, in poche pagine, sembra flettersi e scagliare una parola che dall’oggi tocca la memoria e che a rimbalzo torna come nuova in questo tempo. Una parola, che dalla prima raccolta anzidetta, con San Marco dei Giustiniani, appare già feconda, capace di saperci dire l’originalità di una situazione, un movimento, l’agonia di qualcosa che si va spegnendo. E la fitta rete dialogica naturalmente trova nel corso del libro altre dimensioni, come quella che si stende nel tempo del sogno dove si danno appuntamento amicizie e amori di una vita, ma come pervasi da una sottile vibrazione di oblio; essa si nasconde nel gesto che rivive di un cenno, di un sorriso, ma anche nella penombra di un viso: “/…/C’è lei com’era prima del dolore/e anche lui ma un poco più giovane di adesso./ E io, tra i due, la terza persona./O, forse, l’estraneo./…/Come si chiama questo tempo?/Che appuntamento è?/il piccolo prodigio/di trovarci simultaneamente/…/qui riuniti nella stessa cellula mentale/di un buio su cui non sorgerà mai il sole …”. Nella selva appunto vi sono moltitudini di voci che si cercano, di storie vecchissime, di amici e nemici inseguiti nei vichi di Genova, di amori e amicizie assolute, magari perdute nelle stanze di un ospedale. Ritornano nettissime proprio perché assenti definitivamente e come ripescate all’amo di un dialogo potenziato dalla rammemorazione.
E però questi versi che lo inverano, sembrano parlare non più agli assenti ma ai viventi. Questo accade nel palco di queste pagine ma qual è la loro quinta? La natura certo, che talvolta tracima, in sentieri d’alta montagna, o la si odora nel riverbero del mare, nel suo salino; e poi le città, con i movimenti quotidiani, i treni, le loro finestre aperte agli spazi, alle figurazioni. Dice l’autore nelle note finali, che l’opera di selezione di tutto il lavoro poetico presente in Selva non è stata facile: “… guardarsi indietro; misurare da questa prospettiva il passare del tempo; … rileggere poesie che si è dimenticato o che, ora, non si avrebbe neppure voluto scrivere…”. Sì, forse; ma in verità leggere Vico della catena, vecchissima poesia o Albergo sul dirupo una delle ultime, è come vedere gli occhi di un fanciullo divenire adulto, certo le striature del viso, la morfologia dei segni cambieranno radicalmente ma i suoi occhi, a guardarli bene, la luce dell’origine, quella no: “in Vico della Catena/la morsa delle mani rompeva/la corsa dei fuggitivi la loro pena,/tramutava il tremore/nella gioia di fare a pugni,/…//alle voci degli amici/– dolci nell’aria serena –/rispondevano/gli scoppi d’ira/dei chiari nemici,/in Vico della catena/vicino all’Ansaldo/a Sampierdarena”.
Ecco, sullo sfondo di ogni scrittura di Enrico Testa c’è quel santo luccichio che ricerca i brandelli delle relazioni, risalendole nella stradina infida della mancanza, per poi ricollegarle nella pagina, in nuovi collage di dialoghi e figurazioni. Sa bene l’autore che ricercare un rapporto con le ombre è in verità ricercare quella preghiera laica che il fragile uomo inoltra da sé a sé, ma che deve comunque attuare, per darsi e soprattutto dare senso di memoria alle nuove generazioni. Ecco, Pietre di sosta, libro di un uomo e dei suoi eterni vacillamenti, si chiude così come s’era aperto: l’alta montagna, il masso-pietra, lo spirito che somiglia tanto a quegli angeli custodi delle nostre religioni millenarie e che guarda il ragazzo lavorare la cote della montagna e poi ecco attorno un silenzio che è più del silenzio: “…/Una solitudine assoluta e senza nome./Come quella dei dipinti dei paesaggi/nati nel digiuno della gente./Conservare e annientare./Essere uno./Conoscere, tra gli ultimi,/l’erba di nessuno/”.