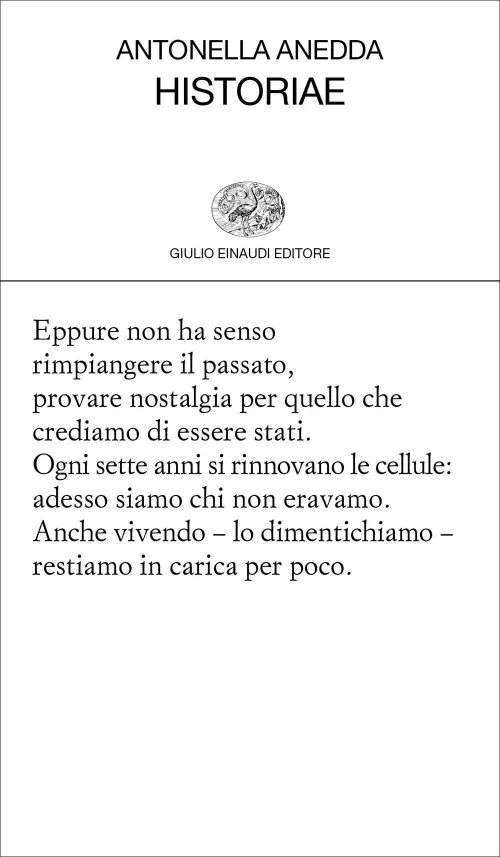Parola-fiamma / Antonella Anedda. Historiae
Antonella Anedda, una delle poetesse più rappresentative e profonde degli ultimi anni sin dal suo esordio avvenuto nel 1992 con Residenze Invernali (Crocetti), conferma con l’ultimo libro dal titolo Historiae (Einaudi, 2018) quella rara capacità di dare alla parola un’accensione che illumina non solo lo spazio circostante ma anche le profondità del tempo; lì opera la sua scrittura, che da sempre cerca di riportare alla luce i segni e le relazioni in esso svaniti. “Non esistono nomi, autrici, autori,/volano soltanto le parole, si mischiano/alla pelle che cade sui divani, quella/che ogni giorno perdiamo…/…/Questo resta, la polvere e i suoi atomi sparsi,/cateti e ipotenusa per il teorema che chiamiamo poesia/”. Historiae, titolo latino della raccolta con desinenza al plurale, ci dice già molto, traducendolo, sul lavoro di Antonella Anedda, che è appunto attività di ricerca su quello che è il senso di una comunità, sulle sue relazioni sempre in bilico e sul punto di disgregarsi, ma al tempo stesso Historiae è anche cronistoria, resoconto, narrazione dei fatti più strettamente intimi che nel loro ricomporsi in parola poetica assumono però un significato tutto da decifrare; difatti quegli accadimenti non sono sepolti dal tempo e nel tempo ma attraverso i versi s’increspano di vita come onde sempre in movimento.
La vividezza dunque della pagina, la sua forza, è quella di innalzare l’attimo del quotidiano, con i suoi sacri e prosaici sussulti, i suoi abissi e glorificarlo laicamente, dando ad esso pari dignità rispetto ai tempi lunghi e indefiniti della storia che sono poi il computo astratto degli attimi stessi: “Oggi penso ai due dei tanti morti affogati/a pochi metri da queste coste soleggiate/trovati sotto lo scafo, stretti, abbracciati./Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo/e cosa ne sarà del sangue dentro il sale./…”. Il libro pur avendo al suo interno cinque capitoli molto differenti quali Osservatorio, Historiae, Occidente, Animalia, Anatomie, Futuro anteriore, in verità obbedisce a una costruzione di pensiero unitaria, che indaga non solo la cognizione del dolore, tanto per essere adiacenti ad uno dei titoli più alti del nostro novecento, ma anche il senso di precarietà di ogni cosa, attraverso una ricognizione intima della poetessa che risale dai tempi più fondi dell’esperienza. Difatti le lacerazioni private è come se fossero macerate a lungo con un sistema di sopraffini filtraggi di parola, per poi esser distillate in immagini crude e asciutte, che in talune pagine paiono assumere quella posa esistenziale e visionaria di L’Homme qui marche di Giacometti.

Nella parte centrale del libro si susseguono le sequenze toccanti di un corpo morto, quello della madre della poetessa, che pare invece nella pagina rianimarsi e ripetere i gesti quotidiani di un tempo, quasi sovrapponendosi a colei che scrive, al punto che non si intuisce più chi sia davvero il corpo vivo che ausculta l’altro trapassato nei contatti fugaci: “Era lei nel vapore salito dai cespugli?/La chiamai pur sapendo anche io come tanti/che la risposta sarebbe stata il silenzio,/…/Due volte strinsi a vuoto il suo nulla/due volte mi abbracciai/finché mi vinse il freddo…/…”. Fugacità appunto, non solo delle ombre private ma come dicevo delle comunità tutte che, fatte per durare, non resistono che alcune generazioni, infette dal germe multiforme della violenza, con gli equilibri sociali sempre esposti e vacillanti per il modus operandi delle società del consumo avanzato.
E queste variegate diapositive di vita intima e collettiva riescono a essere sempre così lievi, avere quasi una saggezza distillata; mai un senso di pesantezza permea lo stile di Anedda, pur scrivendo appunto di cose finali e fondamentali per ogni donna e uomo. Nella pagina difatti il suo individuo si avvicina a quello rinascimentale che guarda rapito ma anche dolente, per la consapevolezza di esser frammento, i bagliori dell’universo, ma è anche l’uomo della società di massa, come già il filosofo tedesco Georg Simmel a inizio novecento teorizzò, schiacciato nella triade metropoli, modernità, capitale, che di quei suoi meccanismi assurdi e oramai usurati di avidità, scaltrezza, si sente oramai parte dolente: “…//Resto ferma a guardare, penso a quanto/siamo alti e miopi e assordati./A nord delle baracche sfrecciano i treni/verso Fiumicino, lo splendente aeroporto della capitale/i vagoni sfiorano la Magliana,/i palazzi affollati di lenzuoli,/i supermercati con le merci scontate./….”.
Ecco, l’amo della parola di Antonella Anedda sembra perforare le tante profondità storico-filosofiche e raccordarsi alla grande tradizione della lingua poetica che ci ha preceduto, entrando in essa ed umilmente chiedendole di tornare, per aiutarla a tratteggiare i foschi contorni delle storie del mondo. E così l’aderenza della poetessa alla voce dei grandi, da Tacito a Mandel’stam, da Dante a Auden, non solo avviene nell’alto gioco stilistico dei rimandi ma anche nella pura dimensione contenutistico-esistenziale, che sembra per osmosi migrare dai loro libri e metabolizzarsi nella pagina di Historiae. Antonella Anedda, col suo linguaggio mite ma implacabile, ecco che illumina un colore, un dolore, uno strappo livido del viso, una pena che scende giù definitiva dagli occhi; eccola indagare le parti più buie del quadro-mondo quasi rischiarandole. E così la sua parola-fiamma non s’arrende, cerca nella tela delle esistenze, da cima a fondo il chiaroscuro di ogni vita: “Qualcuno a quest’ora avrà appena finito di sognare/mentre i popoli migrano,/qualcuno si sarà di nuovo messo a letto,/per qualcuno il mattino non diverrà mai sera,/…”.