La lontananza di Ernesto Franco
Della lontananza si possono dire, e sono state dette, tante cose. La si può opporre come una visione alternativa a una cultura che vuole e ci illude che tutto sia prossimo e a portata di mano; e, allora, essa diventa l’altrove dove scorre un flusso metamorfico di possibilità. Letterati e filosofi, si sa, amano provare a dar voce all’invisibile, al fuggitivo, all’indefinito. E questo comporta che sia sempre disponibile, dopo il distacco o il trauma o la fuga, una nuova parola. In questa aura semantica l’ultima parola è sempre la penultima: si presuppone che ve ne sarà un’altra. Ma se la scrittura e, insieme ad essa, la lettura muovono da un’esperienza concreta e vissuta fin nel profondo del corpo e dell’animo, si danno anche dei casi in cui la lontananza appare, abolito ogni intrattenimento metafisico del pensiero, assoluta, definitiva, senza scampo.
Ernesto Franco ci ha lasciato, prima di salutarci, un libro di poesie che proprio di questo parla. E lo ribadisce nel titolo, Lontano io, che presuppone uno stato di assenza di sé a sé stesso, e poi lo segnala e rimarca, come rintocco o suono di campana, nei titoli di ogni sezione. Con l’esclusione dell’ultima, che in realtà drammaticamente invera, non distaccandosi affatto dal tono primario degli altri testi, la dimensione in cui essi si collocano: in Aiutami – due sole poesie, la prima di 79 versi che dà il titolo alla sequenza e la seconda, A poco a poco, più breve – la lontananza è il processo dell’allontanarsi in un dolore intollerabile.

Nel libro si susseguono testi che hanno per cifra tematica ed espressiva le coordinate essenziali del nostro essere al mondo, riassumibili con semplicità grammaticale in un qui (il luogo: la città natale nella prima parte, Lontano da Genova), nelle forme pronominali del tu (Lontano da te), dell’io (Lontano da me) e della terza persona (Lontano dall’altro). Usando la forma privilegiata della quartina a schema ABAB, Genova è offerta a rasoiate d’immagini. C’è sempre qualcosa di ventoso che fa dolere gli occhi e di puntuto che fa dolere il cuore: «Genova arco e faretra / ha il cuore di pietra», «Genova equilibrista, mancina, / non ha bagaglio, / di fronte è un taglio», «Genova vale un vento / vale un’ipotesi al netto, / il nostro scontento»; Genova ha «nuvole fossili», è «ampia, curva e fonda» (e città ricurva era la definizione che ne dava nel romanzo Vite senza fine del 1999) e «s’avvita a picco / per porti, punti e punte». Dalla città, dal qui, si transita alla figura femminile a cui ci si rivolge nel secondo ‘capitolo’ del libro: «Qui. È di qui / che sono passati. / E a noi non basterà, / cara, /esserci stati». È fortissima – così almeno mi sembra – la connessione tra il luogo perduto e sognato e la donna con cui si ‘dialoga’ usando queste parole: «Mi parli muta, / come se ci fossi. / Mi respiri addosso, / come se esistessi». E non c’è nulla da stupirsi in questo. Ernesto Franco affonda qui il suo scandaglio sin sui fondali della tradizione lirica occidentale.
A partire da Jaufré Rudel e dal suo Amore di terra lontana per arrivare alla prima generazione dei poeti toscani avanti lo Stilnovo per cui lontananza dalla città faceva tutt’uno con lontananza d’amore. Si respira un’aria provenzale e di poesia in volgare delle origini (il motivo dell’alba: «All’alba s’incrina / la mia vita prima»; moduli e scelte linguistiche come quelli della «beltà» che «ghiaccia» o della «luce» vista come un «cristallo»), percorsa però da folate di drammatico disincanto novecentesco («C’era una volta / cenere molta: / l’amica / che mi fu tolta»), da brezze d’ironia («Mi è rimasta, / per sbaglio, / la moneta di taglio») e da refoli di tristezza: «Chiedo: / “Senza di che?” / Sento: / “Senza di te”». L’approdo di queste armoniche semantiche potrebbe essere, secondo la tradizione che sta loro dietro sin dai tempi più antichi, una poesia dell’atemporalità, della privazione e dell’assenza. E tale direzione sembrano indicare versi come i seguenti «Mi lasci e mi torni, / fuori del tempo, / figura senza contorni, / dono senza perdono». Ma, guardiamo a cosa succede nel libro. Seguono le più brevi sezioni terza e quarta. In Lontano da me, nessun tono tragico: s’incontrano intarsi del significante che ricordano le poesie di Toti Scialoja con tanti animali antropomorfizzati.
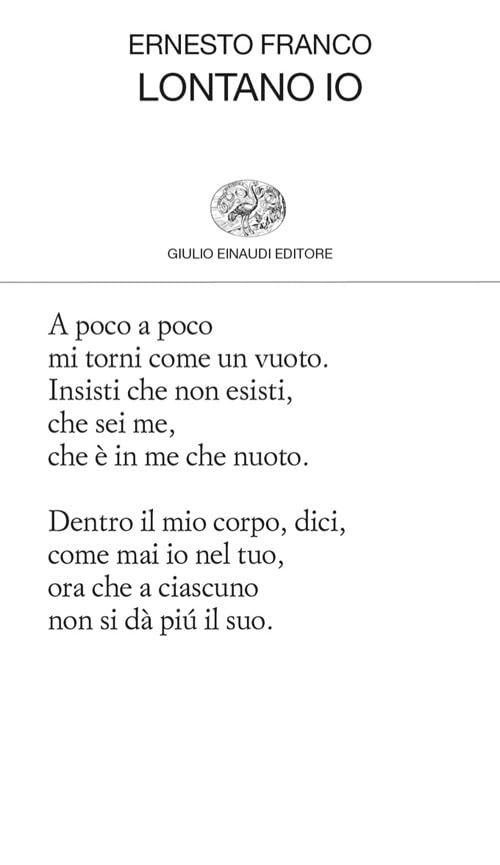
Tordi che salgono a bordo come vecchi marinai in partenza e allocchi con l’anima a picco come alcuni personaggi dell’amata narrativa sudamericana. Un anomalo bestiario che produce, ironizzando sull’abisso, una sorta di lesione del senso. In Lontano dall’altro, nessuna retorica corrente e in gran sfoggio nelle scritture d’oggi, sull’altro. Anzi, sfilano poesie brevissime in forma di battute che puntando, alla Wittgenstein, sui paradossi della lingua comune, acquistano significato sulla base del sottotesto che in calce le accompagna. Ad esempio «In quanti sei?» rimanda alla nota in calce «In un albergo. Al telefono. Il concierge tratta una prenotazione». Sono pause di vento prima che si levi il fortunale di Aiutami. È difficile e doloroso per chi ha voluto bene a entrambi i protagonisti del dramma, leggere la prima poesia, eponima della sezione. Dedicata a Fulvia Bardelli, scomparsa il 4 aprile del 2001 pochi mesi prima di compiere 45 anni e compagna sin dal liceo e poi moglie di Ernesto, la poesia è realizzata per interposta persona. In essa, scandita dal richiamo anaforico dell’invocazione aiutami seguito quasi sistematicamente da quattro versi a rima alternata (in spagnolo si chiama rima cruzada, il termine più adatto alla crocefissione del corpo qui in atto), l’autore interpreta la voce inesorabile della morente fasciata nell’inquietudine, nel dolore, nella domanda rivolta a una vita che ha assunto forma d’ insulto. È preda di «un vento nero», di «una notte» dove le sfugge «ogni pensiero» e chiede con l’imperiosità della debolezza «resta qua». Ma è impossibile far quadrare i conti delle colpe e del perdono. La poesia di chiusura, A poco a poco, ritorna sul qui da cui aveva preso le sue mosse il libro e affida le sue ultime parole alla forma interrogativa – un’interrogativa probabilmente retorica ma forse anche no – del discorso: «Qui è lontano, / non ha portata la mano. / Qui, a costruire la fantasia / che tu non ci sia. / Ma non è mancanza / tutto ciò che fa esistenza?».

Ogni ipotesi di atemporalità quale caratteristica della poesia della lontananza che si potrebbe assegnare, sulla scorta dei modelli provenzali, al libro di Ernesto Franco, si sfarina così in rosume di tarme (a meno di non voler temerariamente concedere un tratto d’eternità alla scrittura letteraria). Infatti, quanto si rappresenta nei versi è, piuttosto, un divenire, un pencolare sulla soglia del nulla. Qui – almeno è questo che mi sembra dicano i testi nel loro insieme – è, mentre «il tempo stringe, / il corpo stinge», tutto un passaggio, un inseguimento, un andare e un tornare, un gioco di ombre, un nome che chiama, una risacca di mare, un’improvvisa piega di vento. C’è un fenomeno formale ricorrente e quasi sistematico in tutta la raccolta che precisa forse più di tante parole questa impressione. Si tratta della rima (e purché torni la rima va tutto bene, scriveva Giovanni Giudici ripensando al suo interesse infantile per i versi) realizzata nei bisillabi per semplice gioco di cambio di lettera iniziale. Come nero: vero, male: sale, tace: pace, gocce: rocce, sente: mente, molta: tolta e, per tacer di altre e più di ogni altra significativa, lutto: tutto.
Senza far ricorso al grande Charles de Brosses e al suo Trattato della formazione meccanica delle lingue o tirare in ballo la linguistica novecentesca, non credo che vi sia qualcosa che più chiaramente di questo fenomeno e del suo profilo così elementare, indichi la permutabilità della lingua, i suoi attriti e le sue erosioni e, quindi, inevitabilmente, la sua temporalità. Ecco, il tratto formale-compositivo del cambio della lettera iniziale di parola viene messo qui al servizio della semantica. Cambio di suono e di grafema che allude allo strambare della navicella del libro, alla dinamica che, nell’apparente fissità che potrebbe essere indotta dalla sorte dell’autore, lo percorre da capo a fondo e ci restituisce, con lo scacco della fine, la ricchezza dell’approdo: un vuoto che accoglie tanti tempi e tanti significati. Allora, non la stasi, l’assenza di tempo, la fissità della lontananza, ma il movimento, un immenso camminare dei testi e nell’intero libro. Un suggerimento in tal senso lo offriva già, fin dal titolo, il precedente libro di versi, Donna cometa del 2020, un bellissimo canzoniere d’amore per l’altro grande affetto di Ernesto e sua seconda moglie e anch’essa cara amica, Irene Babboni, che ci lasciò il 19 giugno 2017.

La forma dei componimenti del libro era diversa da quella delle poesie di Lontano io – più descrittivi, più ampi e distesi e ricchi di particolari – ma il sentimento di fondo era lo stesso: un luogo, l’insistenza sul qui, le forme pronominali del dialogo, la visione che solo lo scorrere del tempo e il senso del passare danno (come quello della cometa, appunto): «Sei nei luoghi, sei nei viali, / sei nel vuoto qui accanto, / “mi manchi” ti dicevo stretto, / per dire che “vicino” non bastava. / Neppure ieri, quando c’eri. // Ora sono qui, uno dei due, / stanco con tu che manchi, / proprio qui. / Qui accanto». Ecco, quindi, mancanza e un «tempo lento» e un inseguire di ombre. Le ombre che traspaiono da tutti e due i libri e dalle perdite dolorose con cui ci costringono a misurarci. E quella dell’autore è per me insanabile. Ho visto l’ultima volta Ernesto, a Genova, il 18 maggio di quest’anno. Sul lungomare parlammo di tante cose, care a entrambi. In un colloquio pieno di intese e di sintonie e di affetti. E questo colloquio – poco importa che sia ora nella forma del monologo – continua. E continua nel tempo, non nel vacuo del caos che amano i dipendenti della Fabbrica del Nulla o nel culto della forma che amano i dipendenti della Ditta del Sublime. Siamo, caro Ernesto, meno lontani di quanto la logica del senso comune possa immaginare.
Leggi anche
Roberto Gilodi, Le isole fantastiche di Ernesto Franco
Italo Rosato, Cesare Viviani e Ernesto Franco
Roberto Gilodi | Ernesto Franco: utopia e disincanto
Mauro Bersani | Ernesto Franco: d’amore e di mare









