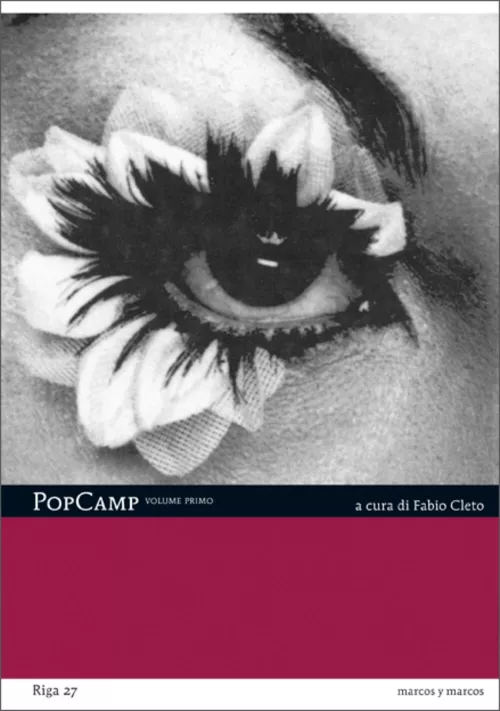Pop Camp 1 e 2
Riga, una collana che avvicina ai grandi innovatori del Novecento
Riga è nata nel luglio del 1991 senza nessun particolare programma. Volevamo piuttosto fare la rivista «che ci sarebbe piaciuto leggere». Una rivista dedicata al contemporaneo, ad autori e temi che ci sembravano rilevanti nel corso dell’ultimo secolo, ma non solo. Una rivista che conservasse la memoria del passato, e insieme che si protendesse sul futuro.
Marco Belpoliti, Elio Grazioli
«In qualcuno dei tuoi voyages au bout de la nuit ti è mai capitato di imbatterti nella parola camp?». Si era nel 1954, e così Christopher Ishwerwood introduceva il narratore di Il mondo di sera alla sfera del camp, dandone la prima discussione a stampa. Non nella dimensione «totalmente degradata» dei «circoli equivoci» – in cui il termine indicava, ad esempio, «un giovincello svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich» – bensì in quella estetica ed emotiva in cui si esprime «ciò che è fondamentalmente serio in termini di umorismo, di artificio, di eleganza». E subito, nel condividerlo, si apriva il problema: come definirlo? Si trattava infatti di un concetto esoterico, avvicinabile solo «per intuito come il Tao», vale a dire attraverso un percorso di seduzione per esempi – il barocco, il balletto, Mozart, El Greco, Dostoevskij – che desse nome e forma a un’eventuale percezione latente. Operazione difficile e incerta nell’esito, ma ne valeva la pena, perché il camp era categoria utile – ben di più: necessaria – «tutte le volte che si parla di filosofia, di estetica, e quasi d’ogni altro argomento». Da cui la perplessità su «come se la cavino i critici, facendone a meno».
A distanza di oltre cinquant’anni, la situazione è solo in parte o per nulla cambiata. Lo è in parte nel mondo angloamericano, che ha prodotto un corpus critico di notevoli proporzioni e qualità, salvo però ribadire la peculiare indefinibilità del camp, presupposto ineludibile e sprone a qualsiasi riflessione: il suo essere, in breve, un oggetto di discorso al contempo impossibile, compulsivo e inarrestabile. Lo dichiarava Susan Sontag in apertura di un saggio del 1964, Note sul ‘Camp’, che ha indicato nel camp una parola-chiave epocale, premettendone il carattere elusivo, quasi da «cifrario privato». Un carattere che di per sé implicava un ‘tradimento’ nel parlarne, e imponeva una struttura argomentativi frammentaria, in forma di ‘appunti’, aperta da un elenco di riferimenti dalla sconcertante eterogeneità: le tavole di Aubrey Beardsley, le opere di Bellini e le regie di Visconti, il King Kong di Schoedsack, Flash Gordon, i romanzi di Ronald Firbank e Ivy Compton-Burnett, ecc. Ne hanno ribadito l’elusività tutti coloro che, numerosissimi, hanno scritto sull’argomento negli anni a seguire, moltiplicando le figure del camp e facendone una questione di primo rilievo nel panorama della critica culturale. Poco o nulla sono invece cambiate le cose in Italia, dove i critici hanno continuato a farne a meno: tranne poche eccezioni, il camp non ha da noi conosciuto una spendibilità critica, non è entrato nel lessico dell’estetica e nella storia della cultura, e rimane splendidamente ignoto ai più.
Questo numero doppio di «Riga», nel colmare tale sconcertante lacuna, sollecita necessariamente tutti gli interrogativi con cui si confrontavano Isherwood, Sontag e chi li ha immediatamente seguiti sul terreno scabroso del camp. A partire dalla domanda fondamentale: cosa è, dopo tutto, il camp? Cosa ne costituisce l’essenza e le caratteristiche, da dove giunge e quali ne sono i percorsi storici? Le risposte, anche quelle emerse negli anni successivi, sono imperniate su una sistematica contraddizione. Si tratta di un’estetica, uno stile o gusto, è stato detto, oppure di una sensibilità, un modo d’essere. Uno stile di pensiero e di performance. Una specifica formazione – fors’anche una prerogativa – omosessuale, una strategia di sopravvivenza (ma con stile, nella maschera dell’ironia), eppure difficilmente circoscrivibile all’omosessualità, di per sé condizione non necessaria né sufficiente. Di volta in volta, la si assume quale categoria metastorica, oppure inesorabilmente legata al particolare, a una economia o posizionamento culturale. E la questione si fa ancor più spinosa se ci si chiede come riconoscerlo.
La presentazione per exempla, scelta a lungo quasi obbligatoria, non chiarisce – semmai, appunto, spiazza e seduce a una percezione ironicamente complice. Il camp comprende infatti figure disparate come Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, David Bowie e Judy Garland, Fassbinder ed Elton John, Philip Johnson e George Petty, Jean Cocteau e i Velvet Underground, Erté e le Sisters of Perpetual Indulgence, Angela Carter e Aubrey Beardsley, Versailles e Gore Vidal, la Marchesa Luisa Casati e Robert Mapplethorpe, la mai-troppo-compianta Regina Madre e Pedro Almodóvar, Coco Chanel e Kenneth Anger, Philip Johnson e Cecil Beaton, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Barbara Cartland, Shirley Bassey e Robert de Montesquiou, Wilhelm Von Gloeden e Mae West. Come può aggregare sfere culturali così distanti (arte, musica pop e classica, cinema, architettura, design, opera lirica, fumetti, letteratura, teatro, musical, moda, ecc.) e ordini estetici altrettanto diversi – aristocrazia, piccola borghesia e sottocultura, il pantheon delle divine con il qui-e-ora nostalgico del mercatino delle pulci, il sublime estetico di Visconti con il trash di John Waters?
Il camp non può essere affrontato riparando alla sua eterogeneità, rendendolo didascalicamente codice condiviso e intelligibile. Agisce infatti necessariamente su un terreno indefinibile e obliquo, e proprio nella eterogeneità – nella sua ‘natura’ contaminata di prospettiva e sistema di riferimenti – risiede la sua elitaria ragion d’essere. Marca di esuberanza, la cifra del camp è un travestimento psichico (più che banalmente vestimentario) che lo rende volubile, evanescente, inafferrabile. Perché il camp non è una proprietà oggettuale, pienamente catalogabile e condivisibile: è un processo dinamico, una relazione indiscreta fra oggetto e sguardo che improvvisa uno spazio di performance, una complicità e un senso di solidarietà mobili, tanto esclusivi quanto necessariamente ‘clandestini’.
È un effetto insomma della frizione fra il senso comune e una percezione ‘traversa’, scatenata da un impianto testuale – intenzionale o meno che sia – all’insegna di eccesso, improbabilità, virtuosismo. Il camp accade: ‘trova luogo’ là dove sguardo e oggetto si ‘travestono’, fanno spazio a un narcisismo sfrenato e autoironico, e si mettono in scena a un grado secondo di plausibilità, innaturale e ‘fra virgolette’, diventando camp. In breve, il camp accade ed eccede, attraversa e scardina le dicotomie stesse che sollecita (alto / basso, maschile / femminile, intenzionale / involontario, serio / ludico, mascheramento / esibizione, ecc.), e comprende l’inconciliabile: secondo la logica non tanto dell’accumulo quanto dello scarto; e per spirito non ecumenico, ma di contraddizione. È il termine stesso camp a essere poliedrico, mimetico della contraddittorietà cui si riferisce: al contempo aggettivo, sostantivo astratto, verbo intransitivo e transitivo, camp è un lemma che si traveste e nasconde nella propria stessa polisemia (camp come spazio, fazione, agone, primato e spettacolo).
Quanto alla sua storia, è adeguatamente una storia di mimetismi, stratificati e sedimentati in un regime di eccedenza. L’etimo è incerto, forse derivato dal francese se camper o dall’italiano campeggiare (nell’accezione scenica), e prima ancora dalla radice indoeuropea *kamp che – dicono Detienne e Vernant in Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia – si applica a tutto ciò che è «curvilineo, flessibile, articolato», e inscrive il camp nella logica del «polimorfo, duplice, equivoco, inverso», del «tortuoso, obliquo, ambiguo», che fonda uno stile di pensiero strategico e relazionale. Il termine pare diffondersi a ogni modo in Gran Bretagna nel tardo Ottocento, a indicare una bizzarra commistione di ironia, allusività, effeminatezza e teatralità, distacco aristocratico, affettazione ed estetismo istrionico. I suoi primi spazi e protagonisti sono quelli del demi-monde urbano che ospita pratiche e identità sessuali eccentriche, l’Alta Società e un ordine di plausibilità paradossale segnato dal fantastico e dall’inverosimile: ecco dunque il teatro, la pantomima e il burlesque, l’Opera, il vaudeville e il balletto, il music-hall, il cabaret e il cinema, i locali en travesti e la café society, la haute couture, la letteratura dei decadenti e dei loro epigoni, segnati dal regime di sospetto seguito alla condanna di Oscar Wilde nel 1895. In larga misura, il camp del primo Novecento si è così intrecciato con un’omosessualità che negoziava ironicamente – nel segno di una teatralità propriamente queer, categoria quest’ultima che per molti versi si sovrappone al camp – la propria sopravvivenza con lo stigma decretato dalla cultura dominante.
Uno spartiacque decisivo si colloca negli anni Sessanta, quando peraltro appaiono i primi scritti in merito – con Note sul ‘Camp’ di Sontag ad aprire le danze – che ne intercettano la salienza epocale e la portano al centro dell’attenzione pubblica, fornendo un termine-chiave per gli Swinging Sixties e per la crisi delle gerarchie culturali – cultura alta / bassa, bello / brutto, maschile / femminile, autentico / falso ecc. – di cui si faceva teatro la rivoluzione pop di quegli anni.
Faceva così il suo clamoroso ingresso in scena il ‘Pop Camp’: un gusto o sensibilità marcati dalla maiuscola che, nel celebrare il travestimento delle «cose che sono ciò che non sono», nel prediligere artificio, superfici e frivolezza a natura, impegno e contenuto, proclamava la sublimazione del Kitsch piccolo-borghese e l’apprezzamento perverso della sua «serietà mancata».
Versione glamorous del Pop, il Pop Camp riformulava l’affettazione del primo Novecento da marca di una sessualità eterodossa, e di un eccentrico snobismo, in un posizionamento en masse della borghesia colta. Se l’aristocrazia d’elezione del camp, diceva Sontag, trovava la propria «avanguardia» nel mondo omosessuale, che vi aveva storicamente imperniato la propria integrazione nella società omofobica, ora si offriva quale strada maestra (ancorché deviata) per essere «un dandy nell’epoca della cultura di massa». La matrice upper class britannica si innestava così sull’utopia del consumo statunitense, in un’apertura ‘democratica’ a elitarismo, sprezzatura e ironia, producendo quella forma di metasnobismo che contamina la ‘vecchia’ idea di capitale culturale con lo scenario pop.
Dalla haute couture al prêt à porter, insomma: nel farsi pop, trasferendosi dal retroscena del demi-monde europeo di aristocrazia e sottobosco sessuale al proscenio statunitense, come mai prima il camp del secondo Novecento segnava cultura e costume, gallerie d’arte, giornali e scrittura creativa, cinema e musica pop, pubblicità e moda. E dilatava radicalmente i propri spazi e ambiti: comprendeva ora le sottoculture giovanili, Teds prima e Mods poi, seguiti dal clangore di suoni e colori glam e dalle sonorità Motown degli anni Settanta, e pure i supereroi e i mercatini delle pulci, il jet set newyorkese mescolatosi nell’underground, il supermarket che penetrava nelle gallerie d’arte, i film di terz’ordine e la pornografia ironica à la Russ Meyer giustapposti ai classici di Joseph Losey – scenari e protagonisti di un gusto camp di massa.
Ora, nel presentare la questione in Italia, questo numero di «Riga» si colloca necessariamente nel solco di chi lo ha fatto quarant’anni fa negli Stati Uniti. Nel saggio di Sontag c’erano cinquantotto note; qui, quarantatre fra testi e saggi, tutti o quasi inediti in italiano, cui si aggiungono oltre 270 immagini (non illustrazioni a uso didascalico ma luoghi e dispositivi di spaesamento che necessariamente si accompagnano alla parola camp: il camp è dopo tutto un pensiero visivo, vive nell’immagine, e anche quando si affida alla parola, questa si fa spettacolo e ‘campeggia’).
Sulla scorta della rituale strategia di presentazione del camp, e complice la struttura tradizionale di «Riga», il lavoro si apre con una serie di esempi testuali e iconografici, che idealmente abbracciano un secolo di scrittura camp: da Aubrey Beardsley a Ronald Firbank (insuperati sacerdoti del camp di inizio Novecento) a John Horne Burns, attraverso il variegato pop camp degli anni Sessanta – aperto dalla extravaganza di Cyril Connolly (sorta di trait d’union fra il camp ‘mandarino’ britannico e le logiche della cultura di massa che dominano il panorama nordamericano) – con l’amabile follia di Tom Wolfe e James Purdy, con il pulp gay di Victor J. Banis e i travestimenti epistolari del dandy dell’East End, Joe Orton, per poi far tappa nel camp recente con Angela Carter, Truman Capote e Pedro Lemebel, che segnalano la perdurante attualità del camp sulla scorta della sua fase pop.
Un percorso a grandissime tappe, insomma, che offre un assaggio di camp in atto, nelle sue variazioni dall’Art Nouveau all’isteria degli Swinging Sixties al gotico, al realismo magico e al rétro contemporaneo. Con un’apertura finale al camp non angloamericano nel testo del cileno Lemebel, e nella sezione che ospita un brano della Narcisata del maestro Arbasino e i lavori iconografici di Mirando Haz, Luigi Ontani e Francesco Vezzoli, a introdurre in sintesi cinquant’anni di camp italiano.
Ancora: il camp è presieduto dalla metafora della vita come teatro, che inquadra il mondo e il sé come palcoscenico, performance, messinscena; inscindibile dal regime dello spettacolo, in cui si aggregano attori e spettatori. Il lavoro adotta perciò strutturalmente questa ideale metafora – ideale perché, proprio come il teatro, l’eccedenza camp vive di spazio e tempo organizzati nella rappresentazione, nel sontuoso, itinerante, reiterato spettacolo dell’effimero – facendo seguire a un ‘primo atto’ di scrittura del camp (il ‘proscenio’) un secondo atto di scrittura sul camp, la nostra ‘platea’, a sua volta in forma cronologica. Uno spazio questo che ospita uno sguardo prossimo e privilegiato, inestricabile dal palco del camp ‘in scena’ nel decretare forma e successo di una rappresentazione: lo spazio di Isherwood, Sontag e dei commentatori (figure di primo piano su riviste e giornali angloamericani quali John Simon, Jan Harold Brunvand, Thomas Meehan, George Frazier, Vivian Gornick, Alan Brien, Thom Andersen) che in presa diretta sono intervenuti sui periodici a grande diffusione, discutendo e divulgando le bizzarre figure del camp.
Nella ‘platea’ si collocano i testi – riprodotti cercando di restituirne la materialità, giacché esiste una materia dell’effimero, così come dei sogni – che hanno reso cioè possibile il pop camp, facendone una moda che ha segnato lo scenario culturale degli anni Sessanta e Settanta, in quella ‘democratizzazione’ del codice elitario camp alla quale si devono negli anni Ottanta i volumi illustrati di Mark Booth e Philip Core (i cui estratti chiudono il nostro ‘pressbook’). Ne emerge un panorama segnato dalla controversia, con polemiche, apologie e condanne, il che non sorprende: l’eterogeneità del camp si riflette nel disaccordo che domina i discorsi sul camp. Non mancano, in questa rassegna stampa, i segni di una prima rivendicazione omosessuale della categoria, di cui è esempio l’articolo di Richard Dyer, quale scarto dalla diffusione pop in cui l’elite del camp gay non poteva più riconoscersi: una tappa fondamentale cioè in quel ripensamento del camp – da un lato come essenziale «sensibilità gay» (nell’espressione di Jack Babuscio), e dall’altro come strategia di dubbio valore politico – che ha segnato l’attivismo gay degli anni Settanta.
Seguono poi, nel ‘secondo settore’ che apre il secondo volume, con la maggior distanza critica garantita da uno sguardo su quanto va in scena fra palcoscenico e prime file, i classici della critica: da un primissimo saggio di John Adkins Richardson del 1966 che ne mostrava l’immediata spendibilità nel lessico dell’estetica, ai saggi (compresi fra il 1978 e il 1991) di Jack Babuscio, Patrick Mauriès, Harold Beaver, Hilton Kramer, Giuseppe Merlino (con Mauriès, l’unico critico non anglofono ad aver scritto distesamente sul camp fino alla metà degli anni Novanta), Andrew Ross, Rosalind Krauss e Jonathan Dollimore. I saggi, vale a dire, che ne hanno fornito le coordinate critiche, attraverso le categorie che più direttamente sono parse interpellate e illuminate dal camp: la storia dell’arte, gli studi gay, la teoria del gender, gli studi culturali e queer.
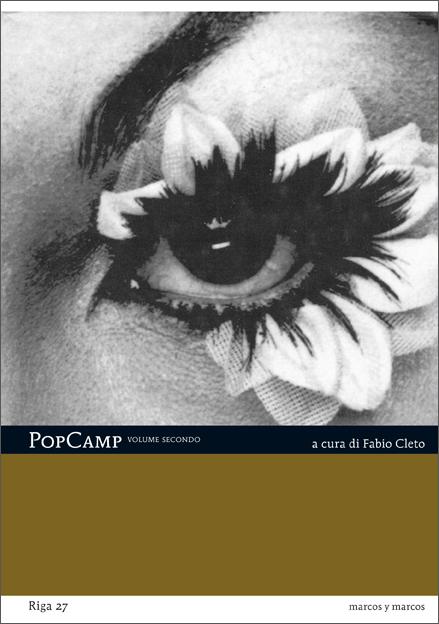
Tanto il ‘proscenio’ quanto la ‘platea’ offrono ovviamente accesso a una scena parziale, dalla selezione un po’ cruenta: molti altri testi creativi potevano infatti essere inclusi – Jean Cocteau, E.F. Benson, Cecil Beaton, Evelyn Waugh, Ivy Compton-Burnett, Angus Wilson, Brigid Brophy, Gore Vidal, Tennessee Williams, Manuel Puig, Carlos Fuentes, Renaud Camus, Edmund White, lo Isherwood di Sally Bowles, per menzionarne solo alcuni. Se si fosse dato più spazio anche alla cultura pop, con ad esempio testi musicali e brani di sceneggiatura, si sarebbe del resto assistito a un diluvio di inclusioni dalle proporzioni bibliche.
Il che vale anche per la saggistica – solo nove dei ventisei lavori raccolti in Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject, l’antologia critica che ho curato nel 1999 per University of Michigan Press e Edinburgh University Press, trovano qui spazio. In un lavoro che pure si annunciava di dimensioni inattuali, si imponeva ovviamente una selezione (in ossequio al principio camp dell’un peu trop, c’est assez), che si è voluta secondo un principio di focalizzazione tanto spaziale (obbligatoriamente, la cultura angloamericana) quanto temporale, rivolta al pop camp degli anni Sessanta e Settanta. Si tratta, com’è naturale, di una scelta strategica volta a delimitare il campo: una scelta che sembra di per sé in sintonia con il camp, che agisce circoscrivendo un territorio immaginario, e che pare rispondere meglio di altre a una finalità altamente conflittuale, quella di presentare sì il camp, ma in una chiave adeguatamente composita, che cerchi di renderne il carattere controverso. (Non l’accordo fonda il camp, ma l’antagonismo: lo scarto, si è detto).
La scelta di privilegiare il pop camp rispetto ad esempio al camp più contemporaneo o al camp ‘originario’ (quale che sia: quello di fine Ottocento, quello britannico, quello della ‘sensibilità gay’, quello sei-settecentesco di Versailles e dell’eufuismo, ecc.) si giustifica nella logica del paradosso. Il paradosso che attraversa il camp, e si incarna nella sua declinazione pop. E che rinvia alla questione fondamentale insita nel presentare il camp; ossia cosa in effetti ne rappresenti il dato fondativo e ne garantisca l’origine. Innanzitutto, se il camp si attiva a partire da uno sguardo che si ‘mette in scena’ e ricodifica il segno in una complicità perversa, se in altri termini il camp non prescinde dalle sue rappresentazioni, si può sostenere che il camp quale lo conosciamo si articola negli anni Sessanta. Il che provoca, appunto, una ricaduta sulla concettualizzazione di un camp ‘originario’, inevitabilmente negoziata nella ricodifica del passato: la paradossale ‘origine’ del camp può risiedere negli anni Sessanta prima ancora che nella fin de siècle, necessariamente recuperata, riconcettualizzata e transvalutata dallo sguardo che ne identifica il carattere camp e si investe rispetto al passato mitico di un lignaggio ‘nobiliare’. (La nobiltà del camp è arbitraria e improvvisata, diceva già Sontag.)
E in tal senso, il camp degli anni Sessanta è sicuramente – se non l’originale in senso stretto – uno snodo cruciale, una fase che più di altre mette simultaneamente in gioco le molteplici stratificazioni proprie al camp. Nel ritaglio spazio-temporale del pop camp si coagulano cioè tutte le istanze conflittuali, tutte le contraddizioni di cui il camp si è reso teatro – sovversione e cooptazione, marginalità e paradossale elitarismo, ecc. – nella sua intera storia. Una storia dai confini slabbrati, certo, e che il pop camp, in drammatica tensione fra quanto lo precede e la pervasiva eredità che lascia, testimonia appieno. Ma soprattutto, la fase pop pare ideale punto di partenza nell’avvicinare il camp perché il pop camp è sia un ossimoro, sia un’endiadi. Un ossimoro – lo si è più volte notato – in quanto la contraddizione è insita nel suo proporsi quale elitarismo, ma di massa, ossia nel coniugare le antitesi ‘camp’ e ‘pop’. Un ossimoro che però è pure un’endiadi, dato che il camp da sempre si intreccia con il pop: il camp – se non altro collocandone le origini in linea con la prima circolazione del termine, nel tardo Ottocento – si articola infatti come risposta alla cultura di massa, e ne è sempre stato perversamente complice. Il camp è l’erede del dandismo, diceva Sontag, e riformula la posizione aristocratica nella cultura di massa. Laddove il dandy era inimitabile, il che ne circoscrive l’esperienza ai primi anni dell’Ottocento, il camp vive di repliche, esiste nella riproduzione e sposa le tecnologie di massa. Ecco perché la sua storia abbraccia un arco temporale indefinitamente più ampio, e ben lungi dal volersi chiudere. Il camp è insomma per ‘natura’ imperniato su una contraddizione, ed è sempre stato, in qualche modo tutto suo, ‘pop’.
Infine, va detto che questo lavoro si chiude con un inizio. Il terzo ‘atto’ raccoglie infatti saggi del tutto inediti, che – con il vantaggio dello sguardo rivolto dalla confortevole angolatura prospettica di un ‘palchetto’ – tracciano nuovi percorsi nei territori del camp. Si va da una mia retrospettiva del pop camp nell’autunno newyorkese del 1964 (sorta di introduzione al volume, collocata dove solo può trovarsi un’introduzione al camp: fuori luogo) al camp della propaganda staliniana indagato da Gian Piero Piretto, dal picaresco camp fra Petronio e Pedro Almodóvar cui si rivolgono Giulio Iacoli e Massimo Fusillo all’incursione di Luca Scarlini nel camp ecclesiastico e a quella di Gabriele Monti nella moda contemporanea.
Tutti saggi di studiosi italiani, insomma, eccezion fatta per il saggio conclusivo di Steve Dixon dedicato al camp postumano della robot & cyborg performance art, e alla breve recherche del camp italiano che si è voluto affidare non a un italiano (scelta in sé forse banale, e contraria al principio di distanza e dislocamento che presiede al camp) ma al poeta e saggista britannico Gregory Woods, nato al Cairo e a lungo vissuto in Italia. La presenza in questa sede di saggi italiani, così come del pezzo di Woods e dei materiali di Arbasino, Haz, Ontani e Vezzoli nell’‘Intervallo’, sollecita un’ultima questione, di primario rilievo in un lavoro che introduce la nozione in Italia.
Tanto nella prassi quanto nella riflessione critica, è forse lecito parlare – a partire da un fenomeno, non dimentichiamolo, in odore di nominalismo – di un camp italiano? Certo, trasferire una categoria di per sé sfuggente e ‘locale’ ad altri confini culturali moltiplica gli interrogativi sulla sua pertinenza e legittimità. Tuttavia, è proprio la natura provvisoria e costantemente rinegoziata del camp a legittimarne l’adozione in un contesto italiano; basta farlo ‘capitare’, riconoscerlo là dove si è materializzato, anche a costo (un costo tutt’altro che gravoso) di produrlo. È fin ovvio che infiniti possono essere i casi di Kitsch nostrano disponibili a una sublimazione camp, così come lo sono tante forme di travestimento di dubbia intenzionalità cui ci ha abituato il mondo dello spettacolo. Lo è altrettanto che anche in Italia il camp comprenda una parte straordinaria della cultura gay, e che a una iconicità camp possano essere ricondotte molte italiane, dalla Marchesa Casati a Paola Borboni, alla grande Franca Valeri, fino a Mina e a tutte le divine della lirica (si pensi a Renata Tebaldi, o a Luisa Tetrazzini).
E non è difficile identificare una performance deliberatamente camp nella scrittura di Arbasino, certo, ma anche di Aldo Busi, nel cinema di Luchino Visconti ma pure nel pop romano di Mario Schifano, nel teatro di Paolo Poli e Carmelo Bene, nel cabaret dei Legnanesi di Felice Musazzi, nella musica leggera (con Renato Zero, Patty Pravo, Milva, Donatella Rettore, Loredana Berté, Ivan Cattaneo), in televisione (le sorelle Bandiera, più recentemente Platinette), in locali, costume e moda – ambito in cui, con Fiorucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace, Cavalli e quant’altri, il camp italiano fa indubbiamente scuola. Il che ci riporta là dove ci eravamo mossi, all’apologia di Isherwood. Il camp italiano, proprio perché ancor più elusivo della sua controparte angloamericana, e proprio perché ben poco praticato, non è dunque solo ‘legittimo’: è necessario (o se non altro, assai gratificante), al pari di quello sovietico, francese, tedesco, spagnolo, o sudamericano.
Accoglierlo, tanto nella prassi quanto nella critica, significa confrontarsi con la possibilità di costruire un quadro di intelligibilità – non solo fra diversi ordini estetici, ma anche fra aree culturali: fra New York e Londra, certo, così come fra Londra e Roma, Parigi, Santiago, Mosca o Madrid – che comprenda l’eterogeneo senza dirimerne la differenza. Significa cioè misurarsi con la sfida lanciata da percorsi inediti nella storia culturale italiana, e da un’indagine che, mutuando l’intelligenza sistemica e relazionale del camp, riconosca la specificità locale delle sue manifestazioni italiane. A partire dalla specificità dell’impianto normativo (la natura, il vero, il giusto), delle istituzioni di gusto e delle costruzioni identitarie, con cui il camp si è misurato e che, con gesto un poco forse outré ma certamente squisito, ha non di rado irriso. Per molti versi, allora, la storia del camp in Italia inizia oggi.
Sipario.
Clicca qui per acquistare il volume 1