La vibrazione nascosta nel paesaggio / Giacimenti della memoria di guerra
Tra i non pochi equivoci del postmodernismo, uno dei più influenti è stato l’interpretazione del cosiddetto spatial turn quale sostituzione della geografia alla storia. Se le «grandi narrazioni» della modernità avevano peccato di fede eccessiva in uno storicismo progressivo e teleologico, il tempo a seguire sarebbe connotato da un cambiamento di paradigma in grado di rappresentare i fenomeni culturali su un piano non più inclinato in una determinata direzione, bensì disteso in uno spazio a due dimensioni, senza vettori privilegiati. Era questa che si chiamava, appunto, la fine della storia. E invece se c’è una cosa che in questi ultimi decenni ci ha insegnato la migliore geografia culturale (penso a un geografo come Franco Farinelli, a uno storico come Karl Schlögel o a un comparatista come Michael Jakob), è che intendere i fenomeni sotto la specie della loro localizzazione nello spazio comporta né più né meno che un modo nuovo di percepirne la storicità. La superficie di un piano è quella che vediamo, certo, ma essa sottende stratificazioni e dislivelli che di quel piano – il nostro presente – sono la genealogia e l’archeologia. La nostra storia, appunto.
Lo dimostra, agli albori del tempo dopo la modernità, quello che fu il primo – e allora, infatti, scandaloso – incunabolo cinematografico dell’interminabile elaborazione del lutto per quello che da allora, della modernità, è stato l’insostenibile estremo; e che ha trasformato gli ultimi settant’anni in un ininterrotto dopoguerra (o Postwar, come è meglio scelto il nuovo titolo della capitale opera di Tony Judt, da poco ripubblicata da Laterza). All’inizio di Nuit et brouillard, il mediometraggio realizzato nel 1955 da Alain Resnais, una panoramica scende dal cielo chiaro e da un orizzonte imperturbato sino a inquadrare un reticolato; si sente un flauto intonare una melodia bucolica di Hanns Eisler, e la voce di Michel Bouquet recitare le parole di Jean Cayrol: «Persino un paesaggio tranquillo, persino una campagna con il volo dei corvi, […] persino un paese di villeggiatura, con la sua fiera e il suo campanile, possono portare banalmente a un campo di concentramento» (cito dalla bella edizione, pubblicata nel 2014 dall’editore triestino Nonostante, di Notte e nebbia: che di Cayrol riporta, con postfazione di Boris Pahor, oltre al testo per il film, anche le poesie omonime). A far scandalo, nel film di Resnais, fu tra le altre cose la scelta di giustapporre quelle immagini quiete, dai colori pastello, al più crudo bianco e nero delle foto e dei filmati che, a testimonianza della Shoah, all’epoca si conoscessero. Ma in questo modo si riusciva a esprimere, oltre alla brutalità del passato, anche la più sottile nequizia del presente: quella che, sulla «topografia del terrore» (Schlögel), in appena un decennio aveva steso una pellicola d’oblio in forma di paesaggio. Come proseguiva Cayrol: «un’erba assurda è spuntata e ha coperto la terra consumata dai passi concentrazionari […] invano tentiamo di rinvenirne i resti».
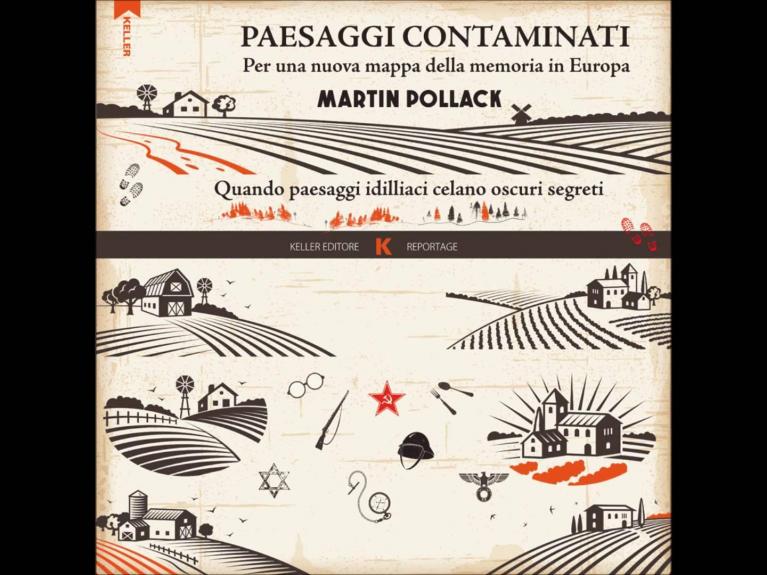
Passati altri sessant’anni, come si sa, alla reticenza e all’indifferenza è seguito il museo. O il parco a tema. La topografia del terrore è divenuta galleria degli orrori, per i turisti di guerra che su Instagram taggano il selfie ad Auschwitz «#juden#arbeitmachtfrei#zyklonb#feelgood», così contribuendo a formare quello che Guido Mazzoni ha definito l’«etere psichico della nostra epoca». È ingannevole, la museificazione dei traumi del Novecento, anche perché, isolando nel paesaggio dei punti privilegiati di male assoluto, implicitamente costituisce come innocente tutto lo spazio circostante. Cioè quello in cui, tornati dall’horror tour, continuiamo placidamente ad abitare. Quando invece siamo ben lontani dal conoscere nel dettaglio la sterminata parcellizzazione dei paesaggi contaminati: quelli cioè che ancora nascondono i luoghi degli eccidi sanguinosi e delle frettolose sepolture, la mimetizzazione dell’orrore che si stende per gran parte del territorio europeo.
Quasi un manuale, tecnico oltre che deontologico (che non si perita per esempio d’invocare l’ausilio dell’archeologia forense), per tentare di rivenire i resti di quell’orrore, di quegli orrori (talora sovrappostisi, guerra dopo guerra ed eccidio dopo eccidio, gli uni sopra i palinsesti degli altri: «spesso le vittime erano i colpevoli, e i colpevoli divennero poi le vittime»), è il piccolo, indispensabile libro dello scrittore tedesco Martin Pollack, dal titolo Paesaggi contaminati appunto, pubblicato l’anno scorso dall’editore Keller di Rovereto. Nato nel 1944, figlio del comandante di un Einsatzgruppe della Wehrmacht, Pollack ha scoperto in prima persona, sulla pelle psichica della sua terra (il Burgenland, al confine fra Austria e Slovenia), la radiazione fossile che contamina il paesaggio. Un bel giorno trova nel suo orto una forchetta conficcata nel terreno: una volta estratta e ripulita, il suo acciaio inossidabile fa luccicare il punzone Waffen-SS. Quel segno del passato che sporge dalla terra decide della sua vita, dell’ossessione per cui «proprio l’aspetto poco appariscente dei luoghi, il fatto che nulla faccia pensare a ciò che vi accadde, conferisce loro un’aria spettrale, anzi minacciosa».
Quello che è il capolavoro di Andrea Zanzotto, Il Galateo in Bosco (1978), è segnato da una simile sensibilità nei confronti non tanto della guerra cui aveva preso parte in prima persona bensì, anche stavolta, del trauma che nel suo sangue circolava per via patrilineare (il poeta era nato nel ’21): quel ’15-18 i cui «pezzi di guerra sporgenti da terra», negli «os-ossari» del Montello, marchiano una volta per tutte il suo «esistere psichicamente», il suo sguardo «dietro il paesaggio». E non è un caso che uno dei nostri migliori giovani studiosi, Matteo Giancotti, che nel 2013 i Luoghi e paesaggi di Zanzotto ha raccolto in un’edizione esemplare, proponga ora presso lo stesso Bompiani un libro innovativo sin dal titolo, Paesaggi del trauma. Le due grandi guerre del Secolo breve si sono impresse nella letteratura (non solo e non tanto quella loro contemporanea) «come una memoria culturale del trauma», che proprio nelle viscere della terra va archeologicamente scovata.
Rileggendo in modo nuovo testi fondativi come la Filosofia del paesaggio di Simmel e la Teoria del partigiano di Schmitt, e incrociando alla filologia storia geografia e appunto teoria del paesaggio, Giancotti può così individuare due crinali fondamentali, due «linee degli ossari» – per dirla con Zanzotto – che percorrono il secolo: quella appunto della Grande guerra, già studiata in tal senso ma ora metodicamente riletta in questa luce (con pagine acute, per esempio, su Renato Serra, Giovanni Comisso, Emilio Lussu e sul grande e misconosciuto Camillo Sbarbaro), e quella della Guerra civile del ’43-45, che dalla sua analisi esce con un aspetto assai lontano dalla vulgata (e qui i protagonisti sono Fenoglio, Calvino e Meneghello ma anche Caproni, il Fortini di Sere in Valdossola e, dall’altra parte della barricata, il Carlo Mazzantini di A cercar la bella morte). Una delle novità di questo approccio è proprio quello di giustapporre, alle canoniche figurazioni della natura sconvolta e brutalizzata dalla guerra, la «finta quiete» di paesaggi idilliaci, se non proprio edenici, che per reazione evocano – con una sindrome à la Pollack, o à la Resnais – «la vibrazione nascosta» che li rende, nelle parole del Partigiano Johnny, «vacui e stregati». Quello che Clemente Rebora, il più grande nostro poeta del primo quarto del Novecento (e del quale non a caso Giancotti è fra i nostri maggiori studiosi), codificò, nel 1922, come il «tempo che la vita era inesplosa».
Oppure la considerazione dei testi nel loro isotropismo al «restringimento del campo della coscienza» che Agostino Gemelli diagnosticò al soldato della Grande Guerra. Molto interessante, uscito insieme al libro di Giancotti, il breve saggio dal titolo Paesaggio di guerra, scritto nel ’17 durante un congedo dai combattimenti ai quali aveva preso parte da soldato semplice volontario, di uno dei padri della psicologia sociale, Kurt Lewin (il quale, ebreo e socialista costretto all’esilio nel ’33, ebbe in sorte di coniare l’espressione resa funesta dai nazisti, Lebensraum, «spazio vitale»). Anticipando cogli strumenti della Gestalt-psychologie il concetto di Ortung dello Schmitt del Nomos della terra, Lewin mostra che mentre quello di pace è uno «spazio arrotondato, senza davanti e senza dietro», quello di guerra è un «paesaggio delimitato», marchiato e vettorializzato dall’uso che della terra fa il combattente: proprio quello che dirà Schmitt nella Teoria del partigiano (e che ha messo a frutto, per il repertorio della Guerra civile, Gabriele Pedullà nella sua bella antologia dei Racconti della Resistenza). Lo stesso paesaggio infatti, visto dai reduci a distanza di tempo dai combattimenti, appare loro irriconoscibile.
Un paesaggio-sutura, una benda che si è stesa sul trauma per curarlo ma insieme per celarlo. Ma il trauma è sempre pronto a riemergere, come un revênant, deformando sottilmente quella che diventa, allora, una terra-sintomo. Racconta Pollack che a Hrastovec, in Slovenia, nel ’45 i partigiani jugoslavi pensarono di impiegare il fango delle peschiere del luogo, da loro svuotate, per seppellire le minoranze tedesche e ungheresi da loro eliminate dopo la ritirata della Wehrmacht. Ma testimoniano i contadini del luogo che i gas prodotti dalla putrefazione dei cadaveri fecero sì che per diversi inverni quegli stagni non riuscissero a gelare del tutto. Il ghiaccio dell’oblio si incrinava e infine si spezzava, riportando alla luce l’orrore di un secolo ancora tutto da scavare.
Matteo Giancotti, Paesaggi del trauma, Bompiani, pp. 264; Martin Pollack, Paesaggi contaminati, traduzione di Melissa Maggioni, Keller, pp. 144; Kurt Lewin, Paesaggio di guerra, a cura di Raffaele Scolari, Mimesis, pp. 43. Altri testi citati: Jean Cayrol, Notte e nebbia, a cura di Giovanni Pilastro, traduzione di Nicola Muschitiello, postfazione di Boris Pahor, Nonostante, pp. 188; Tony Judt, Postwar. Europa 1945-2005, traduzione di Aldo Piccato, Laterza, pp. X-1075; Andrea Zanzotto, Luoghi e paesaggi, a cura di Matteo Giancotti, Bompiani, pp. 230; Guido Mazzoni, I destini generali, Laterza, pp. 122; Racconti della Resistenza, a cura di Gabriele Pedullà, Einaudi, pp. XLIV-346.
Una versione più breve di questo articolo è uscita l’8 ottobre sul «Sole 24 ore».









