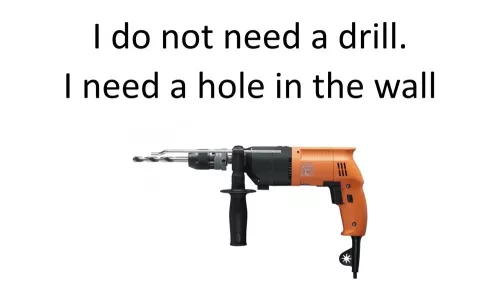Speciale
La solidarietà debole
Negli ultimi anni, molti hanno visto nella sharing economy una risposta solidale e comunitaria all’individualismo spinto di quel mercato neoliberale che si configura come una situazione di competizione sfrenata in cui si trova una parte sempre più grande del ceto medio, costretta a lavorare come freelance.
“Sharare” – un nuovo verbo in italiano – non sarebbe solo una nuova modalità di condividere risorse in una congiuntura economica sempre più difficile, ma potrebbe anche essere un nuovo modo di tessere quella rete di relazioni che può agire da contrappeso alla logica del mercato, dando così origine a nuovi valori e, perché no, provocando un risveglio di quella politica di sinistra ormai profondamente addormentata. Sarà che, come sostiene Ciccarelli, in Italia sta crescendo il mondo del mutuo soccorso, ma di questo poco si deve alla sharing economy. Al contrario, è sorprendente quanto, all’interno di questo contesto, siano scarsi gli esempi di solidarietà concreta.
Secondo le dinamiche della sharing economy, si possono condividere le risorse materiali che per il momento non servono – come il trapano prestato ai vicini del social street – o momenti di socialità, skills e consigli professionali; molto raramente, però, questa condivisione arriva a coinvolgere risorse economiche tangibili. Soprattutto, la sharing economy non dà origine a una posizione antagonista, come succedeva per l’economia morale della classe operaia nel secolo scorso: prevale, invece, quella che potremmo chiamare una “solidarietà debole”.
Queste dinamiche sono molto chiare negli spazi di co-working: anche se avviene una continua condivisione di competenze, di contatti e di consigli su come gestire clienti e creare un brand personale, il co-working non si costituisce mai come un’alternativa al mercato. Anzi, nei co-working si impara principalmente come posizionarsi in modo efficiente sul mercato. Anche se i co-worker riconoscono di condividere una situazione comune, ossia di essere precari e generalmente sottopagati, questa consapevolezza non si traduce mai in una critica al mercato: né al mercato come istituzione – perché le responsabilità sono dovute principalmente ai “burocrati” o ai “politici” – né al prezzo di mercato: non esiste, come nel movimento operaio di fine Ottocento, una concezione del giusto valore del lavoro che può servire come base per una critica del suo prezzo di mercato. La “solidarietà debole” è una solidarietà di mercato, una solidarietà imprenditoriale.

Ciò si spiega con le condizioni particolari del lavoro “creativo” freelance, sottoposto a una contraddizione fondamentale: per il movimento operaio ottocentesco era possibile concepire un giusto valore del lavoro che fosse diverso dal suo prezzo di mercato, perché il valore del prodotto era in qualche modo riconducibile al tempo speso per realizzarlo; per un lavoratore “creativo”, oggi, il legame tra lavoro e valore si è completamente spezzato. Per un freelancer il valore dello sforzo dipende invece, come Tiziano Bonini ha descritto chiaramente, della reputazione: un architetto qualsiasi percepisce un reddito ai limiti della sopravvivenza, mentre un’archistar viene riempita di soldi anche se progetta mostruosità. In una situazione del genere, il reddito è determinato dalla capacità di costruirsi una reputazione che legittima una posizione di mercato. La costruzione di una reputazione, però, è anche un’impresa biopolitica e sussume tutta la personalità del co-worker, ossia i suoi interessi, il suo stile di vita e la sua capacità di collaborare con gli altri. In questo modo la collaborazione non è fuori ma dentro al mercato, la capacità di collaborare diventa misurabile come un prezioso bene reputazionale e, per questo, viene gestita in modo riflessivo.
In più, la reputazione non è dovuta unicamente alla capacità di condividere capitali sociali e culturali ma anche, e forse principalmente, alla capacità di creare un’esperienza collaborativa. Con la “creatività” del co-working, i co-worker intendono principalmente l’ambiente positivo ed energizzante che rende possibile autoconvincersi, nonostante le difficoltà economiche, che la propria attività e la propria scelta abbiano un senso. Si collabora anche condividendo le proprie competenze e skills, ma la collaborazione consiste soprattutto nella creazione di un’esperienza positiva quotidiana. L’obbligo di creare affettività positiva è profondamente inscritta nell’habitus dei co-worker stessi: bisogna comportarsi in modo particolare, gestire le emozioni (non va bene mostrarsi eccessivamente depresso a causa, ad esempio, dell’assenza di lavoro), occorre parlare di precisi argomenti (le questioni di lavoro bene; quelle personali, oltre un certo limite, meno bene). Soprattutto, non bisogna creare energia negativa. Il fatto che la propria capacità di creare un’affettività positiva vada curata quotidianamente, come una fonte di valore reputazionale, fa sì che la socialità fra i co-worker non diventi quasi mai collettiva e solidale: non si forma una comunità con valori più grandi del singolo, ma si co-crea una serie di esperienze in cui il singolo può trovare conferma della sua identità come co-worker.
L’idea dello sharing come co-creazione di un’affettività interpersonale è anche rispecchiata nella filosofia politica dei co-worker socialmente impegnati: per gli imprenditori sociali, o changemaker, è importante cercare di “cambiare il mondo”, però, alla fine, “cambiare il mondo” si riduce, alla Hayek, nel cambiare le persone che stanno intorno, ed è ben diverso dalla realizzazione di un progetto collettivo.
La “solidarietà debole” dei co-worker può sembrare superficiale e certamente non sembra in grado di arrivare, da sola, a un progetto politico. Tuttavia si tratta di early days e, come si verificò con il movimento operaio ottocentesco, i possibili conflitti futuri potrebbero dare una svolta più collettivista anche agli imprenditori del sé che popolano il mondo del lavoro creativo contemporaneo. Oppure potrebbe succedere che una solidarietà più forte si sviluppi in altri modi. Più che al movimento operaio, i co-worker assomigliano ai mercanti scozzesi di cui parlò Adam Smith: ognuno sta sul mercato grazie alla reputazione che può conquistare presso i suoi pari e, per questo motivo, bisogna comportarsi con prudence e propriety. Forse la reputazione può, in questo modo, trasformarsi in una moralità in grado di cambiare il mondo descritto da Bonini in una sorta di economica etica in cui la creazione sia del valore sia dei valori coincidono.