1 marzo 1922 - 1 marzo 2022 / Beppe Fenoglio. Corpo
La scrittura di Beppe Fenoglio, la tonalità delle sue pagine, il respiro delle sue narrazioni si intrecciano profondamente con il paesaggio delle Langhe e con la città di Alba, dove Fenoglio è nato cento anni fa il primo marzo 1922, e da cui nell’arco della sua vita non si è quasi mai allontanato. Nello straordinario patrimonio di immagini fotografiche dell’amico Aldo Agnelli, Fenoglio compare spesso ai margini di uno dei sentieri che ha percorso nei giorni del suo arruolamento fra i partigiani azzurri dopo l’8 settembre del ’43, con in tasca una matita e i fogli di uno di quei taccuini che suo padre, Amilcare Fenoglio, usava per i conti di bottega nella macelleria a pochi passi dal Duomo. I boschi sulle colline intorno ad Alba, i rittani in cui trovare rifugio, le cascine dei contadini, le cense, i filari di viti, i ciliegi, gli olmi, i sentieri fangosi attraversati durante la Resistenza e soprattutto l’Alta Langa di San Benedetto Belbo, dove una parte della famiglia aveva le sue origini, sono il grande corpo a cui Fenoglio si affida, ascoltandone le voci e assorbendone tutti gli umori.
Non si tratta propriamente di un paesaggio osservato, quanto piuttosto di una materia viva che permea ogni aspetto della scrittura, in un legame simbiotico con la terra, con gli animali e le piante, la pioggia e il vento, l’acqua dei fiumi e dei torrenti in cui i suoi personaggi si immergono nei punti di snodo della narrazione. L’origine delle storie che Fenoglio racconta, cominciando dalle narrazioni orali ascoltate nei ritrovi di famiglia e nelle trattorie di Santo Stefano, sta proprio in una stretta intimità con il mondo naturale che trova corrispondenza in una scrittura intessuta in un primo tempo di umori dialettali, e pertanto esposta, ai suoi esordi, all’equivoco di un verismo attardato. È sufficiente tuttavia rileggere le sue pagine, i racconti d’esordio I ventitré gironi della città di Alba, i romanzi La paga del sabato, La malora, Primavera di bellezza, Il partigiano Johnny, L’imboscata, Una questione privata, per comprendere come la sua ricerca andasse nella direzione di una scrittura che fosse in grado di ancorarsi al mondo allontanandosi dalle prospettive consuete di rappresentazione. Scrivere per Fenoglio significa prima di tutto ascoltare le voci degli altri e restituirle con tutte le marche d’origine di cui sono impregnate, trattando le parole come corpi senzienti nati dal grande organismo della natura, che li genera e li contiene. C’è un animismo di fondo che attraversa le sue pagine e le plasma attraverso una scrittura materica, sempre fuori chiave rispetto agli orizzonti di attesa dei suoi primi critici-lettori, che non riescono a collocarla in nessuna delle categorie acquisite, con abbagli e fraintendimenti che Fenoglio sente per tutta la vita come una ferita aperta.

Tutto comincia con un rapporto difficile con la parola: parlare di fronte agli altri era per Beppe un’impresa difficile, come ricordano i suoi familiari e i suoi insegnanti di liceo. Non propriamente una balbuzie, ma un blocco dell’eloquio si manifestava con pause intermittenti che gli provocavano rabbia e imbarazzo. Per Fenoglio le parole hanno avuto da sempre un peso specifico che avverte fin da ragazzo, quando al liceo cominciano a manifestarsi quei perturbamenti dell’espressione che lo obbligano a interrompere una frase per riprenderla dopo una pausa di qualche secondo. “Le parole gli saltavan via di bocca, una dietro l’altra come se per ognuna ci volesse uno spintone da dietro, proprio come quei tre della cocaina che erano dovuti saltare nel lago di montagna”, – scriverà in una pagina del romanzo La paga del sabato raccontando le vicende di Ettore, l’ex partigiano che cerca un riscatto associandosi a un gruppo di sbandati e ai loro traffici loschi. Anche la scrittura sembra dover operare quel salto, alla ricerca di una forma di materialità senziente – come l’ha definita Guido Guglielmi scrivendo di Il partigiano Johnny –, negli stati del corpo che costituiscono il livello profondo di verità del personaggio. Si tratta di corpi in perenne movimento e in condizione di precarietà, sepolti o inghiottiti dalla terra, come il cadavere del padre di Agostino Braida che apre la vicenda di La malora in una di quelle «scene assolute» in cui Stevenson riconosceva il sigillo dell’arte di raccontare: “Pioveva su tutte le langhe, lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Era mancato nella notte di giovedì l’altro e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il mio padrone m’aveva anticipato tre marenghi, altrimenti in tutta casa nostra non c’era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel’avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto tirare un po’ su testa. Io ero ripartito la mattina di mercoledì, mia madre voleva mettermi nel fagotto la mia parte dei vestiti di nostro padre, ma io le dissi di schivarmeli, che li avrei presi alla prima licenza che mi ridava Tobia. […] Avevo appena sotterrato mio padre e già andavo a ripigliare in tutto e per tutto la mia vita grama, neanche la morte di mio padre valeva a cambiarmi il destino. E allora potevo tagliare a destra, arrivare a Belbo e cercarmi un gorgo profondo abbastanza”.
Lo sguardo di Agostino Braida, il giovane bracciante che vediamo per la prima volta al funerale del padre, quel padre che a diciassette anni lo aveva portato al mercato di Niella per venderlo come bracciante, si muove in una prospettiva che potremmo definire, etimologicamente, «subliminale»: l'occhio si pone infatti nell'ottica della morte, oltre il limite dell'esistenza, o meglio, sotto quel limite, al livello del corpo bagnato dalla pioggia e restituito alla terra. L’incipit delimita, con un rapidissimo giro di frase, lo spazio del romanzo, includendolo in una prospettiva favolosa di ampi orizzonti («tutte le langhe»), attraverso l’uso dell’imperfetto, il tempo fiabesco per eccellenza e attraverso la modalità del racconto che Gianni Celati ha definito «narrazione per piani panoramici».
Vista così, anche l’esperienza personale e determinata della morte del padre entra a far parte di una storia più grande, come una delle tante storie possibili accadute sotto il cielo che abbraccia l’unica terra che Agostino abbia mai conosciuto. Si tratta della «prima acqua», altre ne seguiranno, come altri seguiranno, inevitabilmente, il destino del padre. La pioggia, designata con il termine più generale dell’elemento primario a cui appartiene, bagna il corpo, abbracciandolo come parte di un tutto che lo trascende e il corpo, a sua volta, sprigiona una forza di attrazione da cui Agostino si sente trascinare, come era già accaduto ad altri vissuti in quelle terre. Il corpo collocato sottoterra conferisce una tonalità all’intero racconto: la morte esercita infatti un fascino pericoloso sul ragazzo, come è accaduto a tanti altri di «razza langhetta» che hanno deciso di farla finita gettandosi nel fiume e come era accaduto a Ettore, protagonista di La paga del sabato, al momento di decidere quale direzione dare alla sua vita. Anche ad Agostino capita di pensare al suicidio, ma è proprio passando davanti al luogo dove sono sepolti i suoi morti, il cimitero del paese intravisto mentre percorre la strada verso il fiume, che il ragazzo si sente come un padrone sulla sua terra e decide di accettare la vita, per quanto difficile essa sia, cercando di riempire con le forze residue il vuoto di senso provocato dall'esperienza del lutto: le gambe lo porteranno lungo i sentieri dei suoi paesi, le braccia lavoreranno la terra, gli occhi guarderanno il mondo, le orecchie ne raccoglieranno i suoni e ascolteranno le storie che circolano nell'aria.
Il regista Guido Chiesa, nel documentario Una questione privata. Vita di Beppe Fenoglio, coglie con straordinaria sensibilità il rapporto che Fenoglio aveva con l’arte del raccontare: non si limita infatti a riportare delle testimonianze, come spesso accade nel genere della biografia per immagini, ma fa emergere le esperienze di vita da una prospettiva corale, fatta di voci che si richiamano e si intrecciano in una forma di racconto collettivo in cui i testi si inseriscono senza soluzione di continuità, anche quando sembrano allontanarsi dal fondo che li ha generati. Da quel fondo di voci prendono origine le diverse direzioni di ricerca che Fenoglio segue nella sua storia di narratore, inizialmente rivolgendosi alla lingua che gli era più familiare, il dialetto dei suoi antenati, che si ritrova nell’intonazione, nell’andamento ruvido e paratattico della prosa, nel registro colloquiale e nelle scelte lessicali a cui ricorre per raccontare la vicenda di Agostino Braida, con le parole “parole precise e vere”, di cui aveva parlato Calvino.
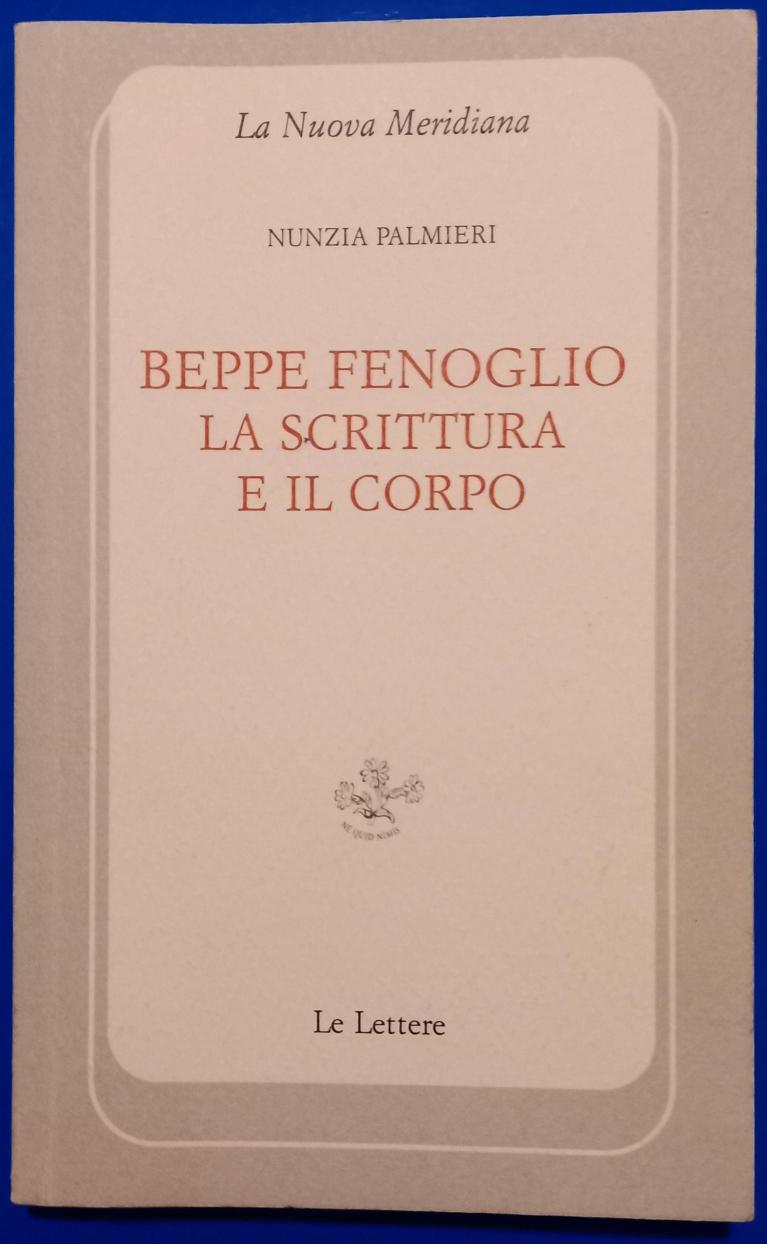
Non si trattava in questo caso di “colore locale”, quanto piuttosto, come ha fatto notare Gianluigi Beccaria in Le forme della lontananza, di una lingua fuori epoca, una denaturalizzazione della lingua, una regressione verso l’antichità che conduce, in un altro momento della storia di Fenoglio, a cercare nuovi modi espressione nel grande stile del Partigiano Johnny. Quello che Fenoglio definisce “il libro grosso”, scritto in prima redazione in un inglese inventato che ha avuto molteplici definizioni (fenglese, itanglese, itangliano, fenogliano), aveva bisogno una lingua magica, mobile e libera, che gli permettesse di allontanarsi, in una direzione opposta a quella seguita in La malora, dal grado zero della scrittura. Pietro Chiodi, filosofo, traduttore e professore di Storia e filosofia di Fenoglio al liceo di Alba, racconta come è nato il rapporto d’amore con questa lingua: Fenoglio si era immerso, “come un pesce si immerge nell’acqua, nel mondo della letteratura inglese, nella vita, nel costume, nella lingua, nei grandi autori” – racconta Chiodi. Shakespeare, Milton, Marlowe, Donne, Hopkins, Coleridge, Melville, Brontë, Hemingway, Faulkner, Steinbeck, letti, tradotti, amati come via di fuga dal nazionalismo fascista, come modello culturale e come terreno di coltura dove far nascere una lingua nuova. Nelle diverse redazioni di Il partigiano, attraversate da un’inquietudine evidente nel continuo processo di scomposizione e ricomposizione a cui i testi sono stati sottoposti e che i curatori hanno assemblato con criteri diversi (prima nel 1968, nell’edizione curata per Einaudi da Lorenzo Mondo, poi, più di recente e sempre per Einaudi, nella versione più ampia curata da Gabriele Pedullà nel 2015), le parole hanno una consistenza tridimensionale, si svincolano dalle pretese della mimesi del reale o dagli obblighi della rimemorazione e creano un mondo in conflitto con lo sforzo di restituzione della grande storia e con il percorso individuale di ricerca di senso che i personaggi devono compiere.
La ricerca di senso affidata agli stati del corpo trova un’espressione compiuta in Una questione privata, il romanzo di materia partigiana che Fenoglio ha lasciato nei cassetti in tre versioni diverse, e che insieme a Il partigiano Johnny è considerato il suo capolavoro: qui la materia partigiana si intreccia alle vicende sentimentali del giovane Milton, che si mette alla ricerca di una verità dei rapporti intercorsi fra Giorgio, amico e compagno d’avventura sulle colline delle Langhe, e Fulvia, la ragazza di cui Milton si è innamorato frequentando la sua casa in tempo di pace. Si tratta di una ricerca destinata a non trovare un punto di scioglimento definitivo, ma che pure obbliga il partigiano Milton a interrogarsi sul senso della guerra, sulle svolte improvvise del destino, quando si trova a dover uccidere su malgrado un prigioniero che aveva catturato per poterlo scambiare con l’amico Giorgio che a sua volta era prigioniero dei fascisti.
Per raccontare le vicende di Milton Fenoglio abbandona lo stile epico di Il partigiano per ritornare ai modelli del romance, intrecciando le storie che aveva ascoltato nelle serate passate in cascina con i compagni e recuperando strutture narrative della tradizione in una forma nuova e originalissima. Nella prefazione alla seconda edizione di Il sentiero dei nidi di ragno Calvino riconosce a Fenoglio il grande merito di aver dato spessore e verità alle vicende che ha raccontato: “Solo ora, grazie a Fenoglio – scrive Calvino –, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita: Una questione privata [...] è costruito con la geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l’Orlando furioso, e nello stesso tempo c’è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente nella memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione, e la furia. [...] Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro, e quest’altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché”.

La grandezza di Fenoglio sta proprio nella sua meravigliosa capacità di raccontare conferendo alla natura una forma di animazione, nel respiro del vento che porta messaggi incomprensibili, nell’intrico del bosco, che a volte accoglie e protegge, a volte si chiude come una prigione intorno ai protagonisti dei suoi racconti, nei sentieri di montagna, nei rittani scoscesi, nei tramonti sulle colline che non vengo sentiti come punto di pacificazione ma che anticipano il buio inquietante della notte. “L’esercito è un sogno morboso, solo la natura è reale”, dice Johnny in Primavera di bellezza. Alla natura portatrice di messaggi indecifrabili, accogliente, terribile e piena di mistero, Milton si affida correndo per sfuggire alla morte. Il finale di Una questione privata non ci dice se per Milton il bosco che si chiude sul corpo al termine di una cavalcata che muta l’uomo in vento, in fango, in cavallo al galoppo, sia un punto di approdo sicuro o un segno di morte: “Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò”.
Sulla sorte di Milton, sulla compiutezza o incompiutezza del finale dell’ultimo romanzo di Fenoglio si è dibattuto a lungo. Quel che è certo è che Fenoglio si congeda dalla scrittura affidando il destino del suo personaggio alla sua pura sostanza corporea, abbandonata dai pensieri e dal cuore, svincolata dalla presa della volontà, sagoma di cavallo impazzito, palla di fango, ammasso di ossa scarnificate dalla violenza dell’acqua. Nella corsa di Milton la terra si apre sinistramente, mostra il suo ventre infernale, e il crescendo drammatico si stempera in quelle ultime note, dove gli alberi recuperano il loro posto di presenze mute. Forse un finale compiuto va cercato fra le pagine di quegli appunti partigiani tracciati sui fogli della macelleria, dove Fenoglio fa il bilancio di una battaglia vinta, restituendo a tutta la vicenda drammatica il senso di un destino che trascende gli uomini e la loro storia: “Erano venuti in tre divisioni, per setacciare tutto e tutti. Ma, chiedo perdono ai morti e alle loro famiglie, scusa a quelli che ci han perduta la casa e il bestiame, ma io credo che allora tedeschi e fascisti non si siano salvate le spese. Non fu abilità nostra, né che loro fossero tutte schiappe. Fu, con la sua terra, la sua pietra e il suo bosco, la Langa, la nostra grande madre Langa”.









