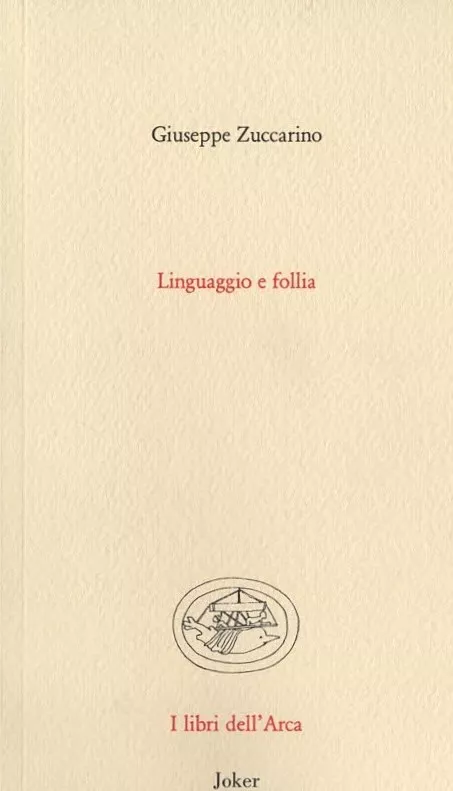Da Roussel a Wolfson. Linguaggio e follia
Il linguaggio non è soltanto un medium, uno strumento, ma anche un corpo: se ne può riconoscere la conformazione anatomica, disarticolarlo e ricomporlo, può diventare l’origine di infinite metamorfosi. È un corpo che si può amare, esplorare in ogni sua piega, da cui ci si può allontanare, che si può ferire, respingere. È un luogo che mostra i segni del tempo, la traccia delle esperienze e degli anni. Le parole, le frasi, hanno questa natura: sono mani, volti, occhi che ci guardano. A volte ci seguono, come un rimorso che non ci abbandona. Scrivere significa far emergere questa dimensione del linguaggio, esporla sulla superficie di una pagina, accedere ‒ tramite un ritmo, un borbottio, la sostanza e la fisionomia dei grafemi ‒ a qualcosa che nella realtà quotidiana resta quasi sempre occulto, sotterraneo, nascosto da tutte le funzioni che un dialogo o un discorso mettono in atto. Se questa realtà è ciò che ogni autentico scrittore conosce assai bene, la follia equivale a sprofondare in essa, a viverla senza più soluzione di continuità, a riconoscere il linguaggio unicamente in questa forma, in una condizione da cui non è più possibile evadere.
Su queste dinamiche invita a confrontarci un libro di Giuseppe Zuccarino, Linguaggio e follia, da poco uscito presso le edizioni Joker. Il volume raccoglie sei saggi, la cui stesura va dal 2014 al 2023, dedicati ad altrettanti autori (Raymond Roussel, Robert Walser, Antonin Artaud, Raymond Queneau, Unica Zürn e Louis Wolfson) e al nesso che nelle loro opere si instaura tra la follia e la materialità del linguaggio.
L’analisi condotta da Zuccarino non trascura i percorsi clinici e i dati biografici degli autori considerati. Nel caso di Walser (Penna e matita. Sui microgrammi di Walser), per esempio, il critico nota come il piano biografico e quello letterario siano strettamente correlati. Vi sono nell’opera di Walser riferimenti ai mestieri da lui svolti, mestieri nei quali la penna riveste un ruolo decisivo. Tra i più insoliti, l’impiego in una copisteria per disoccupati, luogo che lo scrittore svizzero fa descrivere da una creatura della sua immaginazione: Simon Tanner. Al pari del suo personaggio, Walser avvertiva il lavoro d’ufficio come tendenzialmente incompatibile con la propria vocazione di poeta e narratore, trovando conforto soltanto nel comporre, in un’elegante calligrafia, poesie su strette strisce di carta. Ma questo quadro, in cui la penna recita il ruolo di protagonista, è stato modificato dalla scoperta, nel lascito testamentario dello scrittore, di 526 fogli disparati contenenti «brevi prose, scene dialogate, poesie e persino un intero romanzo». Su quei fogli Walser ha tracciato col lapis, in una grafia minutissima e in apparenza illeggibile, testi quasi del tutto privi di correzioni e cancellature. Il ricorso alla matita non è un dato insignificante: corrisponde, al contrario, al tentativo di aggirare ‒ con la possibilità di accedere a una dimensione più calma, quasi onirica ‒ il blocco psicologico provocato, a un certo punto dell’esistenza dello scrittore svizzero, dall’uso della penna. Alla dimensione labile e provvisoria, quei fogli associano un altro tratto essenziale: la micrografia. Essa trasforma i foglietti in testi segreti e soprattutto, verrebbe da aggiungere, in segnali che alludono al destino di Walser, in bilico tra il silenzio e l’esile traccia della scrittura.

Per certi versi opposto è il caso di Artaud (L’utopia della lingua nell’ultimo Artaud). Nella sua opera, ci ricorda Zuccarino, la ricerca di nuovi modi di espressione rappresenta un costante obiettivo. Artaud insegue una lingua impossibile, tale da scuotere la stessa architettura logico-sintattica del discorso. Si tratta di un progetto che si fa più urgente negli ultimi anni della vita dello scrittore, ma che affonda le sue radici nelle riflessioni sul teatro (sfociate nell’opera forse più nota di Artaud, Il teatro e il suo doppio) e che si traduce nella formula e nei modi di una scrittura ad alta voce. In cosa consiste? Si tratta dell’abitudine, da parte di Artaud, di ritmare il respiro, di salmodiare, di gridare, di portare insomma, come ha osservato Deleuze, «le grida-respiri allo stato di linguaggio». Un processo che, privilegiando «la vocalità rispetto alla scrittura, la lingua inesistente rispetto alle lingue esistenti», annota Zuccarino, sfocia nella pratica della glossolalia, cioè nella coniazione, tipica del linguaggio dei bambini e in qualche caso degli schizofrenici, di parole asemantiche. L’obiettivo è una lingua potenzialmente universale, alla portata degli illetterati. Artaud sembra gettare uno sguardo su un tempo futuro, quello in cui non soltanto la lingua sarà diversa, ma diverso apparirà anche, tra voce e respiro, il corpo dell’uomo.
Il rinnovamento del linguaggio e le stranezze che questo tentativo costantemente comporta si accompagnano, in Raymond Roussel, a una lucida analisi dei propri mezzi espressivi (Roussel, produttore di congegni verbali). Lo testimonia la pubblicazione, nel 1935, del volume postumo Come ho scritto alcuni miei libri. L’opera in cui il metodo compositivo di Roussel raggiunge un più alto livello di complessità è probabilmente Impressions d’Afrique. Qui, ciò che appare in superficie come un romanzo d’avventure di ambientazione esotica rivela, a uno sguardo più approfondito e soprattutto guidato dalle indicazioni dell’autore, un meccanismo sofisticato che, partendo da due frasi-matrici, procede per associazioni di idee e di vocaboli e genera, tramite l’elaborazione di calembours, i diversi particolari su cui si regge ogni episodio. Questa macchina linguistica, ci ricorda Zuccarino, trova il corrispettivo in altre macchine, «ancor più mirabolanti», che compaiono nel romanzo: dalla cetra che viene fatta suonare da un lombrico melomane al telaio che, azionato da un piccolo mulino ad acqua, tesse senza alcun intervento umano un mantello raffigurante la scena del Diluvio universale, Arca di Noè compresa. Per imbastire la trama è talvolta sufficiente, a Roussel, una sola frase, una frase qualsiasi, che viene poi scomposta in parole di suono simile, innescando in tal modo un meccanismo in grado di generare «un’intera scena da Mille e una notte».
Follia e linguaggio diventano in Raymond Queneau un importante campo d’indagine (Queneau sulle tracce dei pazzi letterari). Lo scrittore, all’inizio degli anni Trenta, dopo essersi staccato dal gruppo surrealista, frequentò la Bibliothèque nationale di Parigi alla ricerca – destinata a concretizzarsi in un’ampia antologia pubblicata postuma – degli scritti di coloro che, con definizione che peraltro egli stesso trovava discutibile, erano chiamati “pazzi letterari”. Si tratta di quelle persone che, «pur coltivando idee deliranti relative ai più diversi ambiti culturali, […] sono riuscite a pubblicare libri in cui hanno esposto le loro bizzarre teorie». I pazzi letterari, tuttavia, non possono essere liquidati, secondo Queneau, come dei casi clinici, perché ci lanciano un invito che non può lasciarci indifferenti: quello di attuare le nostre possibilità inespresse. Queneau individua quattro diversi ambiti in cui l’attività degli autori antologizzati si è manifestata: la matematica, le teorie relative al mondo, il linguaggio e l’autobiografia (intesa però come uno spazio per presentare se stessi come dei perseguitati, dei messia o dei profeti). Tra i diversi casi ricordati da Zuccarino merita particolare menzione quello di Jean-Pierre Brisset. Egli, nelle sue opere, facendo spesso ricorso a diversi tipi di giochi di parole, finì per elaborare una propria visione del mondo, paragonabile a una versione un po’ semplificata e stravagante dell’evoluzionismo, nella quale in principio erano le rane, successivamente evolutesi in esseri umani. Ma è sul piano linguistico che tutto diventa assolutamente inverosimile. Brisset afferma infatti che l’idioma primitivo era il francese, rispetto al quale le altre lingue, anche quelle da noi considerate più antiche, non sono che dei derivati. Da qui all’individuazione di uno strumento per decifrare tutta la realtà il passo, almeno per Brisset, è breve, sicché i suoni che compongono il francese diventano «la chiave universale capace di far comprendere ogni aspetto dell’esistenza». Brisset è una figura eccezionale anche per un altro motivo, perché tra i folli antologizzati è l’unico ad aver goduto di una certa fama, fino a suscitare l’interesse di filosofi come Deleuze e Foucault. Proprio su quest’ultimo, sugli scritti da lui dedicati alle teorie linguistiche di Brisset, Zuccarino ritorna nel saggio Foucault e il grammatico fantastico, che fa parte di un libro, Dittici. Filosofi tra parole e immagini, appena pubblicato da Mimesis.

La tendenza a scomporre e a ricomporre le parole in maniera originale e fantasiosa si ritrova nelle pagine di Unica Zürn (1916-1970), scrittrice e pittrice tedesca (Zürn e la follia creativa). Compagna di Hans Bellmer, amica di numerosi esponenti del surrealismo, Zürn dedicò il suo libro più rilevante, L’uomo nel gelsomino, al racconto, in terza persona, della propria vita. Nel descrivere gli episodi che l’hanno portata ad avere le prime crisi psicotiche, «l’autrice mescola di continuo reminiscenze del passato e presagi del futuro». Ma non si tratta della sola sfasatura presente nel testo, poiché Zürn appare in più di un’occasione incapace di distinguere le proprie fantasie o allucinazioni dalla realtà. Da qui derivano le prevedibili difficoltà nel rapporto con gli altri, le degenze in un ospedale psichiatrico, ma anche un atteggiamento che Zuccarino definisce di «follia cosciente» in opposizione a un mondo esterno che le appare banale e ostile. L’espressione artistica prende, a un certo punto, la forma di una vasta produzione di anagrammi, di sequenze di versi che ogni volta utilizzano, disponendole in maniera differente, le stesse lettere alfabetiche presenti nella frase di avvio. Follia e creatività alla fine coincidono.
Il discorso autobiografico contrassegna anche le pagine di Louis Wolfson, il cui libro più noto è Le Schizo et les langues. Zuccarino ce ne parla nell’ultimo capitolo del suo volume (Wolfson: le lingue straniere, le scommesse, le bombe). L’autore, di origine statunitense, ne aveva inviato il manoscritto all’editore Gallimard, che lo pubblicò nel 1970 con una prefazione di Gilles Deleuze. La scelta di adottare come medium linguistico il francese ci pone immediatamente di fronte al profilo schizofrenico dell’autore, che si traduce nel suo ostinato rifiuto di utilizzare l’inglese, la lingua materna, intesa, letteralmente, come lingua parlata dalla madre. L’ingombrante presenza di lei, che in casa ama suonare l’organo elettrico e che parla molto, con una voce squillante e acuta, provoca nel giovane Louis una crescente avversione per l’inglese ‒ al punto da indurlo a tapparsi le orecchie con le dita ‒ e in parallelo una forte passione per lo studio delle lingue estere. Ma ciò evidentemente non basta, infatti egli ricorre anche al procedimento di sfruttare le somiglianze fonetiche tra parole di lingue diverse per convertire ampie unità linguistiche inglesi in frasi realizzate con il ricorso al francese, al russo, al tedesco e all’ebraico. Le affinità fonetiche consentono il passaggio mentale ad altri idiomi: una fuga che, ricordava Michel Foucault, proprio grazie a questo metodo si rivela istantanea, e consente allo studente di lingua psicotico di spostarsi all’estero e di udire, finalmente, soltanto parole pacificate. Non sembra, però, che la mente di Wolfson abbia raggiunto uno stato di quiete, dal momento che in un’opera autobiografica successiva divengono frequenti le fantasie – alimentate anche dalla continua fabbricazione di ordigni da parte dell’industria bellica – su una definitiva e liberatoria esplosione nucleare.
Forse il caso di Wolfson, che non è possibile ripercorrere qui in tutti i suoi aspetti, mette in evidenza in maniera più vistosa, a volte non priva di tratti umoristici, alcune caratteristiche del rapporto tra linguaggio e follia che si incontrano, a diverso titolo, negli altri autori considerati. Tali caratteristiche possono andare anche oltre l’ambito che qui si è definito, e tradursi e riassumersi infine in una formula: scrivere è un gesto che si colloca tra ossessione e utopia.