Speciale
Letto in un’altra lingua / Danilo Kiš, La lezione di anatomia
Una questione scandalosa, soggettivamente
Non c’è, nel gioco radicalmente inutile della letteratura, scandalo più preciso e ridicolo dello scrittore allo specchio, intrappolato nella contemplazione della propria immagine. Perché proprio io?, si chiede lo scrittore in questione – esausto, disgustato dallo spettacolo che non può fare a meno di giudicare (lo spettacolo non riguarda la propria immagine allo specchio, ma il suo stesso sguardo tenuto ad osservarla). Perché questo dramma?, si chiede di nuovo. È confuso: rapito dall’intensità del momento, dimentica due fattori essenziali: questo non è il suo dramma ma il dramma di tutti; riflessa allo specchio non c’è la sua immagine, ma la sua opera. La sua immagine non conta niente.
Così, in questo ciclico esercizio di ossequio e obliterazione della vanità si consuma, in condizioni normali, la relazione del nostro scrittore (che è appunto tutti gli scrittori) con la propria opera. Tuttavia le condizioni da cui viene fuori, nel 1978, Čas anatomije (“La lezione di anatomia”, ancora inedito in Italia), di Danilo Kiš, non hanno niente di normale: lo scherno e la diffamazione, le accuse di plagio (più improprie che false) all’indirizzo di Kiš in merito a Una tomba per Boris Davidovič; il risentimento smisurato (degli accusatori e dell’accusato); una vena di antisemitismo mascherata da colore locale (colore jugoslavo); il rifiuto categorico (da parte dell’accusato) dell’idea di adeguare la portata della letteratura ai parametri dei premi e del riconoscimento mondano (una letterale guerra alla banalità da parte dell’accusato). Così il nostro scrittore, che in queste condizioni prende le sembianze di Danilo Kiš, si dispone, con un certo fatalismo (con disgusto e con un improvviso lampo di godimento negli occhi), ad affrontare lo scandalo per quello che è: contemplare la propria immagine, la propria opera allo specchio – costretto a difenderla.
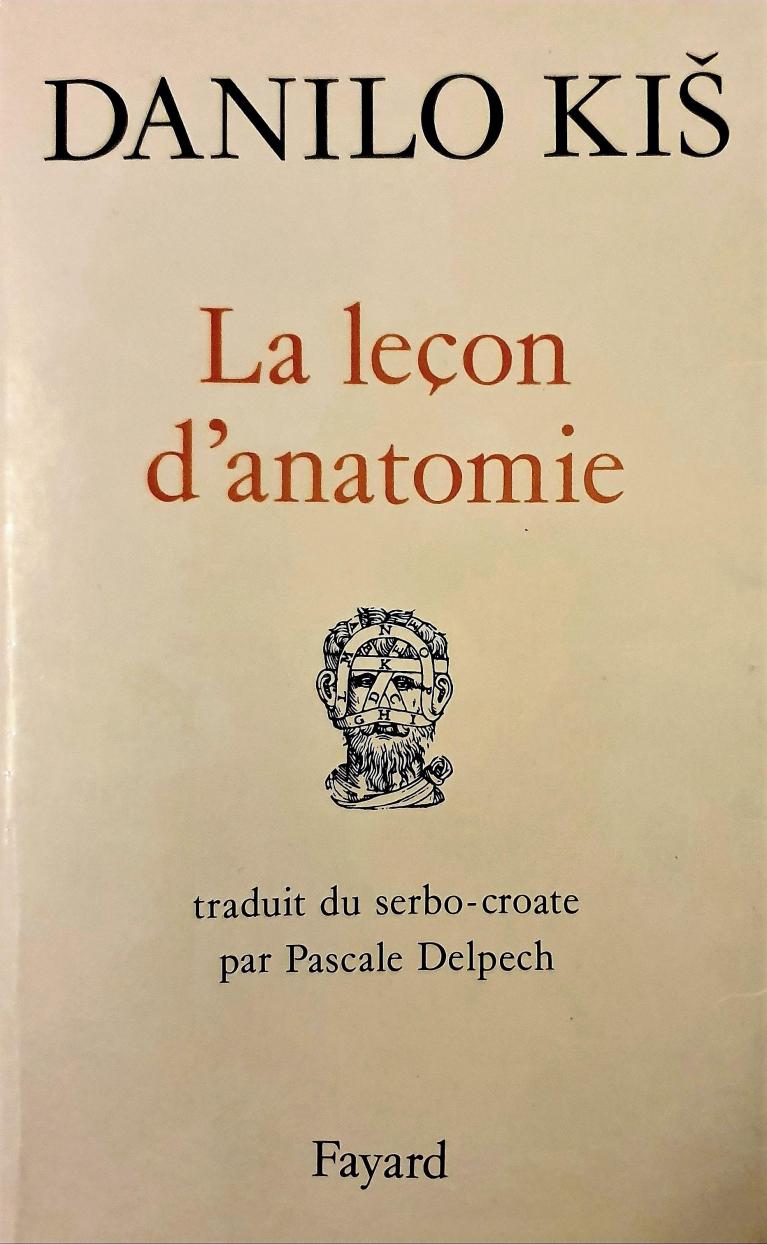
Teoria della prosa
Una tomba per Boris Davidovič esce in Jugoslavia nel 1976. Si tratta di un testo che segna una lieve ma significativa cesura all’interno dell’opera di Kiš: chiuso il cosiddetto ciclo familiare (Giardino, cenere; Dolori precoci; Clessidra) Kiš si cimenta con un soggetto diverso. Il sottotitolo del libro recita “Sette capitoli di una stessa storia”: si tratta, principalmente, di vicende di ebrei che gravitano intorno agli eventi della rivoluzione russa: ognuno di essi sperimenta, sul proprio corpo, l’impennata della Storia e la successiva caduta (la soppressione della verità, l’umiliazione, la tortura: i Gulag).
Affrontare un soggetto diverso, per uno scrittore come Kiš – per cui la riflessione teorica accompagna sempre, sistematicamente, la pratica della finzione – significa soprattutto disporre e utilizzare procedimenti letterari diversi. Nel caso di Una tomba per Boris Davidovič la novità – e la cesura rispetto alle opere precedenti – consiste nel confronto diretto con gli strumenti metanarrativi e metaletterari che Jorge Luis Borges codifica nella forma delle biografie fittizie. Ricordiamo che Storia universale dell’infamia di Borges appare in Jugoslavia all’inizio degli anni settanta e che Kiš legge per la prima volta l’autore argentino in quella circostanza (“La coscienza di un’Europa sconosciuta”, in Homo poeticus, Adelphi, 2009, p. 260). Questi strumenti (che Borges codifica, ripetiamo, non inventa) illuminano in modo inedito un conflitto essenziale che riguarda la pratica della finzione: la relazione tra documento e invenzione. Questo conflitto, in Borges, si sintetizza in una figura precisa: la citazione.
La funzione della citazione come procedimento letterario, formalizzata da Borges in vari punti della sua opera (nel modo forse più limpido e radicale in “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, in Finzioni, Adelphi, 2003), consiste principalmente nella creazione di un legame biunivoco tra documento e invenzione (e in senso più ampio: tra realtà e finzione, tra Storia e immaginazione), un legame ambiguo, di reciproca dipendenza, un motore di dubbio – questo è il suo effetto primario e più lampante. Ce n’è un altro, tuttavia, più sottile ed elementare, ed è forse quest’ultimo a richiamare maggiormente l’attenzione di Kiš quando si appresta a scrivere Una tomba per Boris Davidovič (diverso è il discorso per la sua ultima opera, Enciclopedia dei morti). Scrive Kiš in Čas Anatomije che l’utilizzo della citazione, vera o falsa che sia, in un soggetto letterario a tema storico, aumenta l’effetto di verità del testo. Ma un soggetto che si propone di indagare gli orrori dei campi di sterminio o dei Gulag ha davvero bisogno di tale supporto, di una spinta ulteriore? Non parlano forse da soli i documenti, le testimonianze, le reliquie? Bisogna chiedersi in cosa consista questo effetto di verità: non si tratta di un’iperbole o di un surplus di pathos. Al contrario: si tratta di rendere il testo, per il tramite del ricorso a un documento, indipendente dalla Storia. Il legame ambiguo con cui la citazione aggancia realtà e invenzione è una membrana che isola il testo, che lo rende autonomo, giudicabile solo sub specie aeternitatis, indipendentemente dai documenti certificati dagli storiografi fuori dal testo. La citazione, vera o falsa che sia, in particolare in un soggetto a tema storico, è un vettore di autorevolezza, autonomia e indipendenza del testo; è un procedimento che parla direttamente al lettore, dice: seguimi, qui dentro vigono unicamente le leggi della letteratura.
C’è un rischio, ovviamente, nell’abbandonarsi (scrittore e lettori) senza riserve alle leggi della letteratura. Čas anatomije, in questo senso, non è che un resoconto di tale rischio.
Questa è la storia delle mie emozioni
Una tomba per Boris Davidovič è accolto inizialmente con favore. Presto, tuttavia, pochi mesi dopo l’uscita del libro, cominciano a circolare voci tra Zagabria e Belgrado: Kiš ha copiato; ha ripreso intere pagine di Roy Medvedev, di Borges o di Karlo Štajner senza citarle; o ancora: se anche le avesse citate, il valore letterario dell’operazione sarebbe comunque compromesso, sminuito; e poi: se anche non le avesse copiate, cosa mai può aggiungere una finzione letteraria agli ormai ben certificati orrori dello stalinismo? Non ci basta Solženicyn? Questi orrori li conoscevamo già, perché ripeterli? Forse perché i personaggi sono ebrei? Ebrei come l’autore del libro? E cosa c’entrano questi ebrei rivoluzionari con noi – noi jugoslavi della seconda metà degli anni settanta del novecento, noi pieni di colore locale, noi senza destino, noi non più mitteleuropei e mai – mai! – sovietici, noi eternamente balcanizzati?
Bisogna immaginare l’insieme di queste accuse (più improprie che false) piombare sulla schiena dello scrittore mentre, intrappolato nella contemplazione della propria immagine, si osserva allo specchio. Lo scrittore in questione, Kiš, prende a rispondere, sui giornali, con note affilate, brevi e umoristiche – più entra nel gioco, più il fuoco si accresce: Una tomba per Boris Davidovič, per lo scandalo e le accuse di plagio, è ritirato dalla lista dei finalisti di uno dei premi più importanti della società letteraria jugoslava dell’epoca. Le accuse diventano diffamazione e scherno: scrittori, giornalisti, traduttori influenti infiammano il Club degli Scrittori di Belgrado con prospettive di deliziose torture: lo annienteremo, lo finiremo (ma evitate gli insulti antisemiti, s’il vous plaît, non vogliamo mica che ci sentano da Parigi, sapete che il nostro ha insegnato a Strasburgo, è stato tradotto in francese…).
Solo a quel punto lo scrittore in questione, Danilo Kiš, figlio dell’ebreo errante Eduard Kiš nato Kohn, scampato per caso alla deportazione nel 1944, si mette in piedi (lo specchio è ad altezza uomo), si spoglia del tutto e pronuncia il sermone di Zarathustra al contrario: che la commedia abbia inizio.

I fottutissimi fatti
C’è confusione: gli accusatori attaccano in modo disordinato e non è chiaro se questo caos debiliti o fortifichi l’accusa (Kiš, maestro di inversioni del point of view, è il primo a percepire il dolore e la vergogna degli accusatori). In ogni caso l’autore di Una tomba per Boris Davidovič è imputato: di aver copiato Borges (“il tuo libro non è che una traduzione libera di Borges”, p. 23 dell'edizione francese, La leçon d'anatomie, ed. Fayard); di aver usato fonti precise e autorevoli (Medvedev, Štajner, tra gli altri) senza citarle; di essere, in definitiva, un ciarlatano, oltre che, sottilmente, un ebreo: caro Danilo, non sei uno dei nostri. Tuttavia il momento della verità, la prova inconfutabile della malafede, dell’oltraggio alla letteratura, non arriva mai. Circa un anno dopo il primo attacco subito da Kiš (l’articolo “Una collana di perle rubate”, pubblicato sulla rivista Oko, esce a novembre 1976), il generale dei mandarini della letteratura jugoslava dell’epoca, Dragan Jeremić, scrive che sarebbe preferibile, Danilo, che tu, semplicemente, “ammetta di non aver citato le tue fonti, per diverse ragioni” (p. 91).
Ringraziamo Jeremić per averci fornito la chiave di volta dell’affare: le “diverse ragioni” per cui Kiš cita o non cita le sue fonti sono, di fatto, la poetica stessa di Una tomba per Boris Davidovič.
Così, in Čas Anatomije, dopo un prologo al modo proemiale dei classici antichi (“Introduzione”), un capitolo sui costumi e sul colore locale della vicenda (“Intorno a una vicenda (letteraria) scandalosa, soggettivamente”), una sezione teorica (“Parabasi”), Kiš arriva infine al nodo: nella quarta parte del libro (“Contro l’oscurantismo o lo scalpello della coscienza critica”), ormai Pierre Menard di se stesso, il nostro riscrive, alla lettera, interi passi del suo libro per spiegare – ai mandarini jugoslavi, al mondo intero, ai posteri e persino a se stesso – quale sia la funzione della citazione in un soggetto letterario a tema storico:
“Questo racconto, un racconto che nasce nel dubbio e nell’incertezza, ha un’unica sfortuna (alcuni la chiamano fortuna), di essere vero: annotato dalla mano di gente rispettabile e di testimoni degni di fede” (p. 92).
Queste sono le prime frasi di “Un coltello dal manico in legno rosa”, racconto che apre Una tomba per Boris Davidovič. Tutte le “diverse ragioni” vi sono incluse: il narratore afferma che il racconto è vero, in quanto è stato annotato dalla mano di gente rispettabile e di testimoni degni di fede. E che inoltre la sua autenticità (del racconto e dunque dell’intero libro) è attestata per il tramite di testimonianze scritte. Che cosa significa tutto questo?
“Significa che lo scrittore intende far sapere al lettore che la fabula del testo in questione non è pura affabulazione, non è interamente inventata, ma che si fonda su dei fottuti fatti, su delle fottutissime testimonianze, su dei documenti, perché è stata annotata «dalla mano di gente rispettabile e di testimoni degni»!
Allo stesso tempo è chiaramente detto, in questa prima frase del libro, che il testo nasce «nel dubbio e nell’incertezza», nel dubbio della creazione e nell’incertezza della composizione (come far rivivere questo mondo, come evitare di tradire questa autenticità della realtà), e che l’autore intende scrivere questi racconti basandosi su fatti autentici, su una fabula veridica.
E cos’è la fabula?
«La fabula non è che uno dei materiali che servono alla formazione del soggetto» (Šklovskij).
Quindi: designo il materiale in modo del tutto adeguato. Forse anche troppo adeguato per un lettore perspicace” (p. 92).
Potrebbe bastare questo esempio – non già al lettore perspicace, per cui la sola prima frase del racconto è già abbastanza eloquente, ma al lettore meno intrepido – tuttavia siamo nudi nel fuoco incrociato del ridicolo. Accade che, nell’intensità del momento, il soggetto – lo scrittore in questione, come chiunque altro – si abbandoni a una certa inerzia del conflitto: l’idea della misura scompare in favore dello svuotamento o dello sfogo. Seguono dunque intere pagine di esempi analoghi. Qui sotto una (fottutissima) testimonianza fotografica dello scrittore ossessivamente allo specchio:
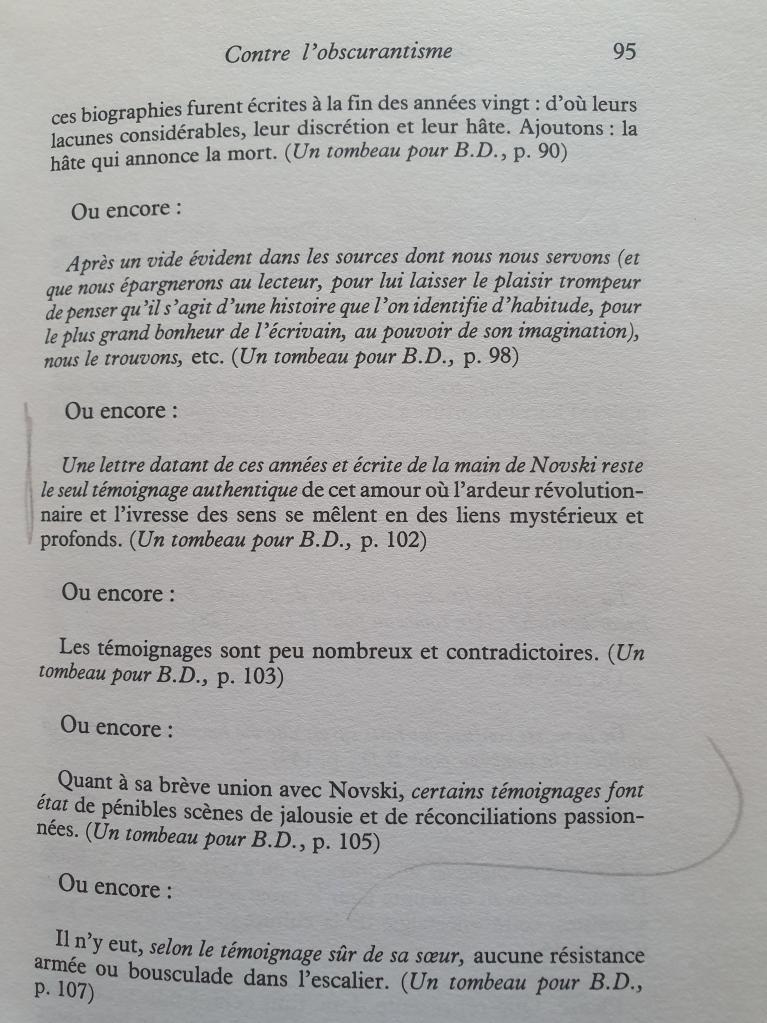 __title__
__title__
Persiste tuttavia un dubbio. Kiš insiste sul fatto che la fabula di Una tomba per Boris Davidovič si fondi su documenti e testimonianze – ma non li nomina. O meglio: non nomina le fonti più accreditate e autorevoli (Medvedev e Louis Réau), ma quelle più sconosciute e secondarie (un esempio su tutti: A.L. Rubina, sorella anagrafica dell’individuo storico la cui vicenda ispira la costruzione di uno dei personaggi del libro, Boris Davidovič, citata a più riprese nel racconto che dà il titolo all’opera). Risponde Kiš:
“In Una tomba per Boris Davidovič sono dunque citate numerose fonti, vere o false, «argomentative» o «ornamentali», non solo giornali e riviste, reportage, testimonianze (di prima o seconda mano), ma anche nomi, veri o falsi. […] E cosa c’è di più logico, in questo mondo fittizio, in cui il vero e il falso sono mescolati, in questo mondo di mistificazione letteraria – il cui fine supremo, paradossalmente, è pervenire a una verità storica oggettiva –, cosa c’è di più logico, dicevo, che citare le «fonti» più profondamente lontane, dimenticate dalla Storia […]: non Medvedev, perché Medvedev è «editore», ma A.L. Rubina, «la sorella di Boris Davidovič», non Louis Réau [storico dell’arte francese], ma Dietmar di Merseburg, il signore di Beauplan e Costantino Porfirogenito, a cui si rifà lo stesso Réau. […] E come servirsi di fonti che noi stessi deformiamo, non solo morfologicamente, dunque stilisticamente, ma anche in quanto dati, dati della storia e della storia dell’arte? Come, dunque, citare qualcosa che non è una citazione? […] Questo modo ostinato, ossessivo, di insistere sui documenti, le testimonianze, i dati, le citazioni dovrebbe indicare in maniera sufficientemente chiara al lettore perspicace, e soprattutto al critico perspicace, che l’autore intende per prima cosa sottolineare in questo modo il senso della sua tecnica letteraria, il cui fine ultimo è di convincere il lettore della veridicità di questi racconti, dell’autenticità (degli eventi descritti), non soltanto al livello della fabula, ma anche al livello del processo di formazione di questa fabula. Come se, nel racconto, nulla fosse stato lasciato al caso, […] come se, al contrario, tutto venisse da grandiosi e divini archivi, in cui tutti i pensieri, tutti gli atti di tutti i personaggi sarebbero conservati” (pp. 113-114).
Siamo, di colpo, in un archivio divino (uno specchio?): tutto, qui dentro, sembra essere permesso. In verità è il contrario:
“Non dimentichiamo […] che nel caso concreto di Una tomba per Boris Davidovič, stiamo parlando di un «romanzo storico», di materiali storici, di una fabula della cui autenticità l’autore intende convincere il lettore, e, dunque, che ogni elemento arbitrario, ogni invenzione dell’immaginazione dev’essere giustificata dalla veracità del dettaglio. I riferimenti, veri o falsi, appaiono qui nella loro pura funzione letteraria, in modo del tutto paradossale, come abbiamo detto: i fatti letterari […] sono fondati sul materiale storico, e viceversa” (p. 115).
La citazione, come procedimento compositivo, aggancia vero e falso, documento e invenzione, materiale storico e fatti letterari – li aggancia e li avviluppa in una membrana di ambiguità, facendo di essi un corpo isolato, a parte. Questo a parte è il testo letterario – l’effetto del procedimento sta precisamente nella realizzazione di tale isolamento: il testo ha le sue leggi, è un campo autonomo e minuziosamente delimitato – che lo vedano o meno i mandarini del colore locale, i critici perspicaci, i lettori meno intrepidi e via discendendo. (Non si danno dunque scorciatoie e questo, il nostro scrittore, lo sa fin troppo bene – l’ha accettato, vedete? È da ore in ginocchio davanti allo specchio e non si lamenta.)
Lo specchio dell’ignoto
Čas anatomije, testo polemico e teorico insieme, esce in Jugoslavia nel 1978. È un successo di pubblico e di critica. Poco dopo la pubblicazione uno dei mandarini del folklore jugoslavo, deriso a più riprese nel libro, intenta un processo per diffamazione contro l’autore.
(Esausto, intanto, ora disteso, forse in pigiama, lo scrittore continua a fissare lo specchio.)
Il processo dura più di un anno; l’autore ne esce indenne ma opta per l’esilio joyciano: via dal colore locale di Belgrado, direzione Parigi – verso un altro folklore, di certo meno locale, non per questo più accettabile.
(Il dramma, per ora, è finito. Mentre indugia con lo sguardo allo specchio, in pigiama, poco prima del meritato riposo – fonti degne di fede attestano quanto segue – il nostro scrittore, Kiš in persona, ha un sussulto, uno schizzo di sollievo: per un istante – per un istante soltanto – non vede niente: la sua immagine scompare dal vetro.)
Nota di lettura
Čas Anatomije è stato tradotto in francese da Pascale Delpech (La leçon d’anatomie, Fayard, 1993). La traduzione, dal francese all’italiano, di tutti i passi citati del libro è di chi scrive. Un estratto del primo capitolo e l’intero secondo capitolo di Čas anatomije sono inseriti nella silloge di saggi e interviste Homo poeticus (Adelphi, 2009, traduzione di Dunja Badnjevič).
Uno degli elementi più peculiari di Čas Anatomije è la crestomazia che Kiš vi intercala: una serie di inserti, che intervallano le sezioni e i capitoli del libro, in cui l’autore chiama a raccolta i suoi – si serve di testi altrui (Roger Caillois, Michel Foucault, Thomas Mann, tra gli altri) per spiegare e legittimare la propria poetica. Quest’ultima circostanza indica che forse non era solo – che forse nessuno è mai davvero solo mentre dà battaglia alla propria immagine allo specchio.
La traduzione del passo citato da Una tomba per Boris Davidovič è di Ljiljana Avirović (Adelphi, 2005).
L’insistenza di Kiš sui materiali (matériaux) non è dettata da un’improvvisa febbre edilizia: il termine è usato da Šklovskij in Teoria della prosa (Garzanti, 1974, traduzione di Maria Olsoufieva) in opposizione ai cosiddetti “procedimenti di costruzione”.
I mandarini della letteratura, infine, col loro afflato universalistico (il loro “senso poliziesco della vita”), sono stati colti in flagranza di reato da Roberto Bolaño in “Incontro con Enrique Lihn” (Puttane assassine, Adelphi, 2015, traduzione di Ilide Carmignani).









