10-11 febbraio 2022: Il Semplice e i suoi autori a Modena / Maurizio Salabelle, l’orologiaio del comico
La parabola letteraria di Maurizio Salabelle per tristissimi motivi è legata a quegli anni Novanta che nelle storie letterarie paiono molto spesso fin troppo maneggevoli e di agile ricostruzione, ridotti a pochi fenomeni notevoli. Ricordare che Salabelle è nato nel 1959 a Cagliari e morto a Pisa nel 2003, poco più che quarantenne, significa innanzitutto fissare qualche coordinata importante: egli fa parte di una covata di narratori storicamente individuata, nata durante gli anni del boom economico e che in molti casi si è affermata con stabilità nel nostro panorama letterario solamente nel nuovo millennio. Per intenderci, il lustro ’55-’60 è quello che ha dato i natali, fra gli altri, a nomi come Albinati, Affinati, Anedda, Doninelli, Franchini, Mari, Mozzi, Onofri, Palandri, Trevisan e Voltolini, ai quali va aggiunta la vicenda eccezionale di Pier Vittorio Tondelli, nato, come noto, nel ’55 a Correggio.
A livello editoriale, dunque, Salabelle ha espresso il grosso del suo talento narrativo nell’arco del decennio che va dal 1992 al 2002, lasciandoci in poco tempo sei romanzi (cinque più un romanzo postumo), esordendo con una scrittura già riconoscibile e matura grazie a un’intensa gavetta scrittoria, i cui referti restano ancora parzialmente inediti. Arrischio subito un’affermazione un po’ apodittica: ciò che ha dato in termini creativi Salabelle tra i venticinque e i quarant’anni è in proporzione di più, non solo a livello quantitativo, di quello che autrici e autori di pari rango producono di solito a quell’età. Dico questo solo per sottolineare la precocità e la tenacia della sua vocazione narrativa.
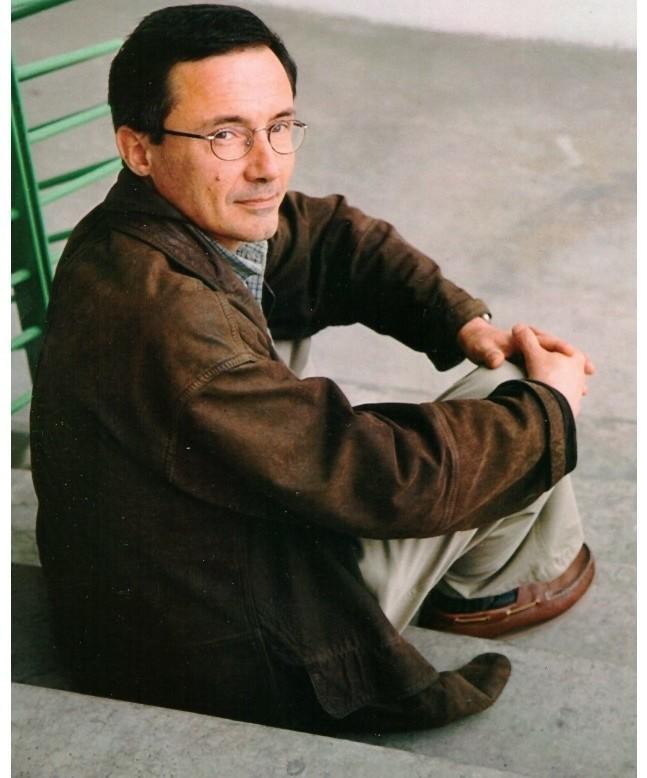
Maurizio Salabelle.
Già a metà degli anni ’80, infatti, le sue prime prove narrative sono opzionate per la storica collana «Under 25» a cura dello stesso Tondelli, anche se l’occasione alla fine non si concretizza. Un’entusiasta telefonata di Giuseppe Pontiggia apre uno spiraglio per la pubblicazione di La famiglia che perse tempo per Adelphi, ma in questo caso alcune renitenze dell’editore fanno sì che per vedere in libreria Un assistente inaffidabile, primo romanzo effettivamente pubblicato da Salabelle, bisognerà attendere l’intuizione di Ermanno Cavazzoni, che ne incoraggia la pubblicazione presso la Bollati Boringhieri di Giulio Bollati nel ’92. Il libro vince in quell’anno il premio «Giuseppe Berto» per la miglior opera prima. Con il senno di poi, si può constatare come proprio il premio «Giuseppe Berto» abbia contribuito a battezzare alcuni degli esordienti più interessanti di quella stagione letteraria: oltre ai già citati Doninelli, Mari e Onofri, anche Paola Capriolo, Helena Janeczek e Paolo Maurensig.
Ed è così che, letteralmente da un anno con l’altro, Salabelle si trova aggregato all’antologia feltrinelliana Narratori delle riserve (1992) assemblata da Gianni Celati e coinvolto negli incontri del «Semplice», che da quell’anno si sarebbero svolti presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, e, sebbene più tangenzialmente, in quelli di «Ricercare» a Reggio Emilia, che nello stesso periodo e nella stessa regione in cui si apre e sviluppa il cantiere del «Semplice» tentano di mettere in comunicazione l’eredità del Gruppo ’63 con i diversi “novismi” emergenti nella letteratura degli anni Novanta. A testimonianza di un’attenzione e di una stima diffusa, Salabelle viene selezionato in qualità di alfiere di un nuovo “realismo magico” per l’antologia Narrative Invaders. Narratori di «Ricercare» 1993-1999, pubblicata nel 2000 per Costa&Nolan come simbolico coronamento editoriale di quell’esperienza di riflessione e tentato rinnovamento. In queste avventure antologiche Salabelle spende alcuni brani ritagliati da La famiglia che perse tempo, il romanzo d’esordio sommerso, che vede la luce solamente nel 2015 nella collana «Compagnia Extra» di Quodlibet, diretta in quella fase da Cavazzoni e Jean Talon.
Salabelle si lega all’esperienza del «Semplice» con tre testi, che possono essere utilizzati come lente per osservare il complesso della sua produzione. Il primo testo del trittico, L’istruzione scolastica, è una modest proposal di marca swiftiana che avrebbe ben figurato fra le pagine del «Caffè» di Giambattista Vicari, pubblicata in dittico sul secondo numero del «Semplice» (gennaio 1996) insieme a un brano di Augusto Frassineti, altro devoto discepolo del pastore irlandese. Si tratta di un testo abrasivo e divertente sulla scuola, un mondo che Salabelle in qualità di insegnante conosceva molto bene e che avrebbe raccontato più avanti in uno dei suoi dei suoi libri più belli, Il maestro Atomi (Comix 1997; Casagrande 2004).
Il secondo testo di Salabelle, La scatola di Minsky, esce sul terzo numero della rivista (maggio 1996): si tratta di uno dei rarissimi interventi di poetica di questo narratore poco in vena di manifesti e perciò vale la pena soffermarcisi un momento. Con argomentazioni che echeggiano in minore il Manganelli di La letteratura come menzogna, questo orologiaio del comico paragona il romanzo a una macchina “inutile”, i cui scorrevoli ingranaggi incastrano fra loro in un movimento che non allude ad altro da sé. Se per Manganelli l’artefatto letterario è assimilabile a un ordigno esplosivo, Salabelle con una similitudine più modesta e poco roboante lo paragona a un apparecchio che potrebbe essere frutto della fantasia di Bruno Munari ma che invece è stato inventato dallo scienziato Marvin Minsky, dal quale appunto prende il nome. Commenta Salabelle: «I libri che vale la pena di leggere non sono quelli “ancora attuali” o che “parlano di noi”: sono quelli che hanno il meccanismo più ricco, complesso, misterioso e il cui funzionamento appare più semplice» (corsivo mio).
Vorrei provare ora a togliere il coperchio al macchinario stilistico salabelliano per provare a osservarne gli ingranaggi e capirne almeno un po’ il funzionamento. Per fare ciò credo che un buon punto di partenza sia comprendere la meccanica dell’avantesto mentale di Salabelle o meglio della sua grammatica della visione. Prendo a prestito questa espressione da un saggio di Andrea Cortellessa pubblicato su «allegoria» nel ’98 a proposito del gaddismo di secondo grado nella letteratura italiana di fine millennio, e in particolare dalle pagine dove il critico romano cerca di individuare i possibili scolari della lezione di Luigi Malerba. Quali sono gli elementi che caratterizzano la grammatica della visione di Salabelle e su quali aspetti del reale questa visione si concentra? Una definizione efficace della tecnica rappresentativa salabelliana è fornita proprio dalla motivazione tecnica della giuria che assegnò il Premio Berto a Un assistente inaffidabile:
Secondo la tecnica iporealista illustrata da Salabelle, «anche le scene più banali» debbono contenere «dosi di inverosimile»: si tratta cioè di una sorta di «subrealismo» minimale dove tutto è scontato e prevedibile, sino al punto che paradossalmente le vicende, ridotte a piccoli, monotoni gesti quotidiani, si rivelano talmente improbabili da confondersi con le allucinazioni.
Mi pare che siamo dalle parti dell’“infra-ordinario” di Perec. Nei libri di Salabelle i narratori-personaggi, spesso giovani o giovanissimi, sembrano stuporosi zeri assoluti walseriani, la cui grammatica della visione è perennemente regolata su una messa a fuoco obbligata dei dettagli, dei particolari in apparenza più sciatti e insignificanti, che si accomodano allo sguardo di chi racconta (e di chi legge) in maniera da impedire un corretto distanziamento e una visione per così dire sintetica del rappresentato: da qui la qualità lievemente narcotizzante della sua prosa. Aggiungo anche che da Perec è mutuato in Salabelle un gusto per il dettaglio al contempo arbitrario e rigoroso, segnale di una dialettica che anima molte delle sue migliori pagine.
Il terzo testo che Salabelle pubblica sul sesto numero del «Semplice» (maggio 1997) è un breve racconto intitolato Lo zio. Si tratta di una tipica scenetta familiare salabelliana, in cui l’inserzione chirurgica di particolari inconsueti disarticola il concetto di quotidianità, mantenendone solo alcune caratteristiche superficiali: vita ordinaria, insomma, ma “di sghimbescio”, per usare una delle espressioni preferite dall’autore. In questa operazione, a livello stilistico hanno grande importanza la scelta degli aggettivi, che crea nel lettore delle dissonanze percettivo-cognitive significative ma mai eccessivamente sopra tono – il rischio sarebbe di inceppare la macchina –, e in generale di tutte le espressioni atte a fornire precisazioni di qualche tipo: in questo senso, molto particolare è l’uso in Salabelle dei diacritici che segnalano espressioni “cosiddette”, denominazioni improprie, nomenclature fantasiose.
Lo zio è un testo ancipite, ottenuto dalla giustapposizione di due frammenti distinti: nel primo è descritto e spiegato il rituale dell’assunzione delle pastiglie dello zio Bindano Ugo, il quale, se eseguito scorrettamente, produrrebbe come esito la morte dello stesso. Nel secondo brano, la scoperta di un debito dovuto alla maturazione esponenziale di un interesse sta per condurre la famiglia Rhuggi sul lastrico, ma la catastrofe finanziaria è evitata proprio dallo zio Ugo, che cancellando alcuni zeri dalla cifra dovuta ne determina la significativa diminuzione: come spesso in Salabelle, un gesto arbitrario ha ricadute molto tangibili. Lo zio esemplifica bene la rigorosità ludica dell’immaginazione di Salabelle. Il rituale dell’assunzione delle pastiglie dello zio Ugo rende bene quell’idea di rigorosa arbitrarietà cui accennavo prima:
Poco prima di ogni pasto estraeva da una tasca della giacca una voluminosa scatola di pastiglie, ne toglieva undici con lentezza e le allineava sul “tavolo rilegato”. Una decina di minuti più tardi (dopo essersi fatto riempire dalla signora Rhuggi un bicchiere strapieno d’acqua ghiacciata) le ingurgitava ad una ad una stando attento a seguire un preciso ordine. Prendeva per prima una compressa rosa, poi una verde con delle tacche, dopodiché un’enorme pastiglia bianca e nera alla quale faceva seguire altre tre più piccole. Per concludere scioglieva una compressa effervescente nel mezzo bicchier d’acqua che gli era avanzato, e con questo liquido inghiottiva quattro pasticche triangolari che dovevano fargli digerire quelle già prese. Solamente dopo questo rito che si ripeteva a ogni inizio di pranzo diventava meno teso, faceva un sospiro malinconico e si cominciava a tagliare la carne fritta.

Ora che ci faccio caso l’idea di ricetta, di metodo, di riturale rigoroso è una delle cellule narrative più attive a livello di trama nei libri di Salabelle, popolati di personaggi impegnati nell’esecuzione di gesti macchinali e burattineschi, come a seguire dei pattern operativi impliciti o, come nel caso di questo racconto, addirittura esplicitati. Anche a livello orale, spesso i suoi protagonisti provano a formalizzare l’informe attraverso conferenze improvvisate e l’elaborazione di teorie assurde, la cui totale inutilità ci mette di fronte alle autonarrazioni consolatorie che tutti fabbrichiamo per attraversare, parafrasando un altro autore similmente visionario, quella “schiuma dei giorni” che tutti invischia e che si mostra per natura riottosa ai facili schematismi.
Questi esorcismi “schematici”, appunto, sono spesso tentati nei confronti di misteriose malattie che affliggono soprattutto i maschi adulti, ma che si ripercuotono su tutti i membri delle famiglie dei suoi libri, come a suggerire che i legami interpersonali e soprattutto familiari presentano sempre aspetti patologici difficili da mettere a fuoco. È la storia più vecchia del mondo, si dirà, ma come ha notato con acume lo scrittore Matteo Terzaghi su queste pagine, ciò che sorprende in Salabelle è la capacità di “liofilizzare” i temi capitali fino a farli scomparire alla vista: «C’è molto Novecento nei libri di Salabelle, da Walser a Buster Keaton, da Bove a Beckett a Tadeusz Kantor, ma è un Novecento ridotto a essenza e assimilato fin quasi all’oblio». Per il lettore il possibile carattere medicinale della scrittura di Salabelle, la quale – a scapito di quanto egli stesso afferma – in questo “parla di noi”, sta nel riconoscere e nel rispecchiarsi in questa sintomatologia familiare, restituita in termini atmosferici, fisiologici e psichici, più che psicologici.
L’estemporaneità di questo breve racconto e delle sue trovate evidenzia il respiro breve della fantasia di questo autore, i cui romanzi possono essere visti come infilzate di episodi legati fra loro dal ricorrere di modi, personaggi e tematiche. In questo senso, se dovessi cercare dei parenti letterari prossimi a Salabelle fra gli autori del «Semplice» – oltre al Manganelli più domestico di Sconclusione, ripreso con efficacia in certo Cornia – credo che li troverei nel Cavazzoni di La valle dei ladri e nel Celati del ciclo dei Costumi degli italiani, anche per un certo modo di traslare le proprie visioni in uno spazio urbano restituito a un anonimato senza tempo. Come dichiarato dall’autore, fuori da quest’aria di famiglia, altre parentele letterarie andrebbero cercate in Italia fra le visioni di un Mastronardi o di un Tozzi.
Proprio Cavazzoni in un lucido omaggio ha inquadrato la comune atmosfera che si respira nei libri di Salabelle in un modo che non mi sento di parafrasare: «Mi sono sempre sentito allegro a leggerli e un po’ agghiacciato; si muovono in un panorama che riconosco ogni volta, e che definirei uno stato di rovina senza termine, uno stato di normale rovina del mondo, dove tutto è sbeccato, logoro, ritinto, rimediato». L’uscita di La famiglia che perse tempo per Quodlibet nel 2015 ha generato una mole non trascurabile di nuove recensioni e referti critici. Voglio rimandare almeno ai contributi di Marco Belpoliti, Elena Frontaloni, Daniele Giglioli, Lorenzo Innocenti e Luigi Matt. In particolare, Matt, soffermandosi sulla lingua di questo romanzo nel recente volume Narratori italiani del Duemila. Scritti di stilistica militante (Meltemi 2021), scrive: «Buona parte della riuscita del testo è dovuta all’adozione di una lingua neutra, totalmente inespressiva, come si addice a quello che appare come un diario clinico più che un racconto» (p. 262).
Con la consueta sveltezza di lettore, già Celati aveva colto in Salabelle nei Narratori delle riserve una “stramberia mitigata con la sordina”. Il fatto che a mio avviso vale la pena ribadire è che l’impasto linguistico salabelliano non prevede mai scelte lessicali verticali e raramente slogature sintattiche significative. Come accennato, ciò che rende questo autore ancora molto leggibile è il suo modo di lavorare e sabotare la lingua media, grigia solo in superficie, scommettendo su un periodare sempre musicale, ascoltabile, mai ostile con il lettore. Nelle parole di Giglioli: «Il suo linguaggio è così disponibile, servizievole, sempre pronto a circostanziare: ma lo scrigno resta chiuso come in un film di Lynch». Come a dire: gli ingranaggi scorrono, la macchina inutile si muove, ma il segreto ultimo del testo è inafferrabile e Salabelle stesso ci scoraggia dal cercarlo, poiché risiede nella stessa cinematica narrativa.
Questo modo di lavorare sottolinea una significativa controtendenza rispetto a molte scritture che hanno segnato gli anni Novanta, proiettate più o meno problematicamente verso un “fuori” rispetto al testo, restituito alla pagina con toni enfatici, sopra le righe, in senso lato espressionisti. Dico questo anche se ritengo Salabelle, a suo modo, un narratore dei suoi anni: i suoi personaggi alienati si muovono in anonime periferie urbane, immerse in un clima di post-benessere degradato, consumistico in senso ampio. Segnalo in questa direzione il ruolo che ricoprono i prodotti confezionati e le marche industriali nel suo repertorio, sebbene appaiano sempre trasfigurati da un’onomastica straniante e un po’ comica, attentamente calibrata.
Vorrei evitare un finale dal tono tribunalizio, che comunque mal si intonerebbe alla postura artistica di Salabelle: dirò solo che le “virtù della sordina”, se così possiamo chiamarle con Celati, non mi sembrano oggi tra le più diffuse nell’attuale panorama narrativo – anche in quello comico –, in generale più sedotto, mi pare, dalle sirene di un’estroflessione più facilmente riconoscibile. Salabelle è per definizione uno scrittore senza scopi, la sua pagina non sgomita, non chiede nulla. Nell’era della letteratura “webbabile” (riprendo il neologismo da Walter Siti – anzi, da un suo amico) gli ingranaggi, i pistoni e le rotelle che compongono i suoi clockworks narrativi possono sembrare resti archeologici, relitti di un passato che pare oggi più remoto di quel che è in realtà. Tuttavia, non credo si sbagliarmi quando affermo che il coraggio dell’editore che volesse scommettere di nuovo su Salabelle, riproponendo almeno gli oggi introvabili Un assistente inaffidabile e Il mio unico amico (Bollati Boringhieri 1994), i suoi primi due romanzi pubblicati, sarebbe ampiamente ripagato dalla soddisfazione dei lettori.
Per questi e altri motivi il “maestro” Salabelle avrebbe ancora parecchio da insegnare: proprio lui che, come si racconta, faceva il giro largo quando vedeva un suo libro esposto nella vetrina di una libreria, avvertendo fra sé l’impostura di ogni faccia pubblica. Solidale con l’autore anche io “getto la faccia” in extremis, chiudendo queste annotazioni con le prime righe del Diario notturno di Ennio Flaiano, che chiosano molto meglio di come potrei fare io quanto scritto finora: «Le difficoltà di un’arte appaiono negli esemplari meno riusciti o addirittura cattivi di essa, i buoni danno invece la certezza di una facile riuscita, proprio perché tutto vi è risolto e la fatica non appare».
Questo testo, che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore, riprende l’intervento preparato in occasione del convegno Il Semplice. Vite e voci di una rivista (Modena, 10-11 febbraio 2022), organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Università di Bergamo in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo. Il programma delle due giornate è scaricabile qui; per assistere alle sessioni, in presenza o via web, inviare una mail all'indirizzo giornateilsemplice@gmail.com.









