L’ordinamento giuridico di Santi Romano / Il diritto oltre lo Stato
Ogni testo rivoluzionario vive di contraddizioni patenti e fecondissime, esito inevitabile della lacerante compresenza, al suo interno, di tradizione e innovazione, conservazione e superamento. È dunque null’altro che una riprova della sua assoluta rilevanza se L’ordinamento giuridico che Santi Romano, già al tempo unanimemente riconosciuto tra i maestri del diritto pubblico italiano, assembla nel biennio 1917-1918 finisce per ribadire forzosamente la supremazia dello Stato quale somma realtà giuridica dopo averne per più di duecento pagine disvelato, in una sorta di implacabile ontologia deflattiva, lo statuto, tutt’altro che regale, di ordinamento tra ordinamenti. Non più dunque unica e indiscussa forma politico-giuridica, ancorata a un’inappellabile sovranità, ma istanza di regolazione in concorrenza con altre forme di organizzazione che ne contestano, più o meno apertamente, il primato.
A destabilizzare la forma Stato a poco più di cent’anni dalla sua epocale riaffermazione al Congresso di Vienna (1815) non sarà dunque né l’impressionante serie di lutti della prima guerra mondiale né gli ultimi patetici colpi di coda della stagione del terrorismo anarchico, quanto – questa la tesi fondamentale di Romano – la granulare concrezione di forme di associazione sempre più articolate e composite, che finiscono per sfidare e incrinare dall’interno la complessiva tenuta ordinamentale e organizzativa dello Stato. Una tesi, questa, da Romano già preannunciata in un’aurea prolusione del 1909, Lo Stato moderno e la sua crisi, in cui si parla esplicitamente, con un’espressione che non ha nulla di metaforico, di “decomposizione dello Stato moderno”. Uno Stato ridotto, sul piano della dottrina, ad astratta fictio giuridica e sfibrato, nel campo dell’agone politico, dall’attivismo di movimenti corporativo-sindacali di varia insorgenza. Romano, allora e fino al 1924 professore di diritto amministrativo all’Università di Pisa (prima di trasferirsi all’Università di Milano, per divenirvi Preside della Facoltà di Giurisprudenza), verrà in seguito nominato Presidente del Consiglio di Stato (già al tempo massimo organo amministrativo), complice un diretto interessamento dello stesso Mussolini, carica che ricoprirà ininterrottamente dal 1929 al 1944. Anni intensi e drammatici, va da sé, che vedono gli storici del diritto tutt’oggi divisi sul giudizio a riguardo dell’atteggiamento che Romano ebbe di fronte all’esigenza di fascistizzazione dell’istituzione, impellenza (e incombenza) esplicitamente richiamata, e in più occasioni, dalle massime autorità del regime proprio in quel torno di mesi (non è ovviamente questa la sede per una disamina puntuale del merito e della natura di risoluzioni e provvedimenti presi negli anni della presidenza di Romano. Sia sufficiente, rilasciando su questo il giudizio al lettore, richiamare qui il piano – certo mai di per sé interamente dirimente, dati circostanze e contesto – delle dichiarazioni programmatiche lette da Romano durante il discorso di insediamento del 22 dicembre 1928, pp. 115-119).
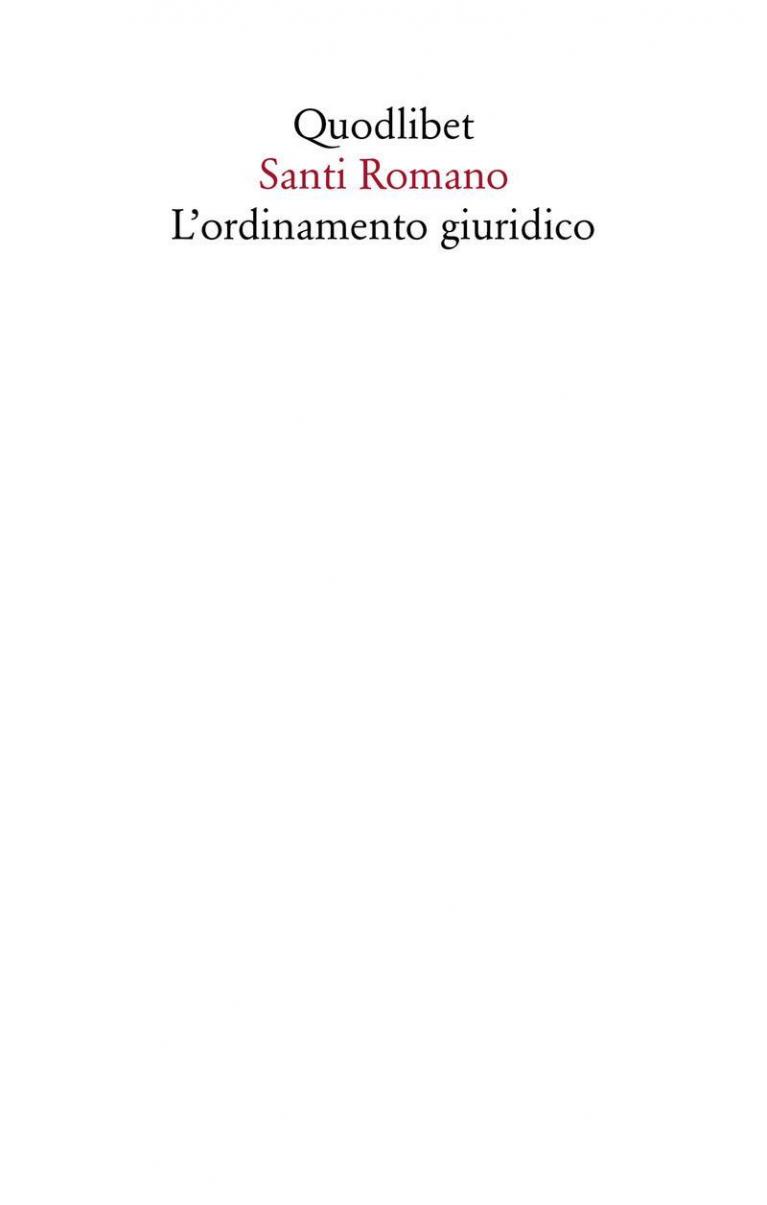
Volgendo nuovamente lo sguardo al momento teorico, se a guidare Romano nella prolusione del 1909 è un intento essenzialmente diagnostico e dunque un approccio soprattutto descrittivo (che cosa ne è della primazia dello Stato al sorgere di partiti, sindacati e movimenti di massa che ne contestano la pretesa di assoluto controllo sul sociale?), L’ordinamento giuridico si volge alla sistematicità normativa di un diritto composito e compositivo. Composito perché frutto dell’aggregazione, paziente ed elastica, di prassi giuridiche invalse all’interno dei più diversi contesti d’interazione caratterizzanti una data società. Compositivo perché orientato all’assemblaggio di tale pluralità di modelli e dinamiche di organizzazione, a tutta prima irrelate, all’interno di una unità sì coerente (ovvero capace di effettività giuridica), ma mai al prezzo di una normalizzazione impositiva che finisca per prevaricare l’eterogeneità di fondo (e d’ispirazione) dell’intero impianto. L’ordine giuridico che ne risulta appare quindi privo tanto di un centro ordinamentale sovrano quanto di una fonte autoritativa altra dalla capacità organizzativa dei singoli, la quale assurge così a condizione necessaria e sufficiente per il darsi del rapporto giuridico. Questo, in ultimo, il significato del doppio movimento richiamato nell’icastico brocardo Ubi ius ibi societas, ubi societas ibi ius: pieno e incondizionato riconoscimento della giuridicità di ogni segmento e contesto sociale che risulti in grado di auto-organizzarsi, ovvero di organarsi autonomamente in un insieme di pratiche e condotte finalizzate al conseguimento di un determinato scopo – condiviso da tutti i componenti dell’associazione e sua stessa ragion d’essere – secondo modalità e ruoli prefissati. Per riprendere l’efficacissima sintesi romaniana: “Ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata si trasforma per ciò stesso in diritto” (p. 50). L’esito ultimo di questo spontaneismo ordinamentale – un vero e proprio diritto “dal basso”, senza tuttavia alcuna alternativa “dall’alto” a fungere da fuorviante contrappasso – prende il nome di istituzione, a indicare tanto il processo di produzione delle prassi sociali poste in essere quanto la concreta struttura organizzativa (dal variabile grado di formalità) deputata alla loro riproduzione nel tempo.
Che un testo di tale rilievo sia rimasto per lungo tempo introvabile è uno di quegli ineffabili misteri che pertengono al masochismo della cultura (e dell’industria culturale) italiana. Che a cento anni dalla sua prima edizione non lo sia più è invece opera assai meritoria dell’editore Quodlibet, che, dopo la ristampa di un altro caposaldo della più influente tradizione giuridica italiana, Il diritto dei privati di Widar Cesarini Sforza (una riedizione ottimamente curata da Michele Spanò), ripubblica quello che è – lo si è cercato di argomentare anche qui – “il testo forse più influente della cultura giuridica italiana”, come afferma nella premessa il curatore della riedizione, Mariano Croce, anche autore di una illuminante e multiforme postfazione sulla rilevanza del testo di Romano per nuovi processi di istituzionalizzazione che reimpieghino in forme interstiziali – tra le tessiture, per così dire, dell’ormai largamente smagliato ordito statual-centralistico – il potenziale aggregante della logica giuridica.
Tesi rivoluzionaria, si diceva, da cogliere in tutta la sua disarmante radicalità: ogni microcontesto interazionale, in grado di darsi una struttura organizzativa riconoscibile e relativamente stabile nel tempo, è per ciò stesso da riconoscersi come avente rilevanza giuridica, indipendentemente da ogni altra condizione (ad esempio, la facoltà sanzionatoria) o criterio (uno su tutti, ogni rinvio a principi di giustizia sostantivi). Da questo punto di vista, non sussiste alcuna differenza giuridica tra uno Stato e un’organizzazione criminale, tra la Chiesa e un circolo di scambisti, in quanto tutte realtà parimenti istituzionali (nell’accezione tecnica condivisa da Romano). Non solo: sul piano pratico, non esiste alcun meta-criterio normativo, altro dal punto di vista interno di ogni singola istituzione, in base al quale sia possibile stabilire la legalità o illegalità di una data realtà giuridica (e dunque la mutua scomunica, poniamo, tra Stato e mafia non troverà alcuna dirimente istanza superiore). Insistiamo sulla radicalità: gli esempi citati non entrano semplicemente a far parte a pieno diritto di un presunto ordinamento giuridico più comprensivo, ma sono, ciascuno, un ordinamento giuridico a tutti gli effetti, e come tale potenzialmente autonomo. Di qui il corollario, di logica dirompenza, secondo cui “ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni” (p. 97). Di qui anche, e soprattutto, la stupefacente attualità del testo e delle tesi di Romano per un presente segnato dall’esigenza, ai limiti del titanico, di tenere assieme forme di vita plurali, quando non irriducibili, che non solo rimandano a prassi comunitarie polarmente divergenti, ma che faticano a trovare nella capacità di azione dello Stato una istanza di mediazione (men che meno di sintesi). A tale condizione, il più delle volte presentata con i caratteri di eccezionalità propri di ogni tempo di crisi, Romano restituisce piena dignità normativa: il pluralismo giuridico, lungi dall’essere un mero precipitato contingente di cui prendere atto, è la condizione usuale, e anzi tratto caratterizzante, del diritto. Per dirla più chiaramente: non sono la proliferazione di assai diversificate forme di associazione e il riemergere di gruppi di varia natura a contendere illegittimamente lo scettro della sovranità statuale, quanto è al contrario l’esclusivismo proprio di quest’ultima ad aver abusato di un potere che solo contingenze fattuali, ma mai alcuna probante ragione normativa, hanno temporaneamente reso di suo esclusivo esercizio.
E dunque colpevolmente miope si rivelerebbe ogni lettura riduzionistica dell’istituzionalismo di Romano che abbandonasse L’ordinamento giuridico al naufragio tra la Scilla del pangiuridicismo (se ogni forma di organizzazione ha di per sé rilevanza giuridica, allora tutto, o quantomeno tutto il sociale, è diritto) e la Cariddi di un recupero, immotivato e goffo, di una sorta di primazia statuale di risulta, giustificata – almeno nelle intenzioni – dal maggior raggio di azione e di efficacia delle potenzialità ordinamentali della super-istituzione Stato (esito contraddittorio, come detto all’inizio, che risulta da un’affannosa e incerta ritrattazione, di fatto una sorta di malsicuro controcanto, operata soprattutto nelle note alla seconda edizione del testo, pubblicata nel 1946). Colpevolmente miope perché, al prezzo di una sterile coerenza, si priverebbe di una ottica assai promettente per un inquadramento altro delle varie forme e logiche di aggregazione all’opera oggigiorno (e tutt’altro che accessoria si rivela, in quest’ottica, la seconda parte del libro, del resto la più corposa, significativamente denominata “La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni”).
Molte sarebbero le direttrici da seguire per sviluppare, rimodulandolo, il discorso di Romano (tracce cripto-deleuziane si ritrovano, ad esempio, nella postfazione di Croce). Qui preme, tuttavia, approfondire un aspetto più interno all’approccio romaniano, utile anche per evitare un possibile fraintendimento circa le implicazioni dell’ottica istituzionalista alla base de L’ordinamento giuridico.
Il possibile fraintendimento consiste nel ravvisare, al cuore dell’ontologia giuridica romaniana, una sostanziale apoliticità, riconducibile a un disinteresse scientifico per ogni differenziale di potere rinvenibile nei rapporti tra ordinamenti giuridici (o tra istituzioni, ché è dire per Romano la stessa cosa); sia tale disinteresse dettato da una non rilevanza scientifica (la scienza giuridica non si occupa di potere) o addirittura da una irrilevanza fattuale (differenziali di potere non hanno conseguenze significative sui modi in cui le istituzioni si relazionano tra loro). Contro ogni possibile sospetto di un irrealistico irenismo, va qui richiamato il carattere costitutivamente agonale del pluralismo giuridico di Romano: la comune natura giuridica di ogni stabile regolamentazione sociale è pensata non già al fine di un armonico e confluente contributo da parte di ciascuna di esse alla formazione di un super-ordinamento che garantisca una pacifica coesistenza tra le differenti realtà istituzionali a esso facenti capo, quanto piuttosto alla consustanziale concorrenzialità tra forme di regolazione e modelli interazionali il più delle volte incompatibili. Lungi pertanto dal risultare estranee alla comprensione giuridica, le relazioni di potere finiscono, nell’ottica di Romano, per diventare parte integrante di essa, quale capitale simbolico e al contempo forza materiale in grado di disporre di sufficienti risorse per rendere vincolante un determinato ordinamento, accordando o negando riconoscimento giuridico a realtà istituzionali altre da sé. Una vera e propria lotta per il riconoscimento giuridico, dunque, quella prefigurata nel testo di Romano, che come tutti i classici sembra parlare più a noi (e di noi) che all’epoca in cui vide la luce.









