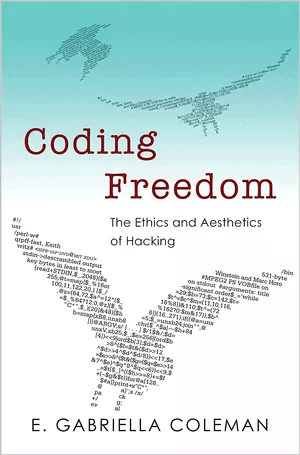Gli agnostici dell’utopia digitale
Gli hacker stanno ridisegnando il volto delle società liberali contemporanee. Non solo perché sono protagonisti dell’evoluzione delle tecnologie digitali e della rete, che hanno un ruolo cruciale nell’economia e nelle vite di miliardi di individui. Ma anche perché le azioni degli hacker sono in grado di portare una critica fondamentale all’interno della struttura politica delle nostre società basate sulla conoscenza e sull’informazione: una critica che, seppur basata su di un pilastro del pensiero liberale, come la libertà di parola, è diretta ad altri fondamenti di questo stesso pensiero, come il diritto di proprietà intellettuale.
Lo scontro tra questi due diritti è visibile in decine di avvenimenti della storia più recente, ed è uno dei sintomi più evidenti delle contraddizioni insite in un modello di società in cui il diritto relativo alla proprietà privata si è espanso a tal punto da condizionare le nostre possibilità di leggere, scambiarci una canzone o produrre e condividere cultura. È quello che sostiene Gabriella Coleman, antropologa e docente di studi sulla scienza e la tecnologia all’università McGill di Montreal, nel suo Coding freedom. The ethics and aesthetics of hacking, pubblicato da Princeton University Press e ancora in cerca di un editore in Italia. Coleman si basa proprio sui teorici del liberalismo, come John Stuart Mill o Jürgen Habermas, o su autori contemporanei come Yochai Benkler e il suo lavoro sulla produzione sociale online.
Il lavoro di Coleman si basa su un decennio di etnografia a contatto diretto con i programmatori di diversi progetti di software libero, cioè software che viene scritto pubblicando anche tutti i dati del suo “codice sorgente” e permettendo quindi a chiunque di studiarlo, rielaborarlo, migliorarlo, e poi redistribuirlo. L’esempio più conosciuto è quello di Linux, un progetto che è stato in grado di riunire migliaia di programmatori sparsi per il mondo, pronti a cooperare online per scrivere un sistema operativo che oggi è alla base di molti servizi che usiamo quotidianamente, dai server del web che in stragrande maggioranza usano il software Apache basato su Linux, a quelli di Google, sino ad Android sui nostri cellulari.
L’avvento del software libero ha dimostrato che una forma di produzione alternativa a quelle verticiste basate sul comando e l’organizzazione burocratica aziendale è possibile, e proprio su un prodotto così complesso come il software. Tuttavia il software libero e l’attività degli hacker sono stati spesso interpretati secondo due assi principali, come ricorda Coleman. Da un lato chi vede in queste nuove forme di cooperazione l’emergere di un artigianato digitale reso possibile dai computer e dalle reti e che riporta al centro della scena l’individuo e le sua capacità. Dall’altro chi vede nella collaborazione online dei programmatori di software libero un’alternativa radicale al capitalismo informazionale, la prefigurazione di un nuovo tipo di democrazia dal basso nel quale i mezzi di produzione e di informazione sono nelle mani dei produttori organizzati in nuove forme di cooperazione e mutualismo.
Coleman critica queste due visioni in qualche modo semplicistiche per ricordare che come già notato da molti teorici della società dell’informazione, tra tutti Manuel Castells, il software libero è politicamente “agnostico”, cioè rifiuta una chiara definizione politica, aprendosi all’utilizzo per scopi diversi e persino opposti. Nel libro Coleman porta esempi eterogenei di adozione del software libero e di quanto diversificate possano essere le basi culturali ed ideologiche su cui fondare il suo uso. Il gigante dell’informatica Ibm mise in campo una strategia di passaggio al free software per scopi ovviamente di profitto, con una campagna che insisteva sulle caratteristiche di flessibilità, scelta per i consumatori e libertà dalle burocrazie statali, seguendo la tradizione aperta da Apple nel 1984 con il famoso spot in cui i suoi computer permettevano di sfuggire al controllo del Grande Fratello orwelliano.
I computer come strumenti di liberazione dalle pastoie burocratiche, per ampliare l’accesso alle opportunità aperte dalle reti e realizzare un mercato più libero. Non certo equo nei risultati dei processi di mercato, ma piuttosto nelle opportunità di ingresso – in fondo è la retorica di rimozione degli ostacoli alla libera competizione che è dominante negli Stati Uniti. Per le piattaforme di informazione dal basso di Indymedia, nate con le mobilitazioni di Seattle contro l’Organizzazione mondiale del commercio nel 1999, scegliere il software libero era al contrario una decisione in contrasto con la privatizzazione dell’informazione e tesa a fornire a chiunque uno strumento contro le corporation e i loro interessi. Nel libro sono analizzati anche gli scontri con il Digital millenium copyright act, la repressione contro gli hacker negli anni Duemila, la nascita della licenza Gpl a opera di Richard Stallman e altri tra i principali avvenimenti che hanno fatto la storia delle ultime generazioni di hacker. Il mondo hacker è complesso e molto eterogeneo, e al suo interno vi sono molte sottoculture differenti, dagli hacker più politicizzati italiani e spagnoli a quelli più individualisti e orientati al mercato che sono maggioranza in altri paesi.
Tuttavia Coleman sottolinea i tratti comuni. La meritocrazia compensata dall’adesione all’imperativo etico del rimettere sempre in circolazione il valore prodotto (il codice). La capacità di mettere le proprie competenze tecniche, sociali e giuridiche al servizio di un ideale di liberalismo individuale che tuttavia cozza contro i dettami del neoliberismo che estende i confini della proprietà privata. L’attività degli hacker contribuisce in modi inaspettati a ridefinire il significato di termini come “individuo”, “libertà”, “trasparenza” o “proprietà”. Per esempio contribuendo a smitizzare l’idea che la proprietà intellettuale, copyright e brevetti, rappresenti un incentivo in qualche modo “naturale” all’innovazione: il software libero e il copyleft dimostrano il contrario, cioè che altri incentivi possono funzionare come e meglio del copyright pur basandosi su ideali liberali come la libertà di espressione. La volontà di creare, comunicare e condividere può prevalere su quella di privatizzare i frutti del proprio lavoro.
Gli hacker sono capaci di innovare le forme politiche in azione all’interno dei mondi digitali. Ma scrivendo codice in contesti culturali e politici densi di attenzione alla questione della libertà di espressione, gli hacker hanno soprattutto costruito tecnologie che incarnano una politica precisa, che si tratti dei software che sviluppano, delle licenze per gestire i diritti di proprietà intellettuale che scrivono, come la licenza Gpl, o delle strutture decisionali che progettano e implementano per gestire sforzi collettivi complessi come il progetto Debian. Hanno, come dice il titolo del libro, programmato libertà.
Facendolo hanno dato vita a conflitti che sono decisivi per le sorti della società dell’informazione. Facciamo l’esempio di due casi non contenuti nel libro ma che aiutano a capire la posta in gioco negli scontri sulle libertà digitali. Uno dei casi più drammatici di questo tipo di conflitti è quello di Aaron Swartz, il programmatore e attivista per la cultura libera che si è tolto la vita pochi giorni fa negli Stati Uniti e per il quale era stata chiesta una condanna a trentacinque anni di carcere e un milione di dollari di multa per aver scaricato dall’archivio digitale Jstor un database di milioni di articoli scientifici.
Il caso di Swartz è paradigmatico dei conflitti esplosi con l’avvento delle tecnologie digitali, in cui le capacità di singoli programmatori o di gruppi di hacker di forzare l’accesso a un sistema svelano i meccanismi di potere al lavoro nelle nostre società. Il diritto individuale all’accesso, alla trasparenza, al diritto di espressione, come mezzo per svelare contraddizioni. Un altro caso è quello di Salvatore Iaconesi, l’artista e hacker di Art is open source che pochi mesi fa ha scoperto che i dati contenuti nella sua cartella clinica, cioè le immagini della risonanza magnetica e gli altri esami che avevano svelato il suo tumore al cervello, erano in un formato non leggibile dai personal computer. Per questo li ha crackati (aperti, in gergo informatico) e pubblicati online per condividerli con tutti gli utenti della rete. La sua richiesta di una “cura open source” ha attirato più di duecentomila risposte nel giro di due mesi, sotto forma di consigli medici ma anche opere d’arte. Il suo caso ha forzato il nostro paese a interrogarsi sull’importanza di rendere accessibili, standardizzate e riproducibili le informazioni mediche che il sistema sanitario fornisce ai suoi utenti. Tra le libertà di cui un individuo dovrebbe poter disporre rispetto al suo rapporto con la medicina vi è anche quella dell’accesso senza alcuna restrizione alle informazioni che lo riguardano.
Il lavoro di Gabriella Coleman è destinato a restare un punto di riferimento per chi è interessato a capire la politica degli hacker. Negli ultimi anni, mentre era in pubblicazione il suo libro sul software libero, Coleman si è occupata della rete hacker Anonymous, della quale è diventata una dei maggiori esperti a livello mondiale e in qualche modo una delle poche referenti pubbliche. Il suo incontro con Anonymous l’ha portata anche a scrivere pagine interessanti sulla trasformazione dell’etnografia e del mestiere dell’antropologo ai tempi della comunicazione digitale, e quindi a innovare gli strumenti a disposizione delle scienze sociali per comprendere le culture che nascono e agiscono all’interno delle reti digitali. Lo stesso Coding freedom è stato pubblicato sotto licenza Creative Commons e quindi chiunque può copiarlo e distribuirlo, purché non lo faccia a fini di lucro. La versione pdf è scaricabile liberamente dal suo sito.
Pubblicato su Il Manifesto, 26 gennaio 2013
Alessandro Delfanti
twitter: @adelfanti