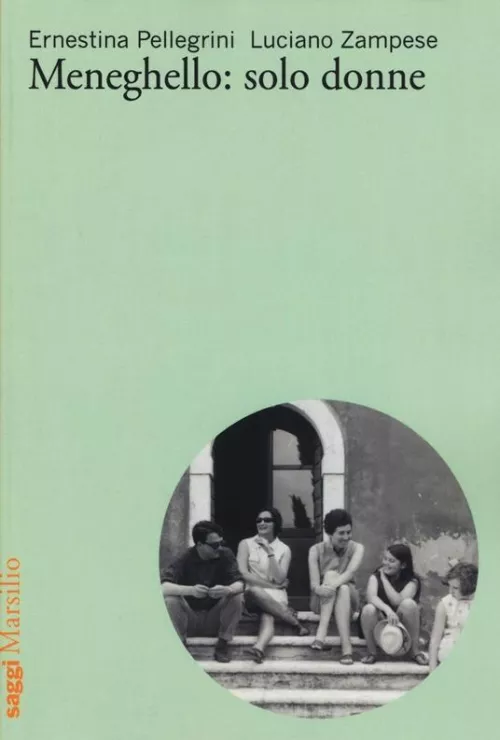Dizionario Meneghello / Il gineceo di Luigi Meneghello
“Lo so che siete fantasmi, voi donne”
esclamò alzando gli occhi al soffitto,
“ma che cosa ci posso fare io?” (L. Meneghello, Le Carte, vol.1)
Mi sono occupata più volte del gineceo di Luigi Meneghello, delle sue rappresentazioni di donne nelle sue tante opere, ma mi fa piacere tornare qui sull’argomento, rimandando il lettore curioso, per una trattazione sistematica, al libro che ho scritto a quattro mani con Luciano Zampese, Meneghello: solo donne, uscito per Marsilio nel 2016. Meneghello suggerì questo titolo, Solo donne, in uno dei primi giorni di maggio del 2006, a Firenze, quando, dopo essere stati a vedere La deposizione del Pontormo in Santa Felicita, parlavamo, un po’ sul serio e un po’ per divertimento, dell’idea di fare un’antologia dei ritratti femminili presenti nelle sue opere. Ricordavamo la brillante nota di Mengaldo, nell’introduzione del secondo volume Rizzoli delle Opere, che, partendo dal capitolo ottavo di Bau-sète!, diceva così:
Nel modo rapsodico giustamente indicato da Bandini, vi si snodano brevi storie di amori sfiorati o falliti, abitati da amabilissimi personaggi femminili: la Simonetta, che fa da aggancio col finale de I piccoli maestri, la tenera guerrigliera ricoverata in sanatorio, ecc. Sono fra le pagine più belle che Meneghello abbia scritto: l’abbandono mette la sordina alla consueta ironia, e la rievocazione assume toni che possiamo dire lirici senza offendere il ritegno dello scrittore. E sono pagine così riuscite, io credo, soprattutto per la buona ragione che è molto difficile trovare uno scrittore (italiano) che come lui abbia non dico tanta comprensione ma tanto tenero affetto per il femminile, singole e categoria. Fossi in lui, scriverei solo di donne, o accompagnato da donne. (P.V. Mengaldo, Meneghello “civile” e pedagogico, in L. Meneghello, Opere, Vol.2, a cura di Francesca Caputo, Rizzoli, Milano 1997, p. XXIII)
Si pensa subito alla Simonetta dei Piccoli maestri che “dava l’impressione di venir dietro, come una cucciola” (PM, p.339) e alla partigiana Natascia che aveva “lunghi capelli lisci tirati di traverso sul viso come un siparietto, e tenere labbra, e una P.08” (PM, p.92). Viene in mente anche la gigantesca staffetta Sulster, in blusa e calzoni, con ‘la grandiosa montagna del sedere, che escludeva lo sguardo da tanta parte del cielo’ (PM, p.155), e anche Adriana Boniver che, in Bau-sète!, assomiglia tanto a Mathilde di Le rouge et le noir di Stendhal (BS, pp.548-553). Profili di donne, emancipate in un baleno dalla guerra, scaraventate da un Home-front a un Battle-front che le ha rese fiere, autonome e spericolate. Le indicazioni di Mengaldo sulla bellezza e potenza di questi frammenti narrativi declinati in Desinenza A, per dirla alla Carlo Dossi, avevano molto colpito e lusingato lo scrittore vicentino, anche perché riscattavano una materia che era stata liquidata da alcuni recensori di Bau-séte! come tracce di narcisismo, ferendolo in un punto nevralgico, tanto che lo avevano costretto a puntualizzare la cosa nel libro intitolato La Materia di Reading:
E veniamo alle ragazze e alle motociclette che a quanto pare sono state viste come frivolezze e banalità edonistiche della mia vita d’allora e forse (non ho ben capito) della mia scrittura di oggi; cose colpevolmente private, poco serie. […] Quando sento formulare critiche di questa specie su questa faccenda delle moto e delle ragazze, io mi dispero! Le ragazze, le moto, di cui ero “così ben provvisto” erano parte di un mondo di cose serie, seriamente amate, e sono trattate nel libro con profondo rispetto e con la stessa passione della poesia e della politica. La bicilindrica e Ugo La Malfa…moto, poeti, ragazze, idee nuove, sono nello stesso campo di magica attrazione, ammirati con simile slancio e stupore: forme di vita percepite con la forza deformante della gioventù…è ovvio che non si tratta solo di sentimenti miei (OS, p.1458).
La chiave della raffigurazione delle donne è realistica, lontana da ogni idealizzazione neostilnovistica. Lo scrittore ricorda quando da ragazzi coi suoi amici tentavano di fare con la creta la “Donna Ideale”: “C’era un’altra importante creatura della crea, la Donna Ideale o piuttosto la sua testa, perché era nata solo con la testa e con un principio di collo… Aveva la permanente anni Trenta e i tratti del viso affilati e purtroppo un po’ spocchiosi, una specie di Greta Garbo andata a male…”. E ancora: “Ogni tanto sento sormontare un lirico modo (mood) e come acido corrosivo mangiarmi lessico, grafemi, sintassi” (Le Carte, Vol.1, p.443).
Esiste, all’interno dell’opera di Meneghello, un punto in cui lo scrittore descrive l’architettura del luogo delle donne. Si trova in Jura. Gineceo, harem, monastero, recinti stretti e impenetrabili. Perché affascina l’idea della reclusione con le sue penombre, e il corollario doloroso, altero dell’impenetrabilità? Un po’ tempio, un po’ prigione, un po’ pollaio; come sfuggono i confini, come si ribaltano le prospettive.
Si saliva per belle scale di pietra viva: a un primo pianerottolo, nudo, disadorno, sparuto, molto bello, un pianerottolo a mattoni con una finestrella a inferriata che di nuovo guardava verso qui, e da cui salendo ancora si arrivava a un più ampio, dimesso, in apparenza banale luogo a pianta rettangolare. Era la piattaforma-madre, meraviglioso crocicchio delle porte. C’era davanti la porta delle camere della zia Lena, da me sentite come un gineceo (l’ho capito quando più tardi ho imparato la parola), il luogo delle donne, la zia la Flora la Este l’Annamaria: lo zio pareva un po’ un ospite… Piero non c’era, era in collegio, Roberto non era nato ancora, quelle stanze grandi, nude, a mattoni erano il reame delle donne. (J, p. 1159)
I ritratti di donne che troviamo disseminati in tutta la sua opera, da Libera nos a Malo ai tre volumi delle Carte, sono nodi centrali e nevralgici della narrazione, sono carichi di passione e di stupore – ‘un mondo di cose serie, seriamente amate’ - ma rispondono anche ad una forte spinta conoscitiva e catalogatoria, a un bisogno quasi ossessivo e difensivo di distinzione e oggettivazione. Strategie narrative precise che ci permettono oggi di raggruppare le immagini per serie, con canoni maggiori e minori, in sintonia con le leggi compositive rigorosissime dell’autore, che organizza la sua materia su due binari stilistici opposti e complementari: da un lato c’è l’abbassamento ironico-sarcastico, che dà vita ad un’esilarante e inedita commedia dell’arte tutta al femminile, e dall’altro c’è l’innalzamento estetico, che tocca corde vertiginose soprattutto all’interno della larga e a suo modo “bassa” categoria delle Paesane, di ogni classe d’età. Si può dire che Meneghello tenda ad abbassare e rovesciare là dove c’è retorica e pomposità, e tenda a innalzare nei momenti in cui raffigura le sue donne di Malo, le sue “povere diavole”. Bastino due esempi di questi movimenti e stili antagonisti. Il primo è tratto dal primo volume delle Carte, in cui si sentono echi, naturalmente in chiave semibuffa, da quella specie di Vangelo primonovecentesco che è Sesso e carattere di Otto Weininger, e dove c’è anche un’allusione, in chiave molto seria, alla poesia A mia moglie di Umberto Saba:
Qualche volta guardandola in viso penso a una cagna, giovane s’intende, sana, bella a modo suo, ma naturalmente animalesca, cagnesca. Anche il corpo robusto ha tratti piacevolmente bestiali nell’impianto delle anche, dei cosciotti. Piange e ride facilmente, con l’aria di fare in entrambi i casi più o meno la stessa cosa. Si intravede un’anima vegetativa proporzionata alle dimensioni corporee, un’animona, con qualche tratto ancora quasi infantile. La penso stipata (nel corpo) di latte e di dolciumi, ma potrebbero essere patate, mucchi di frutta divorata ridendo, nello stesso modo in cui golosamente lei si nutre di musiche, versi, drammi moderni, e della morfologia del greco antico. […] Mi accorgo che tutto diventa per lei materia di autocompiacimento, alimento di amore di sé: l’infanzia, gli affetti in famiglia, gli entusiasmi per le cose che le capita di leggere, la ricerca delle ultime verità in Le rouge et le noir. Le ultime verità non le sa nessuno, Sharon, non sono nei libri, neanche a questo livello, tanto varrebbe cercarle nelle Noterelle di uno dei Mille…Se volete aforismi sulla vita sarebbe più semplice che ve li dicessi io stesso. Non essere amata, guardarsi allo specchio, domandarsi vezzosamente “chi sono?”, vagheggiare l’amore del papà per i tubi, nobilissimo amore… (L.Meneghello, Le Carte, Vol.I, Rizzoli, Milano 1999, pp.304-6)
Il secondo esempio, di innalzamento, è preso da Maredè Maredè…, ed è il ritratto di una donna del popolo che ha perduto il figlio. Una specie di Pietà michelangiolesca in scala maladense:
La fossa del bambino dei Giacomèi qualche giorno dopo che fu seppellito: la Giacomèla (trentacinque anni, in nero) gettata come fagotto sopra la mota della terra accumulata, con lo scoatèlo dei fiori dall’orto: parlava concitatamente alla terra, gemendo e singultando, ma non con la formalità delle prefiche, o delle madri che strillano per il beneficio dei poeti e dei cineasti, a Troia, a Partitico, a Cinecittà, quando gli viene fatto fuori il figlio da una dea o da un brigadiere, e si mettono a recitare quelle sequenze di Opopoi! Figghiu beddu!... No, la Giacoméla discorreva, sia pure in modo convulso, e mi accorsi che discorreva coi soggiuntivi e tutto…Il sole era tramontato, il cimitero era vuoto, io rabbrividivo, e i paradigmi funzionavano (MM, p.468).
È facile trovare innumerevoli esempi di sentimenti di ammirazione incondizionata dell’autore per il mondo delle donne, nonché una frequente ammissione e dimostrazione, altrettanto ironica, della superiorità del sesso femminile: “Eroina, quasi una donnetta che faccia cosine eroiche. Per donne e cose grandi, qualcosa come EROA” (C1, p. 428). E ancora, sfidando e superando ogni dogmatismo linguistico femminista, l’autore scrive in Maredè, maredè...:
Se le donne vorranno che (parlando in VIC) non usiamo più l’articolo davanti ai nomi (la Susan, la Marilena) o ai cognomi delle donne (la Green, la Morante), penso che così sarà giusto fare. Ma finché la volontà delle donne non sarà cristallizzata, vorrei esporre un mio punto di vista, sperando che possa influenzarne qualcuna. Mi sembra evidente che con o senza articolo “donna è bello” (VIC dòna zé bèlo), ma anche il la del dialetto premesso ai nomi di donna e ai loro cognomi ne dà un chiaro segnale: è un ornamento che l’uso ha provvisto e che sarebbe buona cosa preservare. La Pozàn (la Possana), la Maniero […]: potenze paragonabili a la Spagna, la Francia (MM, p.615).
Preme inoltre ricordare che in Maredé, maredè…, e precisamente nei Cenni preliminari delle Note di morfologia elementare, si legge questa avvertenza:
Nei paradigmi e negli esempi (come anche nel testo dei Sondaggi) ho cercato di contrastare meglio che ho potuto l’antica e quasi universale usanza di dare la precedenza alle forme maschili e agli uomini. Ho fatto ciò che ho potuto per mettere invece prima le donne e le forme femminili, ogni volta che si poteva farlo senza creare serie difficoltà di lettura o sconquassi grammaticali troppo grossi…(MM, p.227).
Dalla schedatura di questi medaglioni femminili, di questi Profili di donne, per usare un titolo alla Capuana, viene fuori un vispo museo vivente, un personale, tascabile De mulieribus claris, che si affianca ad un disseminato e involontario, e anche esilarante, trattatello De Amore – sul matrimonio, sulla seduzione, sulle attrazioni magnetiche e oscure di una ‘femminilità’ sganciata da ogni stucchevole ontologismo, una femminilità incarnata di volta in volta in un soggetto concreto, in un unicum irripetibile e del tutto contingente, dalle coordinate geosociostoriche infallibili (ci sono le maladensi, le vicentine, le veneziane, le inglesi, le gallesi, le irlandesi, le australiane, le americane, le israeliane, le egiziane, e persino le etrusche ecc.) - con relative appendici esemplificative di una – come chiamarla? – pseudodarwiniana guerra fra i sessi, illustrata col gusto dell’entomologo e del collezionista.
Si costruisce, libro dopo libro, una imponente galleria di ritratti, e si delineano i raggruppamenti per tipologie (le bambine, le maestre, le paesane, le mitiche zie e tutta la genealogia familiare, le partigiane, le balie e le donne di servizio, le suore, le studentesse, le colleghe inglesi dell’Università), con distinzioni abbastanza nette (The Matter of Britain; la roba maladense), e classificazioni storicizzanti, con distinzioni di epoche, con affondi archeologici (le magnifiche donne fossili, le Vittoriette australopiteche, la donna mummia, le frutaròle con le loro botteghette arcaiche, e il gineceo delle zie situato al meraviglioso crocicchio delle porte), un mondo rievocato e studiato nei minimi dettagli con marcate coloriture sociologiche e antropologiche. Da qui le idealizzazioni antiche e indistruttibili (le donne a priori del paese di una volta), gli shock della modernità, gli sbiaditi frutti del postmoderno, quasi larve di donne state a bagno nella varichina.
Il passaggio dei decenni, le trasformazioni socioeconomiche del paese producono sconquassi nella cultura paesana, processi irreversibili indicati magari sul filo di un verbo che perde la sua presa, come snasare:
Ah, so zio, el ghin’a snasà tante…E l’è sta castigà…In altro senso si può dire che è stato castigato anche questo uso di snasare, sentito come un termine tecnico: “fare una mezza corte (a una donna), con vaghi sottintesi di fidanzamento; corteggiare una donna in modo provvisorio, saggiarne il costrutto femminile, prenderla in considerazione senza vero impegno”. Nella frase riportata la parlante (a differenza forse del parlante medio sensuale) non sente nel verbo l’annusare del cane, la vicinanza del naso alle parti intime della cagna, l’odore che s’immagina pungente…
El ghin’a snasà tante, so zio…Torna (giovane, ardita, moderna) la nipote di un’argentea Direttrice Didattica: Martina o Renata… Sta sugli scalini delle Scuole, corti i capelli castani, scampanata la cottola a pieghe…mio zio le si accosta, la snasa. È come una cerimonia…
Come paiono semplici e svelte, oggi in queste cose, le maniere delle ragazze e dei ragazzi. Forse non si potrebbe nemmeno dire con proprietà che si snasino, l’oggetto dello snasare antico, l’aura segreta, non c’è più, una debole varechina post-moderna la disperde…(MM., p.521).
Permettemi di dare qualche campione esemplificativo dai vari repertori. Vorrei cominciare dal ricchissimo catalogo delle bambine maladensi, quasi tutte presenti nella briosa galleria di Libera nos a malo, che sarebbe interessante mettere a specchio critico con quanto Meneghello ha scritto sulla Lolita di Nabokov sulla rivista “Comunità”, negli anni Cinquanta. Sono bambine ‘scompiglia-visceri’ (LNM, p.22), per cui è stato provato a suo tempo un ‘rapimento sublime’, e con le quali è avvenuta l’iniziazione ai giochi erotici:
“La Norma la prendo io, tu prendi la Carla”.
E io prendevo la Carla, ma in segreto ammiravo la Norma! Il pallore della Norma! Quello sbiancare della pelle all’interno delle cosce. La Carla era una bella tosetta, ricciuta e ben fatta, scura di pelle, cordiale; ma la Norma era un molle tranello in cui bramavo cadere. Però prendevo la Carla: l’idea di contraddire Piareto non mi sfiorava nemmeno. Io ero più giovane (e la Norma, che aveva forse sei anni, la più vecchia) e non toccava a me scegliere. E poi mi sarebbe dispiaciuto offendere la Carla, tanto simpatica e volenterosa. E così nel folto dei rampicanti a metà dell’orto, in una penombra verde subacquea, deposte tra i filari le spade di legno, facevamo le brutte cose con le nostre donne accucciate per terra. Ma con la Norma ebbi un’ora di rapimento sublime nello stanzone sopra la cantina, dietro un oggetto che ricordo nelle sue forme essenziali, nido schermo tetto, probabilmente un moncone di carrozzeria d’auto. […] Ci arrampicammo lassù io e la Norma per giocare, e senza accordi preliminari, senza parole, fui ammesso per una breve ora alla comunione delle superfici esangui, del dolce nodo dove smorivano (LNM, pp.7-8).
Vengono riportati con puntualità antropologica e con spumeggiante brio narrativo i rituali del corteggiamento, la fenomenologia delle seduzioni “a tradimento”, la dinamica degli ati impuri, compiuti ed espiati fra i luamari e le chiese (con i pentimenti, le ricadute, con le relative e contorte confessioni col parroco di turno). Ci si sofferma sui soprannomi affettuosi dati alle piccole donne, sui rustici complimenti (“le bambine a scuola in genere le chiamavamo le cavre”, LNM, p.51), con disinvolti cortocircuiti fra questo sguardo dal basso, dell’occhio bambino, ce i numerosi, impliciti echi e rimandi letterari, dai poemi cavallereschi a Piovene, a cominciare da Dante della Vita nova:
Ma nessuna donna credo fu mai tanto amata in paese, e da tanti, e così fulmineamente come la pallida Sidonia. Io avevo una squadretta di calcio di cui ero padrone e capitano perché il pallone era il mio. Il sabato arrivò in paese la Sidonia, la domenica tornando da messa ultima mio zio Dino mi domandò con chi giocavamo quel giorno. Dissi che avevo sospeso la partita perché avevo mezza squadra innamorata. “E della stessa donna” aggiunsi gravemente. “Eh , ostia” disse Dino. “E chi sarebbe questa vampira?”. Glielo dissi, che era una di Vicenza, arrivata appena, e Dino capì ed ebbe la finezza di non domandarmi altro. Amai la Sidonia com’era giusto amarla: subito e senza condizioni, come cosa venuta da Vicenza a malo a mostrare com’è un miracolo (LNM, p.53).
Dall’esibizione di una parziale campionatura viene fuori - al di là della bellezza letteraria dei materiali raccolti, che risultano come potenziati dalla prospettiva tematica e di genere – un’utile documentazione su certi meccanismi del lavoro letterario di questo grande scrittore, sul suo procedere per veri e propri sistemi per points, col gusto della serie e del canone. Nel primo volume delle Carte, troviamo un brano da cui si capisce l’ironica relazione di distanza che si crea fra la cruda, tagliente prospettiva fenomenologica e la viziosa, dolcissima astrazione metafisica : “Donne: la donna sapiens; la vergine emancipata; la femme mariée…E poi? Luce di lampo le impreziosisce invano. Altro era l’archetipo’ (C1, p. 18). Sempre nello stesso primo volume delle Carte, c’è la serie non contingente delle ‘Veneri’, Veneri che rivelano tutta la pericolosità della loro carica magnetica, la forza micidiale e incontrollabile della seduzione. Altrove, all’interno del ciclo cosiddetto di impegno “civile”, compaiono le attivissime Amazzoni, le cerebrali Atene, le selvatiche donne artemidee, che culminano nelle attraentissime donne con la pistola, nelle Armide partigiane, nelle Clorinde dell’Altipiano che la corazza, prima che fuori, se la sono costruite dentro: “capii che [la Guerrigliera] a me piaceva vestita da soldatessa, da driade armata, non da signorina di paese in abito da festa… Insomma questa donna mi aveva affascinato in veste di creatura dei boschi e della guerra nei boschi” (BS, p.542).
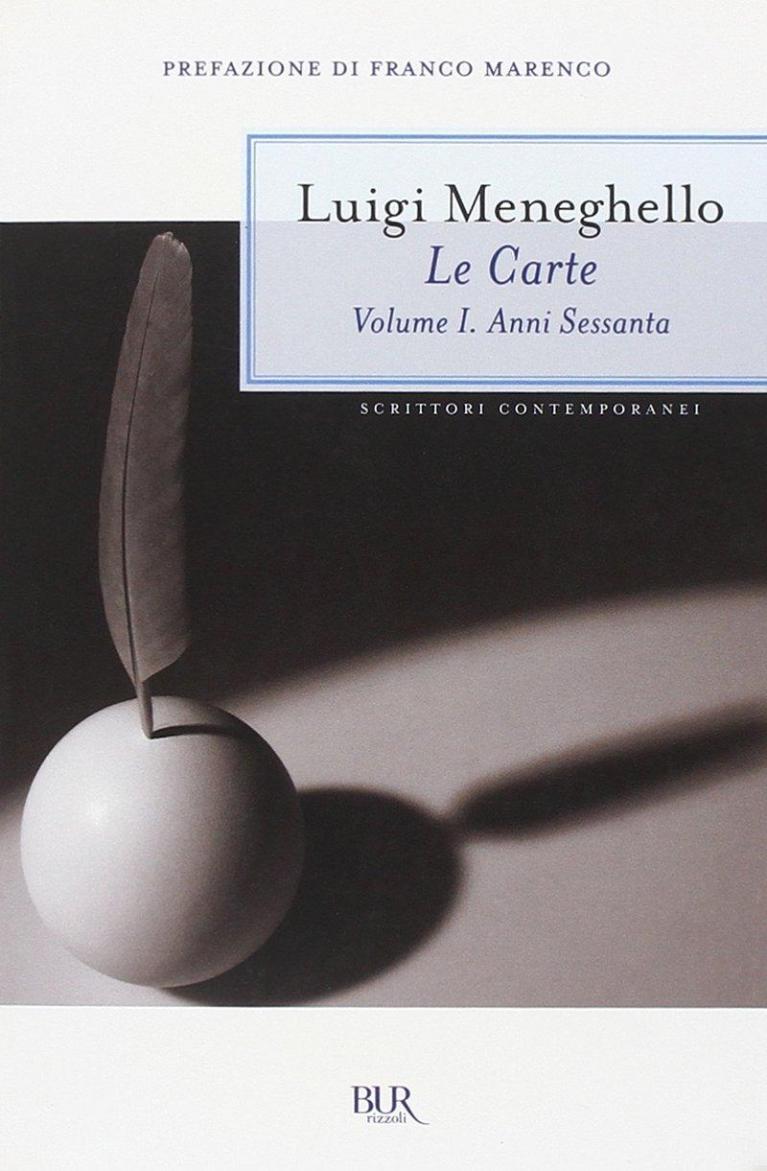
Il metodo non tende all’universale, semmai enfatizza le differenze. Ecco il cataloghetto delle Veneri: “Le veneri tristi, sciocche, intense ecc. La venere celeste: sparpagliare rosolio. L’altra, selvaggia, ricorda le cariche che si collocano negli anfratti (del monte, dei ponti): quando scocca l’ora la loro potenza si libera, squarciano gli anfratti… Così questa venere: esplodere in cavità” (C1, p.153).
La bellezza in genere, e quella femminile senza alcun dubbio, sembra all’autore qualcosa di naturalmente e enigmaticamente pericoloso. Su questo aspetto egli si esibisce in una vera e propria simulazione e parodia della letteratura simbolista e decadente. C’è dietro l’amato Baudelaire con le sue donne maledette, le sue Veneri nere, le sue donne serpente; ci sono gli Idoli di perversità studiati da Bram Dijkstra (Garzanti, Milano 1988); ci sono tutti gli elementi legati a la carne, la morte, il diavolo, studiati da un noto anglista. C’è l’impronta preraffaellita, dove si incontra Christina Rossetti:
Christina Rossetti, splendore dei ritmi, come in O’er crag, morass, and hairbreath pass, ma anche certi spunti, come là dove dice: O Jesus, drink of me (cioè, Gesù, béveme! O forse To’ Gesù, bivi!) (in C3, p.259).
Nella furia sistematica di questo scrittore “libertino”, per il quale sarebbe facile per l’argomento in questione coniare la formula desidero ergo sum, c’è persino, nel secondo volume delle Carte, l’aerea fantasia di una squadra di calcio tutta composta da grandi donne: “Eva in porta; Anita Garibaldi, Penelope, Santa Teresa…come pareva spassoso! Come eccitava l’idea di Giovanna d’Arco in ala, e Saffo centravanti!” (C2, pp.401-2).
In una disseminata e interessantissima metafora ossessiva – chiamiamola così – che troverei stupido e banalizzante spiegare, si trovano legate donne e mezzi di trasporto (macchina, motocicletta), ma soprattutto donne e armi, proprie e improprie, a cominciare dalle zie castratorie del Tremaio fino alle donne macellaie dell’Esempio di morte ai margini del testo in Libera nos:
Il pantàsso! Come nelle poesie di Montale, il nome agì, e con esso mi aggirai in un limbo favoloso tutta la mattina. Ora che lui non c’è più, tocca a loro, alle donne. La Nina afferra le gambe posteriori, la vedova impugna le orecchie, la Nora prende la mira, volta lo sguardo e assesta il primo colpo. Conche cosa? Con un coltellaccio: per il dorso naturalmente, non per il taglio. E muore alla prima botta? Muore e non muore.
La Nina si curva a osservare l’occhio, per vedere se si vela, se “guarda lontano”; quello è il segno che sta morendo. La Nora raddoppia i colpi, infierisce con mano che la pietà e il panico rendono sempre più incerta. A volte la paura di non averlo ancora ucciso le sopraffà: allora gli appoggiano il collo su un ceppo, e la Nora lo pesta col dorso del coltellaccio, a piccoli colpi fitti, finché la pelle della coppa tocca quella della gola (LNM, p.380).
Da una puntuale analisi del numero complessivo delle figure femminili risulta che più della metà delle presenze è contenuta nell’immenso serbatoio delle Carte, che lo scrittore stesso ha definito più volte in occasioni pubbliche come il suo “retrobottega”, i tre volumi che potrebbero essere visti da noi, con un raffronto un po’ azzardato a un noto film di Fellini (con il sogno del proprio harem e poi la splendida scena finale della passerella, con le donne che scendono la scala), come quel luogo mitico e un po’ segregato che è la soffitta: una soffitta recinto, il vagheggiamento di un Harem personale, una Città delle donne da rivisitare a piacere col gusto del possesso e di un non dissimulato vagheggiamento, venato però da una certa paura (e tensione) di identificazione (R.Cini, Nella città delle donne. Femminile e sogno nel cinema di Federico Fellini, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), 2008). Ecco un nodo interessante. Su questo fenomeno psicologico della paura delle donne, che proviene da una più profonda paura, che è quella di essere come loro, anzi di essere una di loro, Meneghello scrive una pagina indimenticabile intitolata Le fonti oscure, che come sempre trasforma e condensa in racconto ciò che potrebbe essere sviluppato pedantescamente in termini psicoanalitici. La citazione proviene da Jura:
La paura degli altri è un tema ricco (la gente è quasi universalmente fifona) ma anche un po’ strano. In una delle poesie della raccolta intitolata Giglio, S. descrive la reazione fobica di un suo parente, piccolo ma importante, nei confronti dei fuochi artificiali. […] È una paura disperata: da dover tappargli le orecchie e chiudergli gli occhi. Ma c’è di peggio, la bellezza femminile. Questa gli provoca una specie di panico. Se intravede “Adriana oppur Marcella” (e ammettiamo che sono bambine piuttosto radiose) “scappa via come fosse una gazzella” terrorizzata. Che fare?
Oimè dovranno mettergli le gonne
A quel pauroso paura-di-donne,
che sarebbe poi il metodo omeopatico: ma allora non si aggraverebbe la situazione? Certo la fuga, nei modi della svelta “gazzella”, non serve: i rumori (ma si stava parlando di donne o di rumori?) t’inseguono e ti raggiungono, resti inchiodato sul marciapiede, indifeso, e lì t’investe la mostruosa scarica delle “ruote” finali, a cui qualcosa dentro di te si mette a rispondere meccanicamente con piccole scariche in proprio. […] Davanti a “Adriana oppur Marcella” ha imparato a nascondere quello che prova, le gambe fremono ancora, ma almeno non partono. E l’amore-spavento che gli incutono le donne non è più così strettamente associato al sospetto di essere una di loro (OS, pp.1004-5).
Oltre alle Carte, gli altri libri, in cui riscontriamo la massima occorrenza della presenza femminile, sono Libera nos a malo, Il Dispatrio e Bau-sète!, con una distribuzione per generi e classi d’età di straordinario interesse, un vero e proprio sistema costruito su una specie di personalissima teoria dei tipi, in cui compaiono: le bambine, le figure familiari (le zie, le cugine, la madre e la moglie K.), le partigiane, le fidanzate, le serve, le suore, le insegnanti, le paesane, le straniere, le studentesse, le creature oniriche e irreali, e le figure che rimandano alla letteratura o all’arte figurativa; il tutto accompagnato qua e là da un corredo esilarante di aforismi. Si rileva che la categoria più nutrita è quella delle Paesane (per usare un titolo di Luigi Capuana), il settore delle leggendarie femmine maladensi, seguita a ruota da un’altra grande categoria che si può formare incrociando le tre sottocategorie di straniere, studentesse e insegnanti, che formano la cosiddetta Matter of Britain del Dispatrio e delle Carte.
Questi profili di donne potrebbero essere ulteriormente inquadrati all’interno di due prospettive che per semplicità si possono definire così: la prima, di carattere socioantropologico, che dispone la materia secondo classi sociali, generazioni e fasce d’età, usi e costumi locali, livelli di emancipazione, autocoscienza di genere; l’altra di carattere fantastico-notturno, che dilata la realtà oniricamente, creando Capricci e Grottesche. Solo due o tre esempi. Nel primo caso, troviamo, in Libera nos a malo, la figura cupa di una contadina che ha perso il figlio – dignità, coraggio, senso tragico della vita unito a rassegnazione – una Donna di dolori abbassata, o innalzata se credete, in scala maladense, perché il meccanismo del rovesciamento sacro-profano è tipico di molte opere dello scrittore vicentino:
Del Santo Matrimonio non si potevano fare parodie da ridere, solo da piangere. La Cattinella sposata in chiesa prima del Concordato, fu abbandonata come tante altre dopo la luna di miele, e incinta. Era una piccola industria: anziché maltrattare le sceme che non serve a nulla, stupravano e derubavano le contadine. La Cattinella venne poi da noi a fare la serva per mantenere il bambino che si chiamava Giovanni e portava il cognome di lei. Era piccola e paziente, e parlava con le inflessioni del monte. Io le davo del lei, i miei fratelli più grandi del tu. Dovette sembrarle un mondo strano, pieno di novità moderne e di trabocchetti urbani, i Pullò di lana colorata, il Cacào nelle scodelle, gli strambi giochi, le curiose lezioni Alfa-Beta-Gamba-Svelta. […] Lavorava come lavorano le donne in casa, come bestie; ma non si lamentava. Il suo sogno era di vedere suo figlio farsi adulto e sistemarsi, e di andare un giorno a stare con lui, per rifarsi così almeno da vecchia la famiglia da cui era stata defraudata da ragazza. […] Giovanni era ormai un giovanotto nel 1944 aveva diciannove anni, e la Cattinella domandava consiglio. Doveva presentarsi il ragazzo? Si poteva lasciarlo andare con questi partigiani con cui voleva andare? Alla fine Giovanni andò con questi partigiani, col nome di battaglia di “Zampa”; ed era col reparto della Malga Zonta la notte del 12 agosto. C’è una fotografia dei quindici o venti ragazzetti in fila davanti alla malga, colle mani in alto, un momento prima che i tedeschi cominciassero a sparare: Giovanni è il primo della fila, in primo piano. Sembra stupito, come se non capisse bene la natura del gioco: ha un’ecchimosi sul viso, probabilmente causata dal calcio del mitra. […] Ricorderò sempre la prima volta che rividi la Cattinella dopo che ebbe saputo di Giovanni. Fu in fondo al cortile della nonna, vicino alla scala dell’essiccatoio…Era vestita di nero, enfiata e sfigurata dal mal di denti, e quando l’abbracciai non disse nulla e non pianse. Ogni anno a 12 agosto va alla Malga Zonta; spesso a piedi fino a Schio, prima dell’alba, poi col camion su per i monti. Ascolta i discorsi, depone i suoi fiori (LNM, pp160-161).
Ma sempre in questa prospettiva socio-antropologica vorrei citare anche l’emblematico e lungo passo dedicato alle Filandiere:
Per i più la vita era estremamente dura: duro lavoro nei campi, nelle officine, nelle bottegucce degli artigiani, elle filande, e durissimo per le donne nelle case e nelle famiglie. […] Le quattro filande erano l’industria massima del paese: tutte le donne del popolo o prima o poi andavano o erano andate in filanda, con orari, salari e condizioni di lavoro che riescono oggi quasi incredibili. Quando la filanda “andava”, c’era un fracasso alto e continuo di macchinari antiquati, e in mezzo come un lamento acuto il canto delle filandiere stordite:
Santa Madre, deh Voi fate
Che le piaghe del Signor
Siano impresse nel mio cuor.
Polenta e cipolla, polenta e anguria. Le filandiere uscivano a mezzogiorno, rientravano alla “cuca” tra la mezza e un bòtto. Per questo breve lunch hour non tute correvano a casa; quelle che venivano da lontano si sedevano lungo i due marciapiedi, di qua e di là della strada. Dai cartocci di carta gialla tiravano fuori la polenta e lo stupefacente companatico. Oltre alle filiere vere e proprie sapevo che c’erano le scoattìne e le ingroppine! Non pareva credibile gurdando queste donne e ragazze col colore dei bachi da seta sul viso. Ristorate, dopo una mattina di lavoro, tornavano dentro a lavorare alle bacinelle di acqua bollente fino a sera, invocando in alte grida la Santa Madre del cielo, chiedendo piaghe. […] La cura dei bachi da seta era uno di quei lavori supplementari che s’affidavano principalmente alle donne, perché non restassero in ozio: avevano solo da partorire una dozzina di figli, da allevarne una mezza dozzina, da cucinare per tutti, lavare, stirare, spazzare, rifare i letti, vuotare i vasi, lavare i piatti, cucire, rattoppare, rammendare, badare alle galline, curare i malati, pregare per il marito, andare in chiesa e baruffare un po’ con le vicine. Come riuscissero ad andare anche in filanda io non l’ho mai capito. Alla sera facevano filò, in campagna nelle stalle, in paese nelle cucine: si divertivano le pigrone, a far la calza o addirittura a giocare la tombola; oppure d’estate sedevano sulla porta con le mani in mano a vedere la gente che tornava dalle osterie (LNM, pp.119-121).
Nella seconda prospettiva, che ho definito di deformazione e invenzione fantastica, si può indicare la creazione di strane chimere, quali la sfinge, la donna-uccello o la donna-albero o la donna-banana. Vediamone almeno uno. È un ritratto che fonde mirabilmente la prospettiva sociologica e la dilatazione fantastica. Ecco Blanche, la donna uccello che chiude il Dispatrio, interessante anche perché è una delle tante personificazioni della morte presenti nell’opera meneghelliana, e che va a intensificare la carica di alterità già proposta nella raffigurazione femminile. La valenza metaforica non va a discapito del preciso e prezioso identikit storico e sociale. Da notare che Il Dispatrio si apriva, con perfetta circolarità rispetto alla fine, con una analoga immagine al nero: “Death qui in Inghilterra non è donna, naturalmente, non porta la veletta coi lustrini, non va a dire ai giovanotti orfici Je suis ta mort, ma nel complesso non è nemmeno uomo, è un travestite” (ID, p.7):
Blanche, canadese, interessantissima donna-uccello, moderna nella scorza e nell’essenza. Il nero dei capelli, armati di lunghissimi cigli, erano ombrati da tinture che parevano sul punto di corrompersi, Il profilo, il becco gentile del naso, il lungo, avventuroso taglio delle labbra, la leggerezza delle ossa, la magrezza elegante delle gambe, l’acutezza dei tacchi delle scarpe, come sproni… Vestiva finemente, in modo originale e schizzinoso. Era un po’ schizzinosa in tutto, figlia di una cultura schizzinosa… Amica dei prodotti farmaceutici, aveva orrore e fastidio delle farmacie europee dove le stesse mani che toccano e porgono le medicine e gli altri farmaci maneggiano anche il denaro: i luridi biglietti, le monete rognose! […] Blanche era da noi come in visita, un soggiorno stagionale, pochi anni: poi lasciò la Hall di Sant’Andrea, le frasche di Whitenights, mi pare che sia migrata per qualche tempo in un’università più antica, poi è volata via, così ho sentito, non è più sotto gli sguardi della luna (ID, pp.236-239)
Sono infiniti i ritratti che bisognerebbe ricordare, al di fuori di ogni gabbia catalogatoria. C’è l’irresistibile ciclo della Bistroia, ci sono le cosiddette ‘icone da viaggio’, e ci sono gli Strafanti della Compagnia paesana; c’è la piccola italiana che si inceppa nel discorso ufficiale, ci sono le adultere di provincia, c’è la Grandona, c’è la vigorosa zia Gegia (dalla quale si è appresa “la grammatica delle favole”), c’è la madre maestra e c’è la maestra Prospera; e quindi rarissimamente, quasi nel non-detto, c’è K., la moglie, alla quale è dedicata la sovraccoperta della prima edizione di La materia di Reading, una coccinella rossa, il Katibogár, cioè il nome ungherese dell’ “insetto di Katia”. Fra i riferimenti a K., basti riportarne uno, preso dal primo volume delle Carte, ora presente anche nello splendido video a lei dedicato, intitolato Katibogár, fatto da Luciano Zampese in occasione della giornata della memoria di quest’anno, ora su youtube in data 26 gennaio 2022:
Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi secondo me non vestì donna unquancho come questa. È la cosa più civile che ho trovato al mondo, benché dica «il fame» e per correggersi «il famme», e sgrammatichi in tutte le lingue; è più profonda la grammatica che sa, negli strati profondissimi della grammatica; non gerundi o casi, non algebra, non punti cardinali, ma la ragione delle cose del mondo.
Preme indicare, inoltre, come ci sia, soprattutto all’interno del retrobottega delle cosiddette Carte, una corda bruciante e vispa che inanella, a catena, una serie mirabile di ciò che mi piace definire come ritratti crudeli. Ci sono moltissimi ritratti, infatti, che nascono ironicamente dalla penna umoristicamente ‘misogina’ di Meneghello, che si diverte, quasi gaddianamente, a caricaturizzare “l’anima vegetativa” della donna, creando figurine stilizzate, donne che sembrano “uscite da un argentiere”, fasciate di seta o di velluto, tutte trine, spacchi, calzamaglia a rete e svolazzi, attrezzate per essere macchine da guerra della seduzione, tanto che una volta, davanti a una donna che, eccitata dalla conversazione, apriva e chiudeva le “ciclopiche cosce” vicino alle fiamme di un caminetto, all’autore sembrò di sentire improvvisamente “un piccolo schiocco di valve per lo scatto di una cerniera” (C2, p.33). In un altro brano lo scrittore si sofferma su un’altra donna che parlando ha il vezzo di intercalare un “cuesta-cuà”, aiutandosi col gesto, trattando “la frittola come consocia e commensale” (C3, p.48). È mirabile, in questa apoteosi dell’apparenza, il piccolo cammeo di una Circe intravista in una pasticceria della Svizzera tedesca:
Cosa fa quella lì nella pasticceria? È amica della padrona, che è una giovane signora elegante di lingua francese, benché qui siamo ancora nella Svizzera tedesca. Anche l’amica è di lingua francese. È confezionata squisitamente, il maglioncino color arancio dà grazioso risalto ai seni, tutto è seta, lacca, superfici lustre o brunite. La breve gonna contiene appena le cosce, il sedere è alla vigliacca. Ora si siede, e presenta vivacemente le vedute interne alla pasticceria vuota; accavalla le gambe, le scavalca, muta e rimuta le vedute, come una che fa le prove dei suoi congegni, per diletto. E intanto chiacchiera con la pasticcera. Sono amiche. Hanno l’anima. Sembra incredibile (C1, p.68).
Simulacri di donna. Tutto, in questa serie volutamente estranea a ogni ridicola e ingessata correttezza politica, è baudelairianamente mirabile artificio, trucco, femminilità posticce quanto calamitanti, un po’ maschere da indossare e sbaraccare a piacimento, un po’ donne vampiro, femmine determinate ciecamente alla conquista:
Una di queste si chiamava Abigail e aveva il viso tutto ricucito, ma era considerata (molto a ragione) avvenente e procace. Ritmo, postura, allure. Abigail gettava la sua femminilità di qua e di là, sia in chiave corporea che intellettuale; la agitava, la faceva passare e ripassare davanti al muso della gente, come l’espada col toro. Dietro lo straccio rosso si indovinava lo spadino. Toreava col Capo del suo reparto, ricciuto, prestigioso, irritabile, che vedevamo scalpicciare nervosamente in corridoio come un torello nell’arena. Lei gli volteggiava attorno, lui dava qualche obliqua cornata all’aria. Lo spadino non sortì mai dal suo astuccio di panno, finché in una notte memorabile, nel fitto di un party di fine trimestre, il Capo ubriaco cascò per terra, in un circolo di assistenti e laureandi, trascinando lei che gli cadde accanto, e avvinghiati si misero a rotolarsi per terra, e in quell’occasione lei sfoderò più volte lo spadino, senza però dargli la stoccata finale. Poi lei si trasferì in Europa, in una grande capitale, e lì sposò uno sprovveduto nel quale poteva affondare domesticamente la lama a tutte le ore, e in questo modo uscì senza sugo dall’arena, lei che avrebbe potuto ottenere le orecchie e la coda del Capo (C2, pp.125-6).
Sarebbero quasi infinite le citazioni che vorrei e dovrei fare, illustrando categorie e sottocategorie, per evidenziare tutte le occorrenze intertestuali, i riferimenti più o meno occulti, gli amati ipotesti: la Lolita delle bambine maladensi, la Mathilde del Rosso e il nero di Stendhal, le guerriere dei poemi cavallereschi, le donne con le anfore montaliane, la muta che un po’ ricorda la figura di Raffaello e un po’ la protagonista di un noto racconto landolfiano e, per risalire alla fonte primaria, di Dostoevskij, fino a un passo che Meneghello stesso citò a Bergamo, durante una sua conferenza, dalle Confessioni di Rousseau, e precisamente il beffardo congedo di Zulietta: “Zanetto, lascia le Donne, e studia la matematica”. E ancora, è possibile rintracciare l’eco della bassaniana Micol, la Persefone-Kora, la signora dei vetri, una dominatrice dello spartiacque sottile che separa i vivi dai morti. C’è il tema di Lara alla Pasternak. C’è anche Alice del Paese delle meraviglie che quando le dicono che lei è solo il sogno del re leone, dice sorridendo fra le lacrime: “ma io sono vera”. Ci sono le vecchissime tre Grazie maladensi, dette le Vittoriette, in cui si sente un’impronta vagamente palazzeschiana:

Vidi le Vittoriette, erano tre: scendevano da un tratto di costa amabilmente alberato, una di appoggiava a un bastone, alta forse un metro, un’altra aveva in mano alcune viole da portare alla Madonna e aveva un ginocchio malandato: la più loquace era balba, due molto sorde, tutte e tre ridevano dolcemente. Erano a passeggio, passeggiando raccoglievano stecchi e bruscandoli con le mani nodose: la più vecchia novantaquattro, la più piccola ottantasei, l’altra in mezzo. Vittoriette di favola, nutrite di radicchi: la mezzana teneva per mano la maggiore, la maggiore era in sopèi, la minore curava le PR, bona pascua, bona pascua, aguri, aguri… Fatti gli aguri negoziavano i piccoli dirupi parlottando: si capiva poco ma dicevano cose, non chiacchiere, messaggi da specie a specie, australopiteche sorelle (C3, p36).
Ci sono poi i ritratti familiari. La mamma, le nonne, le zie. Che spasso, che sorprese se ci si mette a rintracciare le genealogie, indizi un po’ ovunque. Le zie. Ricostruire gli alberi, con quei rami cadetti. Case semivuote. Matriarcato. Il senso di una asserragliata sopravvivenza. Chiavistelli, catenacci rumorosi e lenti. La zia Aurelia, la zia Nena, in là con gli anni. Incombono i pericoli fuori dalle mura domestiche, piovono i rischi sui loro domestici fortini, sulle loro preghiere.
La zia Aurelia e la zia Nena. Catenacci dappertutto, grandi, lenti, rumorosi. Non vedono mai nessuno. Non escono mai. Mai? mai in strada. Hanno però quello che già ci siamo messi a chiamare il gabinetto esterno. Non escono dal recinto della casa, ma di ciò che accade fuori sanno tutto. Non si crederebbe possibile, ma è così.
Hanno l’aia a mattoni, rialzata come una piccola terrazza; c’è un muro che circonda il cortile, un portone di ferro. Appesa al muro, alta alta, c’è una campanella appartenuta a un antico loro fratello cappellano, morto da decenni. È una campanella di soccorso. Il filo che servirebbe per suonarla entra per una persiana al primo piano, tirabile da una camera. Ma le sorelle non vanno più nelle camere. In ognuna è morto qualcuno. Mezzo secolo fa i parenti stretti hanno smesso di morire. Non ce n’era più.
Quando la zia Aurelia decise di andare a Vicenza a un pelerinaio (era il suo primo viaggio da venti anni) prese un tassì per farsi portare a Monte Berico, ma per strada fecero uno scontro. Così è dunque il mondo? Non è meraviglia che da allora si chiudano in casa coi catenacci. (C I, p. 87)
Spesso questi riferimenti letterari sono parodiati o stravolti o occultati o esibiti come un trofeo di guerra, il che è lo stesso. Diventano miraggi, parabole di una delusa oltranza dello sguardo. Ribaltamenti antigraziosi, poetica dell’eccesso, scoronamento. Incitano il lettore addetto ai lavori a una specie di caccia al modello, a un autentico cherchez la femme fra pagine di romanzo, poesie e elementi figurativi.
In chiusura, vorrei toccare un punto che mi sta a cuore, analizzato mirabilmente da altri studiosi, cioè le forme della citazione e dell’allusione intertestuale, fatti che sono inscritti, come si sa, nel DNA stesso della nostra cultura e che sono particolarmente importanti nel tessuto coltissimo della prosa di Meneghello, reperti meravigliosamente incastonati o mimetizzati, in un continuo giuoco di scambi fra astrazione e concretezza, fra abbassamento e innalzamento, e con sproporzioni calcolate tra l’input e l’esito personale. Un complesso cantiere di “dislivelli e attriti”, come ha scritto Franco Marenco, analizzando la “intertestualità divertente” di Meneghello; un processo di interazione volontaria e involontaria che Silvio Ramat ha analizzato in chiave di svelamento degli “idoli fasulli” della poesia del Novecento italiano (Cfr. F. Marenco, Intertestualità divertente, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, a cura di Giuseppe Barbieri e Francesca Caputo, Terra Ferma, Vicenza 2005, pp.45-50; S. Ramat, Luigi Meneghello e la memoria dei poeti italiani, ivi, pp.51-72).
Nella ritrattistica femminile, i rimandi alla grande letteratura occidentale di tutti i tempi sono infiniti. Da Saba a Montale, da Shakespeare ai classici greci, da D’Annunzio a Stendhal, da Piovene a Soldati, a Baudelaire, solo per ricordarne alcuni. I più facili. Per non parlare dei numerosi riferimenti cinematografici, dove compaiono Marilyn Monroe e Claudia Cardinale, le dive del muto, Greta Garbo e Mata Hari. Forse occorre almeno dire che il movimento non è quasi mai quello dell’incarnazione del reperto erudito nella realtà, ma piuttosto quello inverso, che va dalla vita all’arte, cioè il riconoscimento nella realtà di archetipi immortalati nell’arte, magari misteriosamente migrati in uno dei Sarcofaghi montaliani o nella poesia A mia moglie di Saba, e da lì ritornati nelle cose della vita. Trasmigrazioni delle immagini. Fenomeni che rimandano alla grande lezione di Aby Warburg, così importante per la formazione del giovane Gigi in Inghilterra. Le Naiadi accanto al fiume, la mondanizzazione di antiche divinità, il fascino dell’arcaico, il mistero inquietante delle ninfe, le Nereidi oceanine. Donne-dee che guardano altrove. Un misto di familiarità e di straniamento. Ninfe che da antichissimi sarcofaghi arrivano attraverso Raffaello al Giudizio di Paride e alla Tempesta del Giorgione, sfiorano la Olympia di Manet, approdano alle bagnanti nell’acqua nera del Tamigi di Meneghello. Cito un solo frammento, potente e inquietante, dedicato alle Ninfe del Tamigi:
Immagini di un bagno nel Tamigi a tarda notte, dalla riva macchiata di riflessi amaranto. I ragazzi e le ragazze si spogliavano sulla riva, balenano le reni poderose di Deborah in un tuffo veemente, un guizzo nell’acqua nera: e non si doveva berne, fiume inquinato, percolo di morte. Deborah segò di forza la corrente, in un giro di mulinelli luccicanti, fino a metà del fiume: poi lontana, potente, biancastra, si voltò per tornare… Anch’io feci il mio tuffo, legnoso, nell’acqua fredda, velenosa. Nuda sulla sponda l’altra Debby, sempre incline a piangere, piangeva come un vitello, e il giovanotto Tony arrancava timidamente a ranocchio tra il fango sotto la riva (C3, p.384).
Fantasmata interiori e insieme profondamente storici al limite fra il corporeo e l’incorporeo. Trasposizione in abiti moderni delle immagini antiche, tracce di musei dell’immaginario dove si attua la frattura (continuamente suturata da una invisibile dialettica ricomposizione) fra la pratica mitico-religiosa e il puro segno, l’individuale e l’impersonale, il molteplice e l’unico, il sensibile e l’intelligibile. Meneghello sa che le immagini trasmesse dalla memoria storica non sono inerti bensì dotate di vita postuma, sempre pronte a rimettere in movimento il passato. Il miracolo, che il comparatista ama indagare, dell’ancora una volta.
Mi sono divertita soprattutto a rintracciare gli ipotesti iconografici, con risultati talvolta sorprendenti, nella contaminazione delle fonti, nella funzione cardine di testi e immagini di mediazione. Faccio due soli esempi esplicitati dall’autore stesso, e con queste immagini finisco. C’è la tabaccaia di Piazza Spalato a Padova, detta “la tabaccaia dello schermo”, di cui erano prigionieri i sensi del giovane Gigi perché somigliava alla Sibilla Delfica della Cappella Sistina: “aveva gli stessi occhi, la bocca, la bellezza eroica del viso…”. C’è poi la Simonetta dei Piccoli maestri e di Bau-séte!, col monile a forma di serpente nero al collo, con riferimento alla Simonetta Vespucci di Piero di Cosimo, che ritorna in un minuscolo, compressissimo frammento del primo volume della Carte:
Serpenti in Tanganica; meravigliosa cosa, e argomento. Uno dei più velenosi è la Gaboon viper, tarchiata, robusta. Ha veleno per dieci uomini: coccola! […] C’è un uomo in Tanganica che cattura vari tipi di bestie, ma si specializza nei serpi velenosi. […] “Mi sentivo come a casa” dice la donna che è stata in visita all’uomo dei serpenti. Squilibrata anche lei. Il serparo le ha confessato che vorrebbe morire beccato da una serpe. “Serpe”: davvero un tema, o solo una notion? C’è il creep, il serpere; c’è il veleno e il pericolo; c’è la faccenda del Paradiso terrestre; c’è la Simonetta di Piero di Cosimo, col serpe nero al collo. Nulla insomma (C1, pp.95-6).
Nota di lettura
Le citazioni sono tratte da Luigi Meneghello, Opere, Vol. 1, a cura di Francesca Caputo e con Prefazione di Cesare Segre; e vol. 2 con prefazione di Pier Vincenzo Mengaldo (Rizzoli, Milano 1997): Quelle tratte dal vol. 1 compariranno le seguenti sigle: LNM per Libera nos a malo; PP per Pomo pèro; MM per Maredè, Maredè…; IT per Il Tremaio; AM per L’Acqua di Malo; LS per Leda e la schioppa; quelle dal Vol.2, saranno segnalate dalle seguenti sigle: PM per I piccoli maestri; FI, per I Fiori italiani; BS per Bau-sète!. Nei casi in cui si citi dalla recente edizione delle Opere scelte (progetto editoriale e Introduzione di Giulio Lepschy, a cura di Francesca Caputo, con uno scritto di Domenico Starnone, Mondadori, Milano 2006) si userà la sigla OS, col numero delle pagine. Altri riferimenti sono da: L. Meneghello, Le Carte, Vol.I, Rizzoli, Milano 1999, pp.304-6. D’ora in avanti nel testo con la sigla C1, seguita dal numero delle pagine. Per gli altri due volumi delle Carte si sono usate rispettivamente le sigle di C2 e C3.
Leggi anche:
Meneghello, apprendista italiano | Alberto Volpi
Amaluàmen | Manlio Brusatin