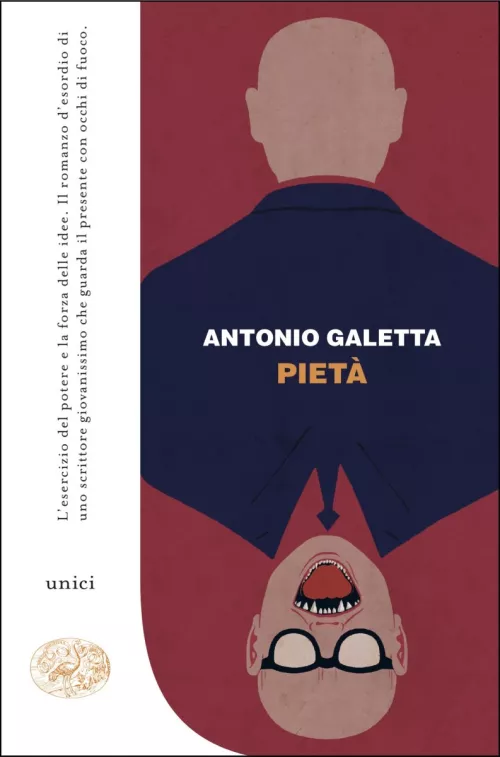Il paese del Noi e del Voi
Bisogna immaginare una piazza, un luogo abbastanza aperto che abbia vie di fuga e al centro uno spazio facilmente visibile da tutti i punti di osservazione; ce ne sono molte in città, ce n’è una o poco di più in un paese di provincia; molto spesso c’è un bar, più spesso ancora c’è una chiesa, di certo c’è tanta gente che vi si dà appuntamento, che la raggiunge e la percorre come viatico per molte altre direzioni o infine come punto d’arrivo della propria socialità. Già luogo principale nell’antichità, nell’epoca moderna questa etimologica referenza al raduno, alla raccolta di persone, si carica di una funzione ulteriore: in piazza ci si mostra, si va per manifestare la propria presenza al prossimo, fare cioè in modo che le altre e gli altri decodifichino lo stato di benessere del proprio nucleo umano – familiare e non – a partire da questa particolare silente ispezione di confronto tra sé e l’altro da sé, a partire dal presupposto che al sé somigli oppure no. E allora bisogna supporre di conoscere una piazza, non una qualsiasi, ma quella del piccolo paese in cui prende vita questa fulminante opera prima del pugliese Antonio Galetta, Pietà, da poco pubblicata per la casa editrice Einaudi; attorno a questo luogo ruota una vicenda che proprio dalla piazza, dall’uso che se ne fa o farà, non può prescindere. Tutte e tutti prima o poi la attraversano ed è lì che finiranno in una delle scene cardinali della storia, come se essa – la piazza appunto – fosse non un luogo ma un nucleo vivente di vita propria e giudicante al cospetto della comunità.
Il punto di partenza della narrazione emerge dal centro nevralgico di una vita di provincia: la campagna elettorale che condurrà alle prossime elezioni comunali, convocate dopo l’inchiesta che ha portato l’ex sindaco a dimettersi e lasciare quindi il campo a un nuovo – ? – potere: d’obbligo, è l’interrogativo, perché proprio questa domanda sarà al centro delle proposte, tra chi cerca di distaccarsi dalla politica corrotta e stantia restando nell’alveo delle tradizionali coalizioni di maggioranza e chi cerca di farlo segnando una differenza in termini sia ideologici che strutturali, dando vita a movimenti venuti dal nulla e finendo però a rimestare in una simile logica di promesse e spartizioni.
È davvero così impossibile districarsi da un simile groviglio di voti di scambio, poltrone e benefici? Galetta affronta un romanzo politico che non disprezza elementi allegorici; la sua è una narrazione grave, le parole hanno un evidente peso specifico e il narratore sa dosare tale peso, si avverte continuamente la sua voce come una presenza ineludibile che sembra accerchiare il lettore, perché non provi mai a disfarsi dei fatti e delle occorrenze intercorse tra di essi. Questa precisa intenzione, fieramente spavalda, inquadra il Paese, quello con la P maiuscola, in un clima di eterno presente elettorale, in cui la politica è ovunque, permea ogni discorso e ogni sguardo, ogni incontro avvenuto e anche quelli che non avvengono per precisi motivi, una partitura di azioni in una sequenza preordinata che mette in luce la particolare uniformità della vita di provincia, là dove parentela e amicizia affondano dentro una rete fitta in cui ognuno è ragno dell’altro, seguendo uno schema divisivo come quello elettorale che esplode in una acredine sotterranea e livorosa di sospetto e tradimento.
In questa narrazione alternata, le cui scene si percepiscono coeve nel tempo, lungo piani giustapposti appena combacianti per un bordo – che è confine e passaggio osmotico da una scena all’altra –, i personaggi che rappresentano le forze politiche, che fluttuano tra i discorsi, non hanno nome proprio, vengono riconosciuti sulla base della funzione che svolgono nella piccola società: l’assicuratore che cerca di raccogliere voti in territori prima sconosciuti, la bambina, sua figlia, che vorrebbe capire suo padre e intanto osserva l’infanzia lasciare il passo a un futuro confuso tra fuga o permanenza, il parlaparla che dal suo scranno di tabaccheria ospita ogni volantino con la stessa condiscendenza, la figlia della barista che torna dalla grande città per votare, che vorrebbe cambiare qualcosa almeno attorno a sé, poi altri, tanti, tenuti su da un filo che lega senza farsi visibile. Il popolo è, dunque, un magma distinto appena, emergono figure non per qualità o informazioni anagrafiche ma per il ruolo che occupano nel gruppo umano di riferimento o, meglio, nel bacino elettorale cui appartengono; nessuna descrizione fisica, solo le azioni che svolgono, verso sé stessi o verso gli altri, come se fossero elementi metaforici, ingranaggi di un meccanismo che grazie a loro si muove e, mentre si muove, li schiaccia.

C’è un elemento che rende ancor più limpido questo processo di rappresentazione: il racconto è affidato a una prima persona plurale che osserva e delimita il raggio d’azione dei personaggi i quali, mentre la storia si sposta altrove, finiscono in un cono d’ombra, diventano “uno/una/alcuni di noi” secondo il punto di osservazione, si smembrano ancor più in una nebulosa; questa dispersione dell’opinione in un Noi onnisciente, il cui anonimato corre il rischio di essere disorientante, ha termini sia positivi – un’evocazione della collettività rimossa dall’individualismo sfrenato – sia negativi – massa informe, capace di muoversi ciecamente per mezzo di una forza che non accetta barriere, ma soprattutto sviluppa il discorso politico attraverso questa forza collettiva apparente, proprio mentre la nega e la sconfessa.
Il Paese del Noi e del Voi, basculanti fino a estendersi in un inarrivabile Loro, si scompone e si ricompone come fossero tutte e tutti davanti a un Tangram da completare, il “gioco della saggezza”, i cui pezzi di forme diverse hanno un solo modo di comporre la figura ultima, e nessuno è abbastanza saggio da capire quale. Nel mezzo è la retorica, ognuno seguirà la propria: “la donna che ci ha traditi” cavalca il dissenso antimigratorio, sta nella disputa elettorale da ago della bilancia e cova un risentimento esplosivo, cerca di conquistare tutti, compreso il “Prete”, con argomentazioni insostenibili, ma il cui magnetismo le rende sorprendentemente plausibili; il “capo della Delegazione” si fa forte di un appoggio nazionale ma si sente predato dalla donna, scavalcato nel suo stesso campo; il “capo del Calderone” attende perché sa che in fondo tutto resterà ciclicamente uguale a sé stesso, pensa già al dopo con la quiete di chi è abituato al potere, finanzia il centro di ricerca scientifica per la figlia, non tanto perché ne capisca o ci creda, ma per antica consuetudine a determinare una meritocrazia sui generis; il “fondatore del movimento Casa Dolce Casa”, tornato in Paese dopo il successo di una invenzione divenuta milionaria ma di cui poco ha goduto, vorrebbe far saltare il banco e colpire parlando di legame con la terra di appartenenza, crea consenso negli interstizi del consenso preesistente, si allea con la figlia di una macchina da voti (una “Cartucciera”) e finisce per amarla, non sa cosa desidera lui per primo e parla per tutti i figli di questo Paese non ancora nati, e di nessuno di essi conosce veramente il nome. Ogni frase crea una nuvola vuota attorno ai personaggi che le pronunciano e a quelli che le ascoltano, ogni frase sarà frutto di quella invincibile qualità enfatica che ribalta le resistenze anche della più coriacea rettitudine.
Galetta non concede punti di riferimento, ma ripaga questa fatica con una solida coerenza di linguaggio; ne nasce un romanzo limpido e raffinato come fosse un’opera non giovanile ma già matura, in cui scorre la linfa di narratori solidi come Jonathan Franzen o Ian McEwan, attingendo alla provincia preurbana di Paolo Volponi o quella viscerale di Luigi Meneghello, fino a raccogliere il testimone di un conterraneo come Nicola Lagioia, il cui sguardo narrativo espanso sul micromondo locale – si pensi ai romanzi Riportando tutto a casa e il premiato La ferocia – ricorre nella scrittura di Galetta come una traccia viva in un corpo moribondo, un rivolo di torrente in una terra arsa.
Si conclude, il viaggio del romanzo, proprio nella piazza in cui Noi, pur tutti presenti, non ci siamo mai incontrati, ai bordi dell’ultimo comizio attorno a cui ci si trova chiedersi: c’è, per qualcuno, redenzione? Risposta non c’è, ma qualcosa di inesorabile si avverte nell’aria, qualcosa che forse è già avvenuto ma che la narrazione rende di nuovo attuale, di nuovo reale oltre il reale, fino a confonderci, chiudendo il libro, nel dubbio di quella frase che rese celebre Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” oppure “Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com’è”. Nessuno, né di Noi né di Loro, ricorda come fosse veramente.