Quale Sardegna?
Il pranzo a base di piatti tipici della cucina barbaricina, preparati dai pastori di Orgosolo, che le agenzie di viaggi vendono regolarmente ai turisti per un’immersione esperienziale nella “Sardegna più autentica”; la folla cosmopolita che segue “Time in Jazz”, il festival organizzato da Paolo Fresu che ogni estate, dal 1988, raccoglie a Berchidda, un piccolo paese della Gallura, il meglio della musica afroamericana, tra performance di star internazionali e percorsi di sperimentazione. Due situazioni apparentemente molto lontane, che però qualcosa in comune ce l’hanno. Entrambe producono reddito, ricchezza. Entrambe inseriscono stabilmente due piccoli centri, Orgosolo e Berchidda, fino a ieri soltanto terre di pastori e di contadini, nel circuito del turismo, settore che per l’isola, dopo la crisi ormai irreversibile dei grandi poli industriali nati con il sostegno statale negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e dopo il declino delle produzioni legate al mondo agro-pastorale, rappresenta economicamente il futuro.
A dare un’idea delle dimensioni, un report del Centro internazionale di studi sull'economia turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, realizzato nel 2017 prima del gelo pandemico, informa che a fronte di un budget di 500.000 euro impiegato per organizzare “Time in Jazz” l’indotto economico per ogni euro speso è di quindici euro lordi, di cui sette netti. Significa che il festival porta nelle tasche dei cittadini di Berchidda tre milioni e mezzo di euro per ogni edizione. Ma c’è un’altra cosa che i pranzi dei pastori insieme con i turisti nel cuore della Barbagia e la ribalta jazz in Gallura hanno in comune.
Entrambe le esperienze mettono in gioco elementi tipici di contesti unici rispetto a tutto ciò che non è Sardegna: nel caso di Orgosolo il mondo agropastorale con le sue peculiarità in termini di codici culturali; nel caso di Berchidda, festival diffuso su un territorio che ormai coincide con quasi tutto il Nord Sardegna, il paesaggio e la particolarità dei contesti storici ad esso collegati, compresi borghi e siti archeologici. Entrambe le esperienze, quindi, valorizzano economicamente un’identità.
Tanti altri casi come quelli di Orgosolo e di Berchidda (che però, come vedremo, per altri aspetti si differenzia molto rispetto al pattern barbaricino) hanno segnato e segnano la storia più recente della Sardegna. Il libro curato da Paolo Dal Molin Creazioni identitarie. Arte, cinema e musica in Sardegna, dal secondo dopoguerra a oggi (Il Maestrale, 2022, 559 pagine, 25 euro) li mette insieme e li analizza usando gli strumenti del pensiero antropologico, della sociologia, della semiologia e della ricerca storica, con in più un corredo di testimonianze dirette, raccolte per lo più in interviste con cineasti, musicisti, artisti, operatori culturali protagonisti dell’attuale scena creativa sarda. Va subito detto che il volume supera di molto le ragioni strettamente legate ai confini regionali. Mettendo al centro, infatti, l’analisi del rapporto tra peculiarità culturali locali e processi più generali attraverso i quali passa la definizione di ogni specifica connotazione identitaria, il libro problematizza il concetto stesso di identità, la sua rilevanza analitica e il suo statuto epistemologico.
Identità, si sa, è una parola da prendere con le pinze. Ce lo ricorda, da antropologo, Gino Satta in uno dei saggi di apertura del volume, “Elaborazioni mitiche e politiche patrimoniali”. Nel 2001 Satta ha pubblicato un libro, Turisti a Orgosolo, in cui il pranzo insieme con i pastori barbaricini a base di maialetto arrosto e di formaggio pecorino che le agenzie turistiche vendono di default ai vacanzieri bergamaschi viene descritto come un “teatro etnografico”, una fiction insomma, in cui i turisti pensano di venire a contatto con “la Sardegna più autentica” (così trovano scritto nei depliant) e invece restano presi in un artificio scenico, in un’illusione. Davanti ai loro occhi viene rappresentata una narrazione fondata su un’immaginazione storiografica (l’isola dei nuraghi, dei pastori e dei banditi) che nulla ha a che fare con l’effettiva realtà contemporanea dell’isola; esattamente l’opposto, quindi, di ciò che viene promesso dai tour operator. “L’immaginazione storiografica che ho analizzato in Turisti a Orgosolo – scrive Satta – produce una lettura essenzialista della storia e della cultura sarda, molto selettiva ed escludente, che marginalizza la gran maggioranza dei sardi, assai lontani dalle icone identitarie, schiaccia l’intera storia sarda su una preistoria molto poco nota e anche per questo disponibile alle più fantasiose e inverosimili invenzioni, restringe abusivamente il significato di sardo facendolo aderire a immagini (orientaliste o spesso auto-orientaliste) fisse e stereotipe”.
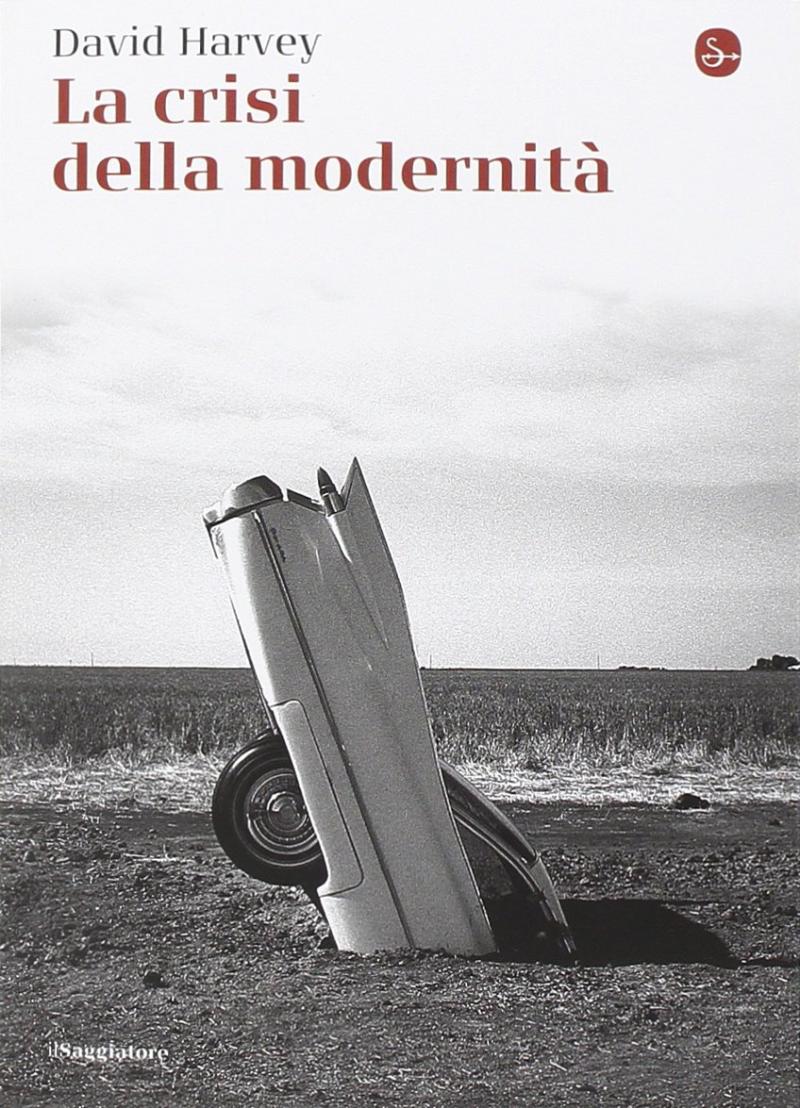
Tutto perfettamente funzionale, rileva ancora Satta richiamando le analisi di David Harvey in La crisi della modernità (Il Saggiatore 2012), alle logiche di accumulazione flessibile del capitale: un adattamento che conferma il dominio del fuori sul dentro, i codici fondativi dell’ordine globale che usano strumentalmente, e di fatto negano, il soggetto identitario. Sono gli squilibri di potere segnalati, sempre in apertura del volume, da Franciscu Sedda nel saggio “Dal trauma alla tradizione”, e che mai possono essere trascurati quando si parla di identità. È sempre dentro la cornice definita da quegli squilibri, infatti, che si gioca la partita. In un mondo in cui è diventata un concetto largamente impiegato e molto attrattivo, l’identità è anche esposta al rischio di utilizzi regressivi.
Quando promette ciò che non esiste, quando – come rileva, richiamato da Satta, Francesco Remotti nel suo L’ossessione identitaria (Laterza 2010) – fa passare per reale ciò che invece è una finzione o al massimo un’aspirazione, l’identità si riduce a inganno (spesso un autoinganno). Ma può anche accadere che al dialogo con l’altro da sé, allo scambio, all’integrazione e al mutamento il soggetto identitario opponga, in modo coercitivo ed escludente, la presunta purezza di un’essenza intangibile (religiosa, nazionale, ideologica).
Dell’inganno e dell’autoinganno riferiti alla Sardegna, già s’è detto: nell’isola la patrimonializzazione dell’identità, la riduzione dei beni culturali (materiali e immateriali) a merce da vendere ai turisti, segna pesantemente il quadro della contemporaneità. I danni ci sono, è evidente, e anche gravi, ma sono molto minori di quelli che si verificherebbero se a questo passo seguisse l’altro: la chiusura in un’essenza identitaria blindata ed escludente. Questo in Sardegna non accade. Il libro curato da Paolo Dal Molin mostra come, considerando ciò che si muove oggi nel campo delle arti, del cinema e della musica, l’isola si collochi molto più vicino al polo dell’apertura che a quello della chiusura.
Lo rilevano, per il cinema, i saggi di Antioco Floris e di Maria Bonaria Urban, che nei lavori di registi come Salvatore Mereu, Giovanni Columbu, Giovanni Coda, Bonifacio Angius e Mario Piredda individuano una tensione costante tra elementi identitari (storie, paesaggio, uso della lingua sarda) e temi universali. “La produzione del cinema sardo contemporaneo – scrive Maria Bonaria Urban – dimostra l’avvenuto abbandono di ogni prospettiva esotica. Il contributo più importate degli autori di oggi è quello di avere ricollocato l’isola nel flusso della storia, rifiutando la nostalgia per una presunta età mitica e riscoprendo nel quotidiano, popolato da personaggi reali e credibili, un terreno fertile da cui partire per raccontare storie dal respiro universale”.
Lo stesso respiro largo (identità che si apre all’alterità) anima – lo ricorda il saggio firmato da Giuliana Altea – il lavoro dei due artisti più importanti che la Sardegna ha espresso nell’arco di tempo (dal secondo dopoguerra a oggi) preso in esame da Creazioni identitarie: Costantino Nivola e Maria Lai. Di Nivola, planato dalla Barbagia a New York e presenza rilevante sulla scena artistica internazionale del secondo Novecento, è noto e studiato da tempo il rapporto strettissimo tra radici mediterranee e ricerca d’avanguardia.
Di Maria Lai e del suo rifarsi alla dimensione artigianale della creazione artistica in un’opera innervata da un forte anelito metafisico e dall’attenzione costante alla multiforme presenza dell’essere nel tempo, Altea scrive: “Maria Lai punta a trascendere tanto l’identità di genere quanto quella etnica. Anche negli anni Novanta, momento della piena maturità dell’artista che coincide con l’affermarsi su scala mondiale delle molteplici varianti dell’identity politics, Lai si terrà a distanza da ogni proposizione identitaria suscettibile di ancorare il suo lavoro a specificità che avverte come limitanti, respingendo l’associazione con il femminismo da un lato e con le ideologie regionaliste dall’altro”.
Ma anche nel campo della musica è netto e preciso il percorso che in Sardegna è stato compiuto nell’arco di un settantennio. All’inizio il predominio della ricerca etnomusicologica intorno alle forme della tradizione (canto a chitarra e canto a tenore in primis); in un secondo tempo i tentativi di rianimare il passato in chiave regressiva (riduzione alle regole della fruizione mediatica attraverso i canali dell’industria culturale); oggi esperienze molteplici di contaminazione, aperte alle influenze di culture musicali altre. Quest’ultimo esito è evidente sia sul versante della cosiddetta musica colta (si veda il saggio di Paolo Dal Molin sulla convergenza tra colto e popolare nelle opere di un importante compositore contemporaneo come Franco Oppo) sia nella storia che Clementina Casula delinea dell’innesto, del radicamento e della fioritura della musica jazz in Sardegna, con tre festival – “Time in Jazz”, “Ai confini tra Sardegna e Jazz” e “Musica sulle Bocche” – che sin dagli anni Ottanta del secolo scorso propongono un dialogo intenso e fruttuoso fra suoni e canti della tradizione sarda e ricerca musicale, in un intreccio raro tra successo di pubblico e pratiche di produzione e di sperimentazione riconosciute a livello internazionale.
Sembra quindi superata, nella Sardegna contemporanea, la contrapposizione tra antitradizionalisti e tradizionalisti richiamata nel suo saggio da Franciscu Sedda: “Se gli antitradizionalisti spingevano verso l’omologazione nei confronti delle culture esterne (in qualunque senso questo esterno lo si volesse intendere) i tradizionalisti producevano i prodromi dell’imbalsamazione della cultura interna (talmente interna da essere sempre più confinata a specifiche zone della Sardegna o a specifici momenti dei vissuti dei singoli)”.
Oggi l’orizzonte è aperto. In uno dei suoi meravigliosi “libri cuciti”, Il Dio distratto, Maria Lai racconta che furono le janas (nella tradizionale mitologia sarda fate bisbetiche ma in fondo benevole) a insegnare alle donne, ai primordi del mondo, come intrecciare i fili nei telai. Nacque così la tessitura, arte femminile dell’intreccio. Di orditi di senso differenti, composti, sconciati, di nuovo in altre trame ricomposti, sono fatte – ci ricorda Maria Lai con il suo racconto – le vite degli esseri umani. Oltre il mito, oltre ogni visione essenzialista, l’unica identità possibile è nell’intreccio che annoda, ma anche mischia, contamina.









