Romance senza categorie
Ormai al termine di un lungo dibattito, che si può far risalire almeno al trattato cinquecentesco I romanzi, in cui Giovan Battista Pigna stabiliva alcune delle caratteristiche chiave del nuovo genere a partire dall’Orlando Furioso, fu Walter Scott a risolvere una controversia che si era fatta aggrovigliata intorno alla contrapposizione tra romance e novel. Fu la pubblicazione di Emma, nel 1815, a offrirgli l’occasione per tornare sulla vexata questio che aveva infiammato il panorama letterario inglese nei decenni precedenti, accentuando la polarizzazione tra racconti eroici e avventurosi di vicende eccezionali da un lato, e racconti verisimili di fatti privati e di contenuto ordinario dall’altro.
Così, se il romance rispondeva secondo Scott alle aspettative di un lettore che «expected a course of adventures of a nature more interesting and extraordinary than those which occur in his own life», il novel era «art of copying from nature […] and presenting to the reader, instead of the splendid scenes of an imaginary world, a correct and striking representation of that which is daily taking place around him» (W. Scott, Emma, a Novel by the Author of Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, & c., in «The Quarterly Review», october 1815). A una narrazione fondata sulla meraviglia e l’esemplarità delle emozioni, si opponeva dunque una narrazione capace di farsi strumento di riconoscimento e di riflessione sul reale.
Eppure la categorizzazione era ab origine problematica: dove collocare per esempio la famosissima Princesse de Clèves? E la Delphine di Mme de Staël? Entrambi spingevano il pedale dell’emozione, delle avventure del cuore, e insieme si presentavano come narrazione di vite private. Lo stesso poteva dirsi di Pamela, Moll Flanders, Tom Jones (che, secondo Guido Mazzoni, rappresenta insieme il culmine della tradizione del romance e il suo superamento verso il novel). Che dire infine dei romanzi di Jane Austen? O più ancora di quelli di Dickens e di Stendhal?
Se spostiamo l’attenzione sull’attuale panorama italiano, ci accorgiamo che – volendo essere radicali – non sarebbe illegittimo classificare la Storia naturale dei giganti di Ermanno Cavazzoni come romance, e al contrario riconoscere nei libri di Elena Ferrante un esempio di quelle narrazioni che, a partire da un contesto ordinario, mettono in scena attraverso uno statuto di realtà quei “nomi propri” che secondo Ian Watt sono il fondamento del novel. Come ha recentemente osservato Giulia Caminito (Le donne non sanno scrivere d’altro che d’amore, per fortuna), stando a queste tipologie, persino Il Colibrì di Sandro Veronesi diverrebbe puro romance.
Basterebbe forse questo per arginare certi usi disinvolti che vengono troppo spesso riproposti della categoria del romance rispetto a quella del novel. E a farci venire qualche dubbio rispetto all’utilità e all’efficacia delle tassonomie – soprattutto se queste arrivano a stabilire una corrispondenza biunivoca tra identità di genere, tipologia e valore della scrittura. Oggi, poi, dopo il profondo rimescolamento dei generi avviato con la stagione postmoderna, quella polarizzazione tipica di un secolo e di una classe sociale che non trovano alcun corrispettivo attuale sembra davvero fuori tempo e fuori fuoco. Come rilevava già Debenedetti, la storia della letteratura contemporanea non può essere spiegata come «un succedersi di imperi»: il romanzo è per natura un genere «anfibio» compiutamente rappresentato da quel passo di Anna Karenina in cui Levin, rifiutato da Kitty, torna avvilito in campagna e scopre «come una rivelazione inattesa e nuova» la benignità della natura, «e ritrova così la proprio concordia col mondo». Vicissitudine amorosa e slancio conoscitivo vengono non solo a coincidere, ma anche a rappresentare una delle ragioni costitutive della vitalità della forma romanzo, del suo essere intimamente connesso con l’assenza di purezza e di trasparenza, con il riuso di scarti, residui, scorie, con tutto ciò che Federico Bertoni ha definito il «grande magazzino del ciarpame romantico».
Perché, dunque, categorizzare? Forse questo bisogno, come quello della periodizzazione, è più una necessità emotiva che conoscitiva, connessa a quella radicale incertezza, o debolezza, che ciascuno di noi – condannato all’immanenza, alla visione periferica, al desiderio frustrato di dare un senso e un fine alla storia – coltiva. Pressati «tra il tic e il toc», di un mondo dai ritmi sempre più accelerati, lettori e critici sono spinti a semplificare un panorama letterario reso ingovernabile sia dalle dimensioni (180 titoli al giorno!) sia dalla sovrapposizione al discorso letterario di altre logiche (editoriali e non solo) che lo opacizzano. Sfrangiato e magmatico, questo panorama è naturalmente in fieri, ma negli ultimi vent’anni si è fatto via via più intricato: che cosa accomuna per esempio i lavori di Trevisan, Janeczek, Stassi, Pugno, Pecoraro, Tobagi, Trevi, Falco o Di Pietrantonio? Che cosa eventualmente distingue ciascuno di essi da Albinati, Colagrande, Terranova, Tarabbia, Petri, Sarchi o Piperno? I rendiconti offerti negli ultimi anni da Gianluigi Simonetti, da Raffaele Donnarumma e da Emanuele Zinato sono, da questo punto di vista, indispensabili strumenti di lavoro.
In un certo senso, l’unica cosa che sembra rendere plausibile l’applicazione coerente dell’etichetta “romanzo” (ormai ridotto a categoria merceologica, secondo il giudizio di Alfonso Berardinelli) alle migliaia di titoli annualmente pubblicati in Italia, è il suo essere un’olla podrida in cui discorso di trama, peripezia, vicissitudine, riflessione metanarrativa, ricerca formale hanno spazi diversi ma si muovono alla ricerca di un convincente e miracoloso equilibrio, resistendo a quel «falsetto estetizzante, disumano, pigramente ricorsivo» che è – nelle parole di Giorgio Ficara – il vero discrimine tra un libro bello e uno meno bello, ben al di là di un ipotetico e inconsistente confine tra letteratura d’amore (femminile?) e letteratura di impegno (maschile?).
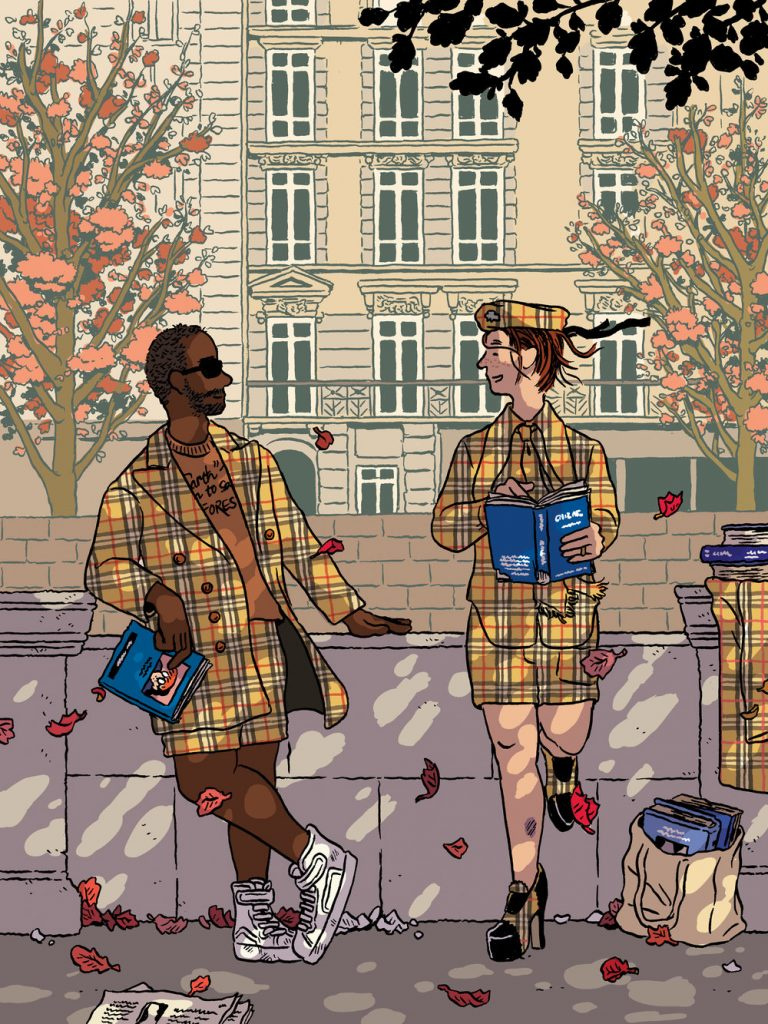
Tuttavia, se nonostante tutto si volesse tentare una mappatura del presente, si potrebbe ricorrere alla vecchia ipotesi occidentale secondo cui lo stile è il risultato di una mai del tutto raggiunta intesa tra io e mondo, e dunque spostare l’attenzione (da alcune categorie fortemente ideologizzate come “letteratura femminile”, “letteratura popolare”, “letteratura di ricerca”…) verso altri elementi che, a seconda dei casi, mettono in risalto nel rapporto io-mondo gradazioni spettrometriche diverse. Radicalizzando in modo forse eccessivo, il binomio io-mondo assume infatti coloriture diverse a seconda che si sposti l’attenzione sulle persone (l’io o gli altri), sullo spazio e sui tempi a partire dai quali viene articolato. Potremo così avere:
a. scritture dell'io (biofiction, autofiction, biografie...); da Mauro Covacich a Tommaso Giartosio, da Mario Desiati a Emanuele Trevi e Antonio Pascale, dall'ultimo Scarpa, a Veronica Raimo, Andrea Pomella, Claudia Durastanti, Marta Barone. Senza dimenticare il modello primo di tutti: ossia Walter Siti.
b. scritture dell'altro, che possono a loro volta essere di immedesimazione come nel caso di Rosella Postorino, Igiaba Scego, Marco Balzano, o di dislocazione come nelle pagine di Eraldo Affinati o, su versanti molto diversi, di Andrea Tarabbia, Alessandro Piperno, Alessandra Sarchi, Lidia Ravera, Melania Mazzucco o Viola di Grado.
c. scritture di mondi (quelle, un po’ semplificando, portate alla ribalta dal cosiddetto spatial turn), come nei casi di Carmen Pellegrino, Laura Pariani, Francesco Permunian, ma anche di Paolo Cognetti, Laura Imai Messina, Nicola Lagioia, che spesso si intersecano con le scritture di epoche e tempi (Davide Orecchio, Antonio Franchini, Benedetta Tobagi, Hélena Janeczek, Silvia Avallone, Federica Manzon rispondono a vario titolo a questo ampio gruppo).
A questa prima partizione andrebbero poi almeno aggiunte altre due macro-aree:
d. quella delle riscritture (il Pinocchio rivisitato da Fabio Stassi o Il vecchio e il mare da Domenico Starnone, ma anche Sandra Petrignani che riscrive le vite di Marguerite Duras o Natalia Ginzburg, Serena Vitale che ri-racconta Puskin e Majakovski, Paolo Nori che dà voce a Dostoevskij e Anna Achmatova).
e. quella del romanzo-saggio (che volendo potrebbe cannibalizzare tutte le altre categorie, e dove si possono collocare prima di tutti Francesco Pecoraro, Walter Siti, Tommaso Pincio, Vitaliano Trevisan, Vanni Santoni, Simona Vinci, Antonio Scurati, testi in cui la narrazione pura è messa in ombra, complicata, arricchita da altre linee di tensione).
Ma poi, dove collocare Ermanno Cavazzoni? o Michele Mari? o Filippo Tuena? o, per allungare lo sguardo a chi ci ha da poco lasciati, Gianni Celati, Raffaele La Capria, Daniele Del Giudice, Ernesto Ferrero, Pia Pera? Dove collocare cioè tutti questi scrittori e scrittrici che, lavorando più sul come che sul che cosa, finiscono per essere, sia pur in modi diversi, considerati scrittori “in fuga” dal romanzo, estranei e indifferenti a ogni etichetta o status distintivo?
Non dimentichiamo, infine, che il romanzo ha potuto formalizzarsi – anche teoricamente – come genere a partire da quella dottrina del rispecchiamento che Lukács ha derivato dalla Fenomenologia dello spirito, stabilendo un principio etico alla base della scrittura romanzesca; in effetti se per Hegel il meccanismo di Anerkennung era fondamentale in ogni processo di presa di coscienza individuale, poiché consentiva il superamento della dialettica del conflitto in una dinamica intersoggettiva (o polifonica, per richiamare Bachtin), in Lukács esso diventa la chiave di volta per una estetica fondata sul rispecchiamento della realtà. Questo consente a Lukács di affrancare il romanzo sia dal principio di una fantasia creatrice onnipotente e irrelata alla realtà, sia da un piatto naturalismo, per affermare anzi le necessità di uno studio del reale come processo, come azione nel tempo e nello spazio. Per questo la categoria dell’ironia (consustanziale al romanzo fin da Cervantes, Fielding e Diderot) è così importante per una sua lettura in direzione anche etica: è attraverso l’ironia che la vicissitudine romanzesca comincia a riguardarci, è attraverso quello speciale sguardo obliquo, che tende ora alla demistificazione ora alla pietà, che la frattura tra io e prosa del mondo può forse ricomporsi. In quanto discorso di avvicinamento alla realtà, il romanzo mira alla (irraggiungibile?) individuazione di uno spazio in cui la trama dei rapporti dell’universo, eternamente instabili, «sembra fermarsi» (Henri James, Le prefazioni). Trovare la propria voce, uscire dal balbettio della lingua della comunicazione, significa allora rivendicare alla letteratura una tensione etica che, nello sforzo a realizzare il mondo, ferma per un istante i suoi inconsistenti e contraddittori disegni, rendendoli irrevocabili.
Nello spazio tra il contingente e il definitivo (uno spazio minimo eppure incommensurabile) si gioca dunque il successo del romanzo: è lo spazio della trasformazione, del continuum storico che si inceppa, e inceppandosi rivela una ferita o cesura o increspatura grazie alla quale si compie quella vicissitudine che distingue la «polisemia propria del discorso letterario» (Mario Barenghi) dalla semplice comunicazione.
Quando ci barrichiamo nelle tassonomie e nelle parcellizzazioni, diventiamo vittime di una contrapposizione ideologica che ci impedisce di attivare quelle categorie dello spirito indispensabili per demistificare la realtà, ma anche di attivare quelle strategie di riconoscimento dell’altro e di altre forme del reale che stanno alla base di ogni lavoro critico, e ancor prima di ogni lettura. Potrebbe allora essere utile tornare a guardare alla letteratura come formazione di compromesso, secondo il suggerimento di Francesco Orlando, o sottolineare con Celati il suo costituirsi come inesauribile ciclo di ritorno di forme letterarie prima scartate e poi recuperate. Sostituire cioè alla logica oppositiva una logica circolare, fondata sui tempi lunghi anziché sulle istantanee del presente.
L'illustrazione in copertina è di Ilya Milstein.









