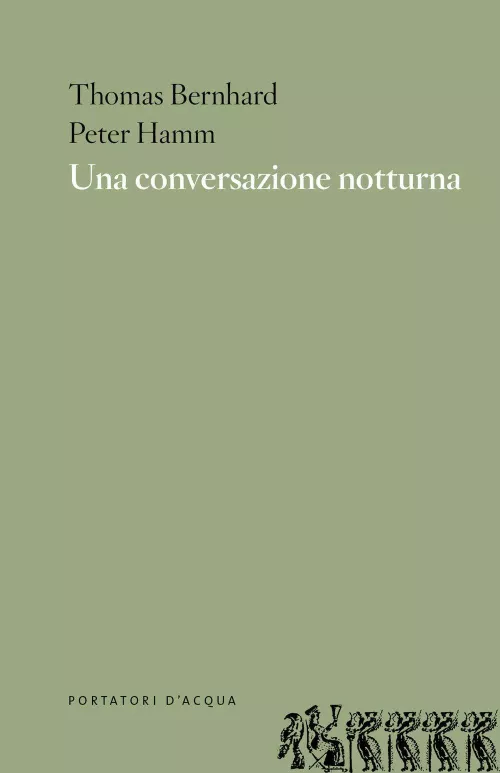Un libro intervista / Thomas Bernhard, Una conversazione notturna
Una conversazione notturna (Portatori d’acqua, 2020) è la trascrizione dell’intervista rilasciata da Thomas Bernhard al critico Peter Hamm nel 1977, dopo una serata trascorsa in una trattoria poco invitante e caratterizzata da un discreto consumo di vino. Ai tempi, dopo averne letta la trascrizione, Bernhard ne aveva impedito la pubblicazione, essendosi reso conto che «ciò che era disposto a dire sulla sua infanzia, sulla sua adolescenza e sul suo apprendistato poetico, non doveva essere diffuso sotto forma di una chiacchierata notturna troppo informale, bensì come testo letterario compiuto», ovvero quell’Autobiografia della quale aveva già pubblicato i primi due volumi. Bernhard d’altronde ha sempre giocato con i confini tra fiction, biografia e autofiction, dissociandosi dalle dichiarazioni dei suoi personaggi ma esprimendosi come loro, alterando alcuni dettagli del proprio vissuto e facendo di tutto per avere l’ultima parola su se stesso. Ed ecco un altro dei motivi per cui si oppose alla diffusione dell’intervista: nonostante lui e Hamm si conoscessero da vent’anni, e fossero legati da un rapporto di reciproca stima, quella sera Hamm non si era dimostrato un interlocutore adeguato.
Bernhard considerava le interviste come una parte integrante della sua opera, una sorta di performance attoriale che doveva riprenderne temi e provocazioni: in tal senso, col suo garbo e la sua sensibilità, la giornalista Krista Fleischmann sarebbe diventata una controparte perfetta, a tal punto che quando la televisione austriaca ipotizzò un ritratto firmato da un noto regista, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, Bernhard si oppose e comunicò ai responsabili: «Lo si deve affidare alla Fleischmann; lei la conosco, se proprio si deve fare, lo faccio solo con lei». Hamm, invece, animato dall’ammirazione ma anche rassicurato da una presunta confidenza, si concede troppo spazio, insiste su alcune domande, dubita delle risposte e, in generale, contrasta la performance di Bernhard più che assecondarla. In realtà, leggendo Una conversazione notturna, pubblicata soltanto nel 2011 con l’approvazione del fratello di Bernhard, è difficile identificare elementi che facciano sfigurare una delle due parti, o che rendano quest’intervista più eccentrica di altre. Manca, certo, quel tipo di simbiosi che Bernhard aveva stabilito con Fleischmann, ma per il resto ci troviamo di fronte a un tassello coerente all’immaginario bernhardiano e fondamentale per comprendere intenti, temi e visioni di uno dei maggiori autori del Novecento. (Mauro Maraschi)
Un motivo ricorrente di tutti i suoi libri lo ha formulato lei stesso: «Tutto è ridicolo se si pensa alla morte». Il che rivela una paura della morte, o no? Oggi pomeriggio lei stesso ha detto: «La paura della morte è un’idiozia».
Al contrario, pensarci è gradevole. Quando qualcuno muore, il suo viso torna a essere com’era in origine, del tutto rilassato. L’uomo, finché vive, è costantemente contratto, e soltanto quando muore si distende. Vive davvero, per la prima volta, soltanto quando è morto, nell’istante in cui non si è ancora irrigidito. È quello, l’uomo.
Sembra un po’ un’arringa in favore del suicidio. Come mai non ha mai scelto per sé questo destino, questa scappatoia?
Non l’ho fatto, e questo è quanto. Di più non saprei dire. Certo, dev’esserci qualcosa di affascinante nel suicidio, altrimenti nessuno lo commetterebbe. È tutto l’insieme, no? Quando uscì il primo romanzo, ma addirittura anche prima, quando uscirono le poesie, la gente diceva: «Vedrai che questo si suicida». Eppure non è successo. E con il prossimo libro diranno: «No, non può andare oltre, vedrai che si suicida». A ogni libro sento dire la stessa cosa.
Con la mia domanda non volevo istigarla al suicidio, quanto riflettere sulla sua evidente attrazione per la morte.
Non sono affatto attratto dalla morte. E la critica che continua a sostenerlo dice sciocchezze. Chi è davvero attratto dalla morte non potrebbe mai scriverne. Così come un folle, se lo è davvero, non può certo scrivere della follia, o no? Il problema è che la gente non ha nessuna idea di cosa sia il teatro. Si può descrivere soltanto ciò di cui si ha un controllo totale, concretamente e mentalmente. Chi è davvero sull’orlo del baratro non può farlo.
Comunque nei suoi libri si ritrova una certa ossessione per la morte. La morte la affascina.
Non posso dire che mi affascini. Affascina i miei personaggi, certo, ma questa è un’altra cosa.
Io conserverò comunque l’impressione che lei sia affascinato dalla morte. Passeggiando e parlando con lei capita spesso che lei accenni a questo o quell’abitante del paese che si è suicidato o sta per morire. E poi si mette a ridere con quel suo riso bernhardiano.
Visto da fuori può sembrare così, ma a dire il vero io non rifletto mai su cosa significhi tutto ciò.
Molte persone interpretano i suoi libri come delle provocazioni. Lei trova divertente la provocazione?
Non lo so. Sono contento che ciò che scrivo colpisca le persone, deve colpirle, ma in che misura, questo non lo so. Io non sono mai rimasto davvero colpito dalla letteratura. Ho guardato alla letteratura sempre e soltanto con interesse, mai con coinvolgimento. Il mio rapporto con la letteratura non è mai andato oltre la soglia dell’interesse. Entusiasmo, al limite, ma soltanto per il modo in cui era stata realizzata. Non ho mai letto una storia in quanto storia, ma piuttosto chiedendomi come avesse fatto l’autore a farla funzionare. Già con le fiabe mi chiedevo perché l’autore avesse collocato i personaggi in quel modo, perché proprio in quel momento la regina indossasse delle pantofole di ferro incandescenti, e così via.
Dunque non la fiaba in sé, la sua essenza o il suo messaggio?
No, no. Ho sempre pensato al modo in cui l’aveva composta l’autore, al perché dei momenti drammatici… Sono sempre stato interessato alla fattura e quasi mai a ciò che viene raccontato, per quanto possa sembrare strano.
Anche quando ha letto L’idiota di Dostoevskij o I fratelli Karamazov era interessato soltanto alla loro fattura?
Sì, proprio questo mi affascinava, la fattura.
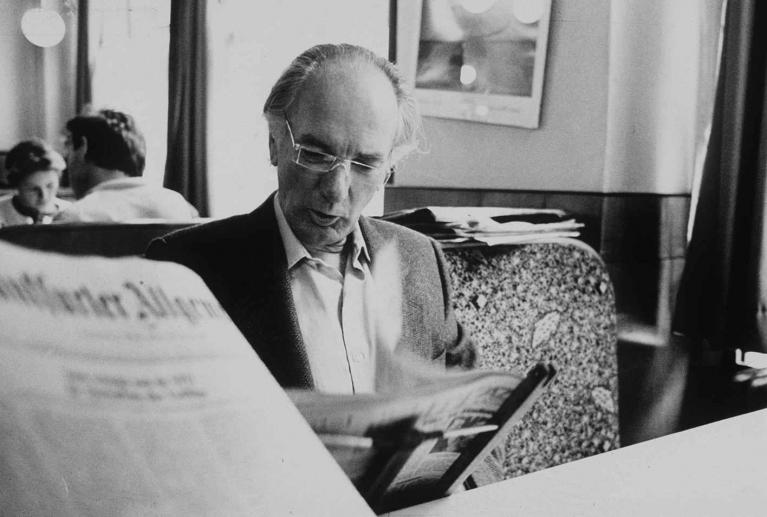
Fatico a crederci.
Io ne sono abbastanza convinto. Non ho mai letto niente in vita mia che mi abbia sconvolto a tal punto da dover andare in giro a parlarne con qualcuno.
So che lo negherà immediatamente, ma tutto ciò significa scindere forma e contenuto, o mi sbaglio? Però forma e contenuto non sono separabili, e poiché la forma non può che essere l’adeguata espressione del contenuto, lei era comunque affascinato anche dal contenuto.
Forse, ma soltanto in seconda battuta. Dipende dal fatto che secondo me è possibile scrivere cinquemila pagine anche su una singola palla di sterco di cavallo, su come è fatta, per l’appunto. Potrei scegliere una lettera, per esempio la «E», e su questa lettera scrivere ottomila pagine, per dire. È una cosa che riesco perfettamente a immaginare di fare. Quel che ne è venuto fuori lo si capirebbe soltanto con il tempo. Le trame non mi hanno mai interessato; mi hanno sempre respinto i libri e le opere teatrali che considerano queste cose più o meno come un fine in sé: non fanno per me.
Ma, al contempo, i suoi libri non sono soltanto virtuosismo, non soltanto pezzi di bravura, ma anche una valvola per liberarsi di una sofferenza opprimente e un baluardo contro la morte. Il suo scrivere è anche uno scrivere per non morire, per mantenersi in vita.
No, probabilmente potrei tenermi in vita anche con qualcos’altro, ma è comunque il modo che mi piace di più, per dirla senza giri di parole.
Ma se qualcuno dicesse: «Questo è puro virtuosismo! È capace di scrivere mille pagine sulla lettera “E”!», lei presumibilmente si sentirebbe offeso.
Offeso non direi.
Contrariato.
Sì, contrariato sì, è vero. Non mi andrebbe bene, certo.
Uno dei problemi principali, per i suoi lettori, è che non possono mai prenderla in parola, perché tutta la sua prosa è una prosa di personaggi. Eppure le vorrei chiedere come vede se stesso in quanto personaggio, come appare lei stesso nei suoi libri.
Tutto ciò che appare nei miei libri sono comunque io, in una qualche forma. Tutti i venti libri che ho scritto finora sono io. E molto intensamente. Tutti.
Ma se lei dovesse scegliere tra due lettori, tra quello che legge un libro di Bernhard dicendo «Mi interessa soltanto com’è fatto» e quello che si sente profondamente colpito non soltanto dal «come» ma anche dal «che cosa»…
In questo caso, quello che vuole sapere com’è fatto mi è più affine, per cui preferirei lui. Anche perché quello che si sente profondamente coinvolto poi vorrebbe coinvolgere anche me, e magari trascinarmi nelle sue disgrazie personali, il che sarebbe una cosa orrenda. Da qui la domanda se sia lecito continuare con il virtuosismo, no?
Secondo me il lettore più coinvolto è proprio quello che può spiegare e apprezzare il modo in cui è stato realizzato un libro. Non c’è una cosa senza l’altra.
Può darsi che sia così, sì. Non ho mai riflettuto su questa cosa.
Le posso chiedere quale dei suoi libri sente più vicino, quello che le è più caro?
Il mio prediletto è Amras. È sempre stata la risposta più spontanea, e penso che sia tuttora valida.
Come mai?
Lì mi è riuscito qualcosa, senza sapere bene come: uno stato fluttuante tra ingenuità, pubertà e, nonostante questo, un altissimo livello di riflessione intellettuale su quella condizione esistenziale, mi spiego? Una specie di funivia in prosa, direi. E questa fune oggi non la vedo più, e vorrei tanto vederla. Amras è sonnambulicamente esatto, credo.
Dunque i suoi libri non sono la prosecuzione dello stesso libro, ma lei li considera singolarmente, distinti gli uni dagli altri?
Sì, certo. Voglio dire, sono sempre gli stessi concetti e lo stesso paesaggio, o la stessa struttura intellettuale, se vogliamo, ma tra tutti Amras mi è più vicino. Qualcosa di simile mi è riuscito di nuovo diversi anni dopo, in Sull’Ortles, qualcosa di analogo, una sospensione simile, appunto. Rimangono i miei preferiti tra le cose che ho scritto.