Che formato ha quest'opera?
Così se mi fa crescere arrivo a prendere la chiave;
e se mi fa rimpicciolire, striscerò sotto la porta
Alice in Wonderland, Lewis Carroll
In seguito a un progetto di recupero e riconversione, l’ex-chiostro cinquecentesco della chiesa di Santa Caterina a Fornello a Napoli è oggi sede della Fondazione Made in Cloister, un centro espositivo e performativo aperto alla città e in dialogo con il quartiere. Abitato temporaneamente da opere site specific di artisti come Laurie Anderson (The Withness of the Body, 2016), Mimmo Paladino (Pane e oro, 2018), Sergio Fermariello (Hear, 2021), quello di Santa Caterina a Fornello si presenta come uno spazio vuoto continuamente riscritto dalla messa in dialogo con grandi opere d’arte contemporanea. Anche Nicola Samorì nel 2020 è stato chiamato a confrontarsi con questo spazio con la sua personale Black Square. L’esposizione dell’artista forlivese si è aperta con Drummer, una scultura mastodontica di oltre cinque metri d’altezza messa in scena nella gabbia lignea al centro del chiostro (fig. 1).

Una figura la cui verticalità mortifera e le cui misure non possono non ricordare gli obelischi partenopei come quello di San Gennaro che svetta al Pio Monte della Misericordia. Così come le guglie dalle grandi volute e capitelli riccamente decorati, la scultura di Samorì è un assemblage in cui si possono riconoscere forme di altri tempi dal formato macro – come quella del treppiedi alla base, ripresa di un candelabro barocco, o come il colosso che svetta sopra di esso, ispirato a una piccola statuetta secentesca di Joachim Henne, Death as a drummer (fig. 2).

Nella sua seducente imponenza l’opera entra in dialogo con il grande quadrato nero su cui è posta, formato da lapilli vulcanici – come anche il colosso – e piccolissime sculture realizzate in grès. Queste, riproduzioni in micro scala di alcune teste esposte nella collezione Villa dei Papiri di Ercolano del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sono a loro volta un chiaro rimando alle vicende dei martiri puteolani e le decollazioni del Forum Vulcani (fig. 3).

Napoli, i suoi abissi oscuri, il regno dei morti e la sua eruttività vulcanica. È questo di cui ci parla l’opera di Samorì in cui il peso della storia e dei simboli della città si intrecciano in una splendida sintesi con il potere dei materiali di cui l’opera è composta. Allo stesso titolo dei materiali, però, è un’altra dimensione che concorre al senso complessivo dell’istallazione. A essere in gioco è il contrappunto tra macro e micro, tra la maestosità del mortifero della statua e la caducità dell’umano che viene riflessa dalle minuscole capuzzelle mescolate con i frammenti lavici del pavimento.
Una dimensione, quella del formato, che si impone allo sguardo dello spettatore e ne rimodula azioni e passioni. È da premesse di questo tipo che prende avvio il volume Semiotica del formato: misure, peso, volume, proporzioni, scala a cura di Tiziana Migliore e Marion Colas-Blaise appena uscito per i tipi di Meltemi nella collana Insegne diretta da Gianfranco Marrone. Un volume collettaneo in cui le voci di semiologi, storici e teorici dell’arte, architetti e curatori si incrociano e offrono al lettore una molteplicità di punti di vista su questo tema di ricerca, finora assai poco esplorato. Nell’ambito di ricerca della disciplina che si occupa dei processi e dei sistemi di significazione, è il saggio di Algirdas Julien Greimas “Semiotica plastica e semiotica figurativa” (1984) a segnare al contempo punto di arrivo e di rilancio di un interesse verso la dimensione del visivo dei fenomeni sociali e culturali.
Un contributo di fondamentale importanza in cui viene evidenziato il possibile funzionamento dei linguaggi visivi, che anticipa sia il Pictorial Turn di W.J.T. Mitchell sia l’Iconic Turn di Gottfried Boehm. Un percorso di ricerca inedito che si poneva all’interno di un orizzonte di semiotica generale, volto all’elaborazione di un metodo di lettura dei testi visivi che non ha mai smesso di progredire. Greimas e i suoi allievi della Scuola di Parigi, infatti, sostennero l’importanza di un approccio analitico al visivo mettendo a punto categorie e modelli per lo studio di quello che viene chiamato piano dell’espressione: il figurativo e il plastico – quest’ultimo contraddistinto per le categorie cromatiche, eidetiche (linee e forme) e topologiche (organizzazione dello spazio planare).
Da una semiotica del visivo, interessata al rapporto tra leggibile e intellegibile, si è poi arrivati alla proposta di una semiotica del visibile interessata agli effetti della testualità non per canali sensoriali singoli ma nella loro dimensione sincretica. Seguendo questa prospettiva, importanti contributi sono poi arrivati anche dal Gruppo μ di Liegi che per lungo tempo ha riflettuto e posto l’accento sull’importanza della testura e dei materiali espressivi degli artefatti. Marginale, almeno fino ad ora, era stata l’attenzione alla dimensione del formato che – come ricordano nell’introduzione Migliore e Colas-Blaise – “non si limita a indicare come è fatta una forma, ma la fa agire a livello comunicativo e retorico con salienze e pregnanze”.
Che siano le macro-sculture di Emilio Isgrò o le micro-figure di Tomaki Suzuki, è possibile delineare possibili effetti di senso che derivano dal cambio di formato, soprattutto per quanto riguarda proporzioni e scala. Se per la prima si può parlare di corrispondenza di misura fra due o più elementi in rapporto reciproco, l’idea di scala permette piuttosto di riflettere sul sistema di rapporti matematici tra un oggetto e le sue rappresentazioni. Riflessioni di questo ordine sono alla base del contributo di Anne Beyaert-Geslin che prende in analisi grandi quadri come La zattera di medusa di Géricault o Il funerale di Ornans di Courbet. L’autrice evidenzia la peculiarità del formato delle opere d’arte in grado di produrre specifici effetti di senso e di introdurre la dimensione fenomenologica dello spettatore, ovvero il ruolo della corporeità dentro e davanti all’immagine. In questi casi il formato della tela, lungi dall’essere un dato accessorio, ricopre piuttosto la funzione di “svelare il segreto più grande della pittura, quello della sua alterità radicale”.
In linea di continuità con queste riflessioni, Tiziana Migliore nel suo saggio si concentra sul ruolo delle sproporzioni, del salto di scala e delle salienze che questi fenomeni offrono in termini percettivi. Che siano le grandi sculture di Ron Mueck come Mask II (fig.4), quelle iperrealistiche a grandezza naturale di Duane Hanson o la ricostruzione in miniatura di un campo di concentramento popolato da oltre trentamila corpi nudi di The Sum of All Evil (2012) dei fratelli Chapman, il salto di scala si fa strumento retorico in grado di ridefinire la dimensione passionale e il quadro interpretativo di riferimento dell’opera d’arte.

Questo fenomeno è indagato anche da Renato Barilli che ne propone una genealogia, concentrandosi sul ruolo della fotografia e sulla funzione dei rimpicciolimenti e degli ingrandimenti. Come in Blow Up (1966) di Michelangelo Antonioni in cui il fotografo Thomas, protagonista della pellicola, proprio grazie al lavoro di ingrandimento dell’immagine fotografica riesce a svelare il mistero di un omicidio che aveva inavvertitamente catturato durante una sua passeggiata nel parco. Se infatti nell’età moderna le variazioni di scala nella rappresentazione di persone o cose erano l’eccezione, il contemporaneo – ricorda Barilli – ne sfrutta quanto più possibile le potenzialità. Basti pensare alle opere surrealiste o della Pop-Art come le gigantesche opere di Roy Lichtenstein di “cui bisogna riconoscere il merito di aver inoltrato ad oltranza, in una dilatazione gigantesca, il puntinato su cui si regge tutto il sistema di riproduzione di immagini nella nostra cultura novecentesca”.
Allo stesso modo le opere di Andy Warhol in cui il prelievo e la decontestualizzazione degli oggetti, la loro messa in serie e gli ingrandimenti mettono in gioco il rapporto percettivo tra rappresentazione e presenza dello spettatore. Come sostiene nel suo contributo Maria Giuseppina Di Monte, “il formato gioca un ruolo nella ricezione delle opere ovvero nel modo in cui esse vengono vissute ed esperite”. Concentrandosi sul lavoro dell’artista americano Ellsworth Kelly – come nel caso di Blue Green Black Red: The Dallas Panels realizzata nel 1989 per il Morton Meyerson Symphony Center di Dallas (fig. 5), Red Floor Panel (1992) e White curve (2001) – viene fatta chiarezza sul rapporto fruizione-formato e sul rapporto che queste opere di grandi dimensioni intrattengono con lo spazio in cui sono collocate.
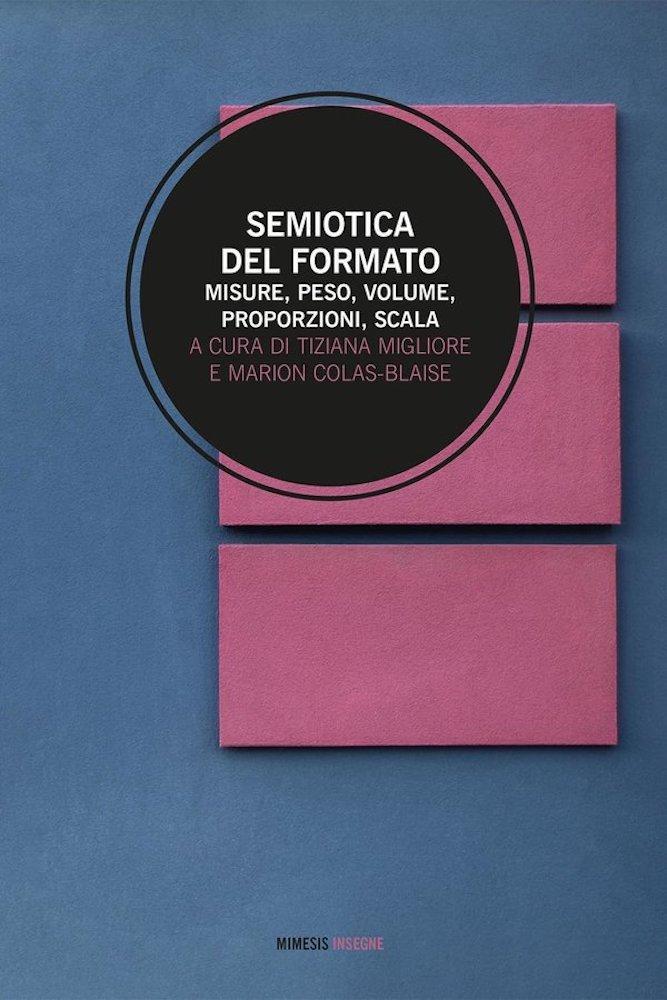
La questione del formato dell’opera d’arte e il suo rapporto con il contesto espositivo viene ulteriormente approfondita da Stefania Zuliani. Riprendendo la lezione di Gillo Dorfles sui limiti e le prospettive della Biennale del ’68, l’autrice riflette in maniera critica sul “gigantismo” che affligge le opere d’arte all’interno di eventi del global artworld come nel caso di grandi esposizioni del calibro di Manifesta o Documenta. Sconfinando esigenze di poetica e stile, sostiene Zuliani, si assiste al proliferare di un ordine di grandezza “che non trova e neppure cerca ragioni in specifiche esigenze di tipo espressivo” poiché lo scopo sarebbe piuttosto “quello di attestare, confermandolo e avvalorandolo per semplice, il prestigio espositivo, celebrato nelle sue forme più magniloquenti e trionfali”. Un vero e proprio effetto Biennal Scale come la mastodontica istallazione Paraproduction di Ni Haifeng, che si adatta di volta in volta al contesto espositivo in cui viene accolta.
L’euristica del formato è in questo senso centrale anche nei lavori di Paul Ardenne, Carla Subrizzi e Fabrizio Gay, quest’ultimo interessato agli effetti di senso della scala 1:1 e del ruolo pedagogico dei plastici delle architetture della città all’interno del Musée national des Monuments Français di Parigi. In modo analogo anche i contributi di Ruggero Pierantoni e Agostino De Rosa mettono in tensione la dimensione del formato. L’uno interessato alla dimensione del microscopico e del macroscopico attraverso un’attenzione specifica all’arte del mosaico, l’altro riflettendo sulla riconfigurazione dello spettatore a partire dall’immaginario ottico delle scatole prospettiche olandesi del XVI secolo.
Cos’è quindi che il formato, il gioco di scala e di proporzioni mettono in gioco? Perché questa dimensione risulta meritevole di essere investigata con maggiore attenzione? La risposta a queste domande la si può ritrovare nelle parole di Michele Di Monte. Quello che colpisce “è una differenza soprattutto estetica, non soltanto perché colpisce i sensi, ma perché influisce sul modo, cognitivo e affettivo, in cui percepiamo le cose, i rapporti, lo spazio e noi stessi”. L’opera Under the table di Robert Thierren (fig. 6) è un caso paradigmatico che consente di mettere in luce proprio i possibili effetti che il salto di scala macrodimensionale rende possibile.

Oggetti di uso comune nel quotidiano come set di tavoli e sedie nella loro trasfigurazione in opere dalle dimensioni ciclopiche, si offrono allo spettatore come monumenti pubblici della nostra epoca. Nel camminare sotto e intorno a questi grandi artefatti si è infatti colti da un duplice gioco percettivo: possiamo percepirli come straordinariamente grandi oppure sentire noi stessi come infinitamente più piccoli di quanto ci percepiamo di solito. E in questo senso è centrale l’idea proposta da Robert Storr per quanto riguarda il potere delle immagini in termini di reazione alle opere d’arte: “il nostro corpo sente le proporzioni tanto quanto le vedono i nostri occhi, se non di più”.
A questi contributi si aggiungono poi quelli di Francesco Marsciani e Bianca Terracciano che invece pongono l’accento su altre dimensioni del formato: il peso, le misure e il volume. Mentre il saggio di Terracciano si concentra sul ruolo delle misure all’interno del sistema della moda e su come il corpo venga ‘modellato’ dagli stili di un’epoca, dalle abitudini e dall’ambiente in cui è chiamato a vivere, Marsciani si concentra sulla nozione di massa. Partendo da un piano di fenomenologia sociale del quotidiano, egli sostiene l’idea per cui non sarebbero possibili segni, discorsi e linguaggi di qualunque tipo che prescindano dal corpo, dalla “massa” del soggetto in quanto corpo collocato di volta in volta in uno spazio e in un tempo specifici: “è sempre il corpo-massa che traccia e istituisce, di volta in volta, la differenza costitutiva del sé e dell’altro, del qui e dell’altrove e dell’allora in quanto presenza, rispetto ad un reale (perché stato) e ad un possibile (perché a venire). Che il corpo sia un corpo collocato come massa è la condizione perché i sistemi delle coordinate si rendano possibili”.
L’eterogeneità di voci che compongono questo volume, la ricchezza di prospettive metodologiche e le molteplici suggestioni teoriche che i vari contributi fanno emergere, sono la prova dell’urgenza di continuare a riflettere sulla dimensione del formato. Le categorie metriche, troppo spesso tenute ai margini della lettura delle immagini, sembrano un ulteriore strumento da inserire in quella “cassetta degli attrezzi” del metodo semiotico. Un metodo che si rinnova e progredisce continuamente proprio grazie alla forza dell’analisi dei testi e che – com’era solito ricordare Paolo Fabbri – “si rifresca con l’uso”.









