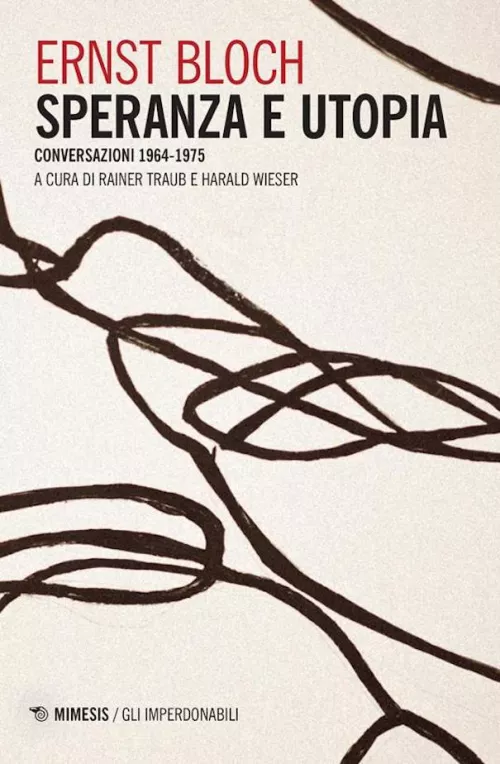Ernst Bloch: perché ci si alza la mattina?
Ci sono delle buone ragioni per sperare? Oppure, detto più prosaicamente ma anche in modo maledettamente più concreto, “perché ci si alza la mattina?”. Se nella notte ci si è rigirati insonni nel letto era proprio perché quella domanda non sembrava trovare risposta. La speranza in certe ore notturne è proprio come morta. “Perché ci si alza allora la mattina?” chiede il filosofo Ernst Bloch nella sua conversazione del 1964 con Theodor W. Adorno, da lui chiamato amichevolmente Teddy (Qualcosa manca… sulla contraddizione dell’anelito utopico contenuta in Ernst Bloch, Speranza e utopia, Conversazioni 1964-1975, a cura di R. Traub e H. Wieser, Mimesis, Milano 2022). Quali sono le radici metafisiche di quella folle speranza in un giorno migliore senza la quale l’esistenza sarebbe intollerabile? Il curatore italiano del libro Eliano Zigiotto, come Laura Boella, che lo correda con una breve e intensa post-fazione (dal titolo: Il coraggio di sperare e di disperare) insistono nel “datare” queste conversazioni: sono, ripetono, di cinquanta – sessanta anni fa quando il mondo era profondamente diverso, quando la guerra fredda imperava e la filosofia era praticata come atto critico e sovversivo.
Bloch e Adorno (per non parlare di György Lukács, compagno di studi filosofici del giovane Ernst, anche lui fugacemente presente in questi dialoghi) erano filosofi che nell’hegelo-marxismo avevano il loro orizzonte di riferimento teorico e nel socialismo quello pratico. Le loro strade certo divergono, anche drammaticamente, ma tutti condividono la speranza in una trasformazione radicale dello stato di cose, anzi il loro dissidio nasce proprio dai diversi modi in cui questa comune speranza può essere declinata. Ora, quel mondo è indubbiamente tramontato al punto che nemmeno chi si propone di rinnovare la malmessa sinistra italiana osa pronunciare quella parola, “socialismo”, che per Ernst come per Teddy era pressoché un’ovvietà. “Socialismo” era per loro “il sogno di una cosa” latente nel “processo storico”, di cui si poteva discutere la praticabilità ma non certo la “necessità”.
Eppure quella domanda, “perché ci si alza la mattina?”, rimbomba più che mai nella nostra testa frastornata. Ciò si deve, forse, al fatto che quella domanda non ha a che fare con il tempo lineare degli eventi, piuttosto va alla radice del tempo, chiede di qualcosa che non è più tempo, qualcosa che se ne sta fuori dal tempo, come il celebre exaiphnes di cui parlava il Parmenide immaginato da Platone, un “improvviso” (così bisognerebbe tradurlo) che del cambiamento è l’origine senza essere parte del tempo (per questo la sua traduzione con “istante” è fuorviante).
Nella prima delle conversazioni raccolte nel volume (anch’essa del 1964), l’intervistatore Jurgen Rühle fa una domanda a bruciapelo a Bloch. Una vera domanda “giornalistica”. Gli chiede: lei che ha scritto Il Principio speranza (1959), lei che ha rimesso in circolazione la necessità dell’utopia, una nozione che gli stessi marxisti, volendo essere “scientifici”, disprezzavano, lei ci sa dire in due parole “qual è l’idea di fondo della sua filosofia?”.
Bloch non esita a rispondere. Da vero filosofo sa che ogni pensiero vivente si nutre di una sola intuizione sebbene occorrano migliaia di pagine e un’intera esistenza di ricerca per comunicare al mondo la sua ineffabilità di principio. Quel punto, dice, è l’“oscurità dell’attimo vissuto”, quel punto è la strana natura del presente, del “qui e ora”. Non bisogna alzare gli occhi al cielo per cercare il mistero. Ciò che è massimamente vicino, perché io lo sono, adesso, è in realtà l’enigma.
L’immediato, come lo chiamano i filosofi, è l’enigma, l’immediato è la sorgente costante dello stupore. “Una vita” denota il tempo speso nel tentativo di decifrarlo e la “storia degli uomini”, con i suoi conflitti, con le sue catastrofi e con le sue rivoluzioni, è il succedersi degli “esperimenti”, quasi sempre fallimentari, con cui l’umanità ha cercato di risolvere quella X incognita nell’equazione del presente vissuto. Il presente, a ben considerarlo, ha infatti una ben strana natura. Il presente è intimamente aporetico, è un vicolo cieco.
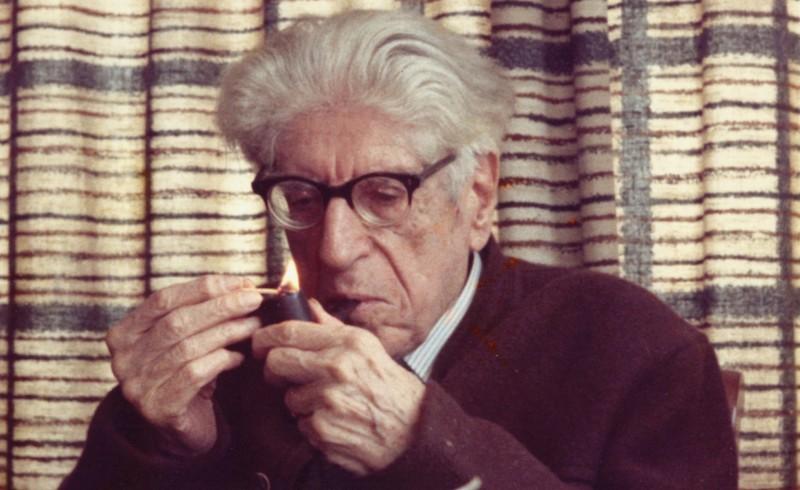
Ad esso non posso sottrarmi – provatevi, se ci riuscite, a fuoriuscire dal suo orizzonte claustrofobico… –, in esso tutto passa e, tuttavia, il presente resta a me, mentre lo sono, ignoto: per vedere qualcosa, per sentire qualcosa, per sapere qualcosa non bisogna forse fare sempre un passo indietro, articolare una distanza, esiliarsi in un “punto di vista” necessariamente esterno alla “cosa” che si ha di fronte? Come recita il proverbio tedesco, ai piedi del faro che illumina il mare c’è il buio e la visione, spiegano i fisiologi, è debitrice di una macchia cieca al fondo della retina. “Utopia” è allora il nome “preciso” che la speranza umana ha dato al momento apicale in cui quell’equazione sarà finalmente risolta, all’attimo immenso in cui il presente potrà dirsi veramente vissuto in pienezza. È un nome “preciso” perché utopia significa al contempo nessun luogo (ou-topos) e il luogo del bene (eu-topos).
Bloch, nelle sue conversazioni, non cita Proust, ma a Proust quella dinamica era assai familiare. Il motore della Recherche non è forse l’“oscurità dell’attimo vissuto”? La memoria involontaria non è una facoltà a disposizione del soggetto. La memoria è il laboratorio nel quale si conducono esperimenti, degni di un dottor Frankenstein, per estrarre dal presente opaco quel senso o quell’aroma spirituale che mentre era in atto non era “dato”. Come ben sa il lettore di Proust, occorrono migliaia di pagine perché il tempo finalmente ritorni e il “perduto” sia “ritrovato”. Immediatamente il presente è cieco. Mentre scorre si perde come neve al sole. Per farlo permanere occorre, come scrive Bloch, che “ruoti fuori”, che faccia segno di sé in un altro.
In Proust l’infanzia si dà così a vedere in un biscotto intinto nel thè da un adulto, “i mattini di Doncières (il passato) nei gorgoglii (presenti) dei nostri caloriferi ad acqua”. Nel filosofo marxista Bloch ad essere ritrovato nella lotta del proletariato per il socialismo era la speranza oscuramente insistente nella esperienza di generazioni di oppressi nel passato e nelle loro vane ribellioni. Per entrambi l’immediato contiene una latenza di futuro che spetta alla prassi esplicitare: nel caso di Proust a incaricarsene sarà la scrittura “messa in forma” dalla memoria involontaria, in quello di Bloch sarà l’azione trasformatrice dello stato di cose presente “messa in forma” dal pensiero critico.
Per entrambi Il cerchio del tempo da qualche parte deve chiudersi e ciò che pareva perso deve essere integralmente restituito, senza che vi siano residui che screzierebbero il cristallo. Entrambi sanno anche, però, che tutto questo è solo il “sogno di una cosa” e non la “cosa stessa”. Ci sono in Proust reminiscenze che non portano da nessuna parte e che lasciano all’esperienza che sembrano evocare la sua cecità di principio, proprio come avviene, scrive Proust, quando ci protendiamo verso “quegli oggetti situati troppo lontano di cui le nostre dita, allungandosi in cima al braccio teso, sfiorano solo per un istante l’involucro senza arrivare a prendere nulla”. Ci sono, insomma, tempi per sempre perduti e mai ritrovati. E a Bloch, filosofo della speranza, è chiaro, come ripete sovente in queste conversazioni, che la delusione sia l’habitat naturale della speranza. Una speranza che non potesse essere anche delusa non sarebbe infatti tale.
Ne risulta uno statuto tutto sommato deludente per l’utopia blochiana. Ridotta a semplice ideale regolativo dell’azione, non si capisce come possa infiammare gli animi, competendo, come Bloch auspica in pagine di raro acume storico, con la demagogia dei nazisti di ieri e, si potrebbe aggiungere, dei “sovranisti” di oggi. Certamente non è con un’arida razionalità ristretta all’“economico” che si può contendere nell’arena politica con i dispensatori di suggestioni identitarie, ma l’utopia è arma spuntata quando si presenta “razionalmente” come “principio speranza” anche se a colorarla emotivamente sono le fiabe e le luci del luna-park così care a Bloch. Per l’oratore nazista, della cui performance Bloch era stato testimone, “sangue e suolo” non è affatto utopia ma solidissima realtà (si veda la conversazione su Non-contemporaneità. Provincia e propaganda). Se il suo pubblico resta affascinato e da socialista che era diventa immantinente nazista è perché gliela fa toccare con mano, mentre è difficile toccare con mano quella che resta, dopotutto, un’idea generata dal pensiero critico. Bisognerebbe riflettere su quanto “frigida” sia una speranza che è divenuta un “principio” nel senso quasi fichteano del termine…
Allora perché continuare a sperare? Perché alzarsi alla mattina? Curiosamente a fornire elementi per una risposta ancora positiva a questa domanda è l’amico Adorno, il maestro del pensiero critico-negativo. Guidato dalla sua incontenibile vis dialettica, ma anche dalla simpatia che provava per Ernst e per il suo anelito utopico, Teddy va subito al dunque, vale a dire all’elemento propriamente scandaloso e raramente enunciato del principio utopico.
“La domanda sull’abolizione della morte”, dice, è il “punto nevralgico” dell’utopia. L’utopia rivoluzionaria è molto spinoziana (e, aggiungerei, per niente critico-negativa…): è l’utopia di una vita che vive, qui e ora, e che della morte, del negativo, del nulla, non ne sa proprio nulla. “Lo possiamo constatare molto facilmente – continua Adorno –, basta sollevare qualche volta la questione della possibilità di abolire la morte con i cosiddetti «benpensanti»”, la reazione sarà la stessa che si avrebbe “se si lanciasse un sasso contro un commissariato di polizia”. L’indignazione è infatti generalizzata, non solo per l’enormità della pretesa avanzata, ma perché ad essere minacciato è un principio d’ordine, che nel memento mori ha il suo cardine metafisico.
“Direi che questo tipo di reazione rappresenta il massimo contrasto con la coscienza utopica. L’identificazione con la morte oltrepassa di gran lunga e prolunga l’identificazione degli esseri umani con le condizioni sociali esistenti”. E Adorno non può esimersi a questo proposito da una stoccata al suo avversario di sempre, Martin Heidegger, responsabile con la sua ontologia della finitezza di aver “consacrato” e “assolutizzato” la morte, fornendo alla parte maggioritaria della filosofia novecentesca il pensiero-guida. Ancora oggi, del resto, a quale istanza sovrana fanno riferimento, “in ultima analisi”, i “benpensanti” quando stigmatizzano il presente denunciando la rimozione o l’oblio della finitezza che lo caratterizzerebbe? Se c’è una lezione da apprendere dalla pandemia, dicono tutti, concordemente, da destra a sinistra, senza quasi eccezioni, questa lezione magistrale non è altro che il vecchio e caro memento mori, eterna legge trascendente che regola ogni comunità umana.
Dimenticarlo introdurrebbe, secondo loro, all’anarchia e l’anarchia è il peggiore dei mali, peggiore del morire che dell’anarchia è il rimedio naturale. Inutile dire che lo stesso pensiero di Adorno avrebbe potuto trarre beneficio dalla iniezione di una siffatta coscienza utopica perché è proprio al suo côté critico-negativo che i “benpensanti” attingono a piene mani per screditare un presente u-topico e immemore del morire (la falsa promessa di immortalità generata dal sogno tecnologico, la società dello spettacolo, la mutazione antropologica, l’imperativo capitalista del godimento ecc. ecc.).
Perché allora ci si alza la mattina? Perché ci si affida ciecamente alla potenza irrazionale della “speranza” nonostante le lezioni di duro realismo che la notte ci ha impartito? Perché l’oscurità dell’attimo vissuto, alla quale, in quanto viventi, non possiamo sottrarci, si dice contemporaneamente in due sensi. Da un lato è certamente la latenza del possibile, la tensione verso il futuro del suo compimento (verso il “tempo ritrovato”), che Bloch ha meravigliosamente descritto nei suoi libri (soprattutto in Experimentum mundi del 1975). L’immediato è il suo trascendersi, è il suo protendere verso una pienezza di soddisfazione, che molto spesso sarà mancata. L’immediato è storia in nuce. Dall’altro, però, l’oscurità dell’attimo vissuto è, proprio a causa della cecità al senso che lo caratterizza, l’indice e la certezza di un radicamento nell’essere che niente potrà scuotere (se stiamo a Cartesio, nemmeno le macchinazioni di un Dio onnipotente che ci vuole male lo potrebbe).
L’immediato, in questo caso, è attualità per la quale non c’è opposto e che letteralmente non muore mai. L’immediato è immanenza assoluta, è utopia realissima, quotidianamente frequentata. Che questa non sia una sofisticheria generata da una ipertrofia intellettualistica (o, come si suole dire, una “sega mentale”…) lo verifica il fatto semplicissimo che noi al mattino ci alziamo, magari per abitudine, magari controvoglia, sicuramente disillusi, ma ci alziamo. E per quanto invecchiando, ammalandoci e consumandoci procediamo a grandi falcate verso la meta stabilita, è nell’immediatezza del presente immemore del morire che restiamo sempre saldamente installati fino alla fine. Da quel presente senza confini trae alimento una speranza che non ha nel tempo il suo orizzonte e nella morte la sua smentita.