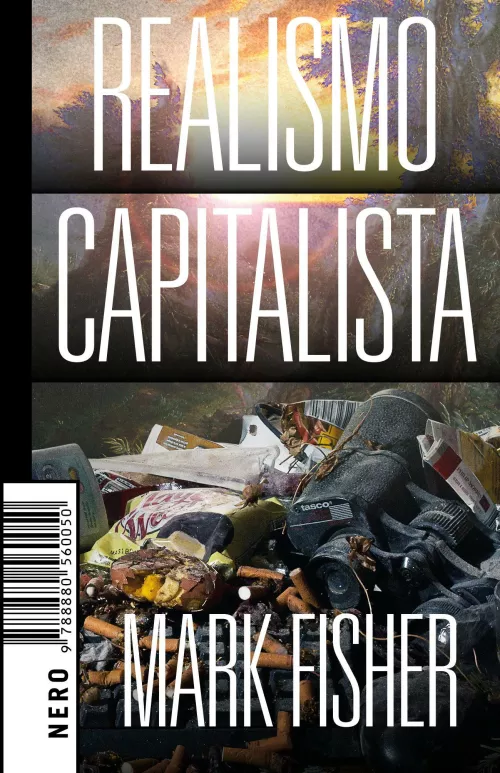Su Mark Fisher / Vivere e morire nell’eterno presente neoliberale
Arriva finalmente in Italia, tradotto da Valerio Mattioli per Nero Editions, Realismo capitalista di Mark Fisher, uno dei testi radicali più acclamati degli ultimi anni, capace di parlare anzitutto a una generazione per cui il capitalismo sembra occupare del tutto “l’orizzonte del pensabile”. Non si tratta semplicemente, sostiene Fisher, di ritenerlo l’unico sistema economico e politico sostenibile, ma di non trovare possibile neppure immaginare un’alternativa a esso.
Cancellando dal futuro ogni eventualità di un superamento della propria logica, il capitale ci defrauda anche del passato – che assume un senso soltanto nel rapporto con la novità. Del resto, ci insegna Ellen Meiksins Wood, la storia del capitalismo è in buona parte una successione di tentativi di naturalizzazione volti a retrodatarne sempre più l’emersione, ammantandola al contempo di una coltre di inevitabilità deterministica da cui nemmeno la tradizione marxista è stata immune. Se Deleuze aveva intuito la possibilità di sfidare la logica infuturata del capitale – che antepone in modo fittizio la mancanza al desiderio – in un presente intensivo, non orientato verso nessun futuro, Fisher ci mostra in un senso l’instabilità di questa frontiera di resistenza, che è sempre a rischio – nelle parole di Laura Bazzicalupo – di risultare involontariamente funzionale al sistema acefalo del mercato finanziario.
Occorre, tuttavia, non lasciarsi ingannare dalla densità dei concetti che Realismo capitalista mette all’opera: non abbiamo tra le mani l’ennesimo, ponderoso volume di filosofia politica e siamo lontani dalle vertiginose astrazioni a cui autori e autrici di riferimento della sinistra contemporanea ci hanno spesso abituati. Mark Fisher era cresciuto del Regno Unito del There is no alternative thatcheriano, nel pieno di quell’epocale miscuglio di innovazione e restaurazione (o meglio: restaurazione attraverso strumenti nuovi) che va sotto il nome di neoliberismo. La logica dell’austerità, della costante revisione al ribasso delle proprie aspettative in nome del male minore che è al centro del volume, è la stessa che le studentesse e gli studenti del college popolare in cui aveva insegnato per anni si trovavano a fronteggiare, in uno scenario in cui il costo dell’istruzione aumenta e le opportunità occupazionali diminuiscono. L’urgenza della prosa, l’intelligenza nomadica che portano le pagine di Fisher a vagare dalle altezze della teoria critica a un’affilata rilettura di blockbuster cinematografici non hanno niente dell’interdisciplinarietà di maniera di certi studi culturali – verrebbe da esclamare, riprendendo l’espressione di Tennessee Williams a proposito del secondo romanzo di Kazan: “C’è un uomo qui dentro!”.
Dal punto di vista strettamente teorico, del resto, l’analisi di Realismo capitalista non è particolarmente nuova. L’idea di un capitalismo occlusivo rispetto a una qualunque facoltà di pensare altrimenti era già presente in Bourdieu e Jameson, la nozione di ideologia della quale Fisher si serve è fortemente debitrice al primo Slavoj Žižek, la (solo apparentemente paradossale) coesistenza tra neoliberismo e neofondamentalismo era già stata mappata da Wendy Brown; la sua stessa visione della temporalità si rifà all’ultimo Derrida, a David Harvey e ancora a Jameson. Certo, Fisher riesce a combinare con chiarezza (e sempre citando le proprie fonti) una serie di idee spesso complesse, rendendole accessibili al grande pubblico nella forma accattivante del pamphlet. Tuttavia, non credo sia questa la ragione del successo internazionale del libro, in grado di conquistare platee molto diverse (dalle avanguardie artistiche ai movimenti sociali ai dipartimenti universitari).
Piuttosto, come ipotizzava già Francesca Coin – tra le poche in Italia a intuire l’importanza di questo autore – a rendere unico Fisher è la sua singolare capacità di reinterpretare con tempismo perfetto il motto femminista per cui “il personale è politico”. Al tentativo di colonizzazione neoliberista di tale slogan – attraverso la ricerca (e la vendita) di “soluzioni biografiche a contraddizioni sistemiche” – Realismo capitalista risponde portando all’estremo la relazione apparentemente ossimorica tra i due termini: alla stregua di quanto si leggerà nel successivo Ghosts of My Life, il modo più produttivo di interpretare l’espressione è leggerla come “il personale è impersonale”. Parlando di se stesso, Fisher riesce a focalizzare le dimensioni “culturali, strutturali e politiche” della soggettività, scandagliando i drammi dei nostri tempi in un modo che riesce ad evitare sia l’altisonante prosopopea di molte star accademiche che un personalismo vagamente ombelicale in stile Teoria della classe disagiata.
Questo modo peculiare di “partire da sé” lo troviamo all’opera in due di quelli che il libro elabora come potenziali fronti di ri-politicizzazione di un mondo che il neoliberismo vorrebbe attraversato da singolarità monadiche, magicamente armonizzate dalla mano invisibile del mercato: burocrazia e depressione.
La prima potrebbe sembrare l’antitesi di un realismo, quello capitalista, che diversamente dai precedenti mira all’accettazione non di una realtà immutabile, ma di una infinita plasticità, di una costante riconfigurazione – difficile del resto trovare metafora migliore per la natura sempre più volatile dei rapporti di lavoro e per la compressione del dibattito politico in un’unità di senso non più corpose della durata del talk show medio. Ma se la società disciplinare di foucaultiana memoria – che si reggeva su apparati imponenti come la scuola, il carcere, il manicomio e l’esercito – appare in buona parte superata, il suo pesante carico di supervisione burocratica ha semplicemente assunto una forma diversa: il controllo, afferma Fisher riecheggiando Deleuze, è ora dentro di noi. Non sono più necessarie le ingombranti impalcature istituzionali del passato: l’individuo neoliberale è il primo sorvegliante di se stesso.
Esempio perfetto di questa tendenza è l’(auto)valutazione in ambito accademico, che l’autore osserva non dalla prospettiva del professore di grido attorniato da un stuolo di teaching and research assistants, ma da quella del docente precario in un further education college – realtà universitaria poco ambita nel Regno Unito. Fisher descrive con ironia amara la propria lotta con le infinite procedure relative al gradimento e alla valutazione che derivano dall’aver trasformato progressivamente le università da luogo dove viene offerto un servizio pubblico a segmento di mercato in cui studentesse e studenti sono semplici consumatori.

Ph Michael Wolf.
La commercializzazione dell’istruzione si accompagna così non a un’efficienza priva di attrito – come vorrebbe la retorica capitalista –, ma a un maldestro tentativo di rendere con indicatori quantitativi un’attività per sua natura qualitativa come l’insegnamento delle materie umanistiche. La conseguenza, da ultimo, non può che essere uno spostamento dal raggiungimento di obiettivi concreti, che facciano la differenza per chi studia, alla produzione di mere rappresentazioni di un tale raggiungimento – volte a ottenere un buon posizionamento nelle graduatorie, dunque una fetta più grande di un torta che però va riducendosi costantemente (nel Regno Unito l’aumento delle tasse universitarie negli stessi anni in cui usciva Realismo capitalista ha accentuato ulteriormente la tendenza di quel sistema a esternalizzare i costi e discriminare gli studenti in base alla classe sociale). In un ambiente del genere, in cui la competizione è tutto e gli atenei sembrano sempre più, soprattutto in ambito umanistico, delle riserve indiane, non occorre nemmeno una sorveglianza dall’alto: è il singolo stesso a imporsi ritmi e risultati proibitivi.
Prendere coscienza di questa interiorizzazione della logica della performance diventa quindi un passaggio di vitale importanza, a maggior ragione quando questa si insinua in ambito scolastico – vale a dire proprio in quei luoghi in cui la facoltà di concepire alternative all’esistente dovrebbe essere nutrita.
Arriviamo dunque alla seconda frontiera di possibile ri-politicizzazione: quella depressione di cui Mark Fisher ha sofferto per buona parte della propria esistenza e della quale è stato, senza dubbio, tra gli osservatori più acuti dell’ultimo decennio.
Precarietà, disuguaglianza crescente, burn-out, progressiva impossibilità di distinguere tra tempo di vita e tempo di lavoro: nella sua configurazione attuale il capitalismo stimola forme di malessere psichico forse mai così diffuse. Non si tratta di una relazione meccanicistica – e l’autore è sempre molto attento a sviluppare una critica serrata del riduzionismo psichiatrico senza cadere nel cliché dell’antipsichiatria –, ma di un processo complesso in cui le trasformazioni nella struttura occupazionale, la contrazione del welfare e la polarizzazione della ricchezza (solo per citare alcuni fattori) intersecano una codificazione individualistica che rende le persone immediatamente responsabili di squilibri sistemici, in una perversa sovrapposizione di colpa e debito (sulla cui contiguità semantica nella lingua tedesca rifletteva già Benjamin). Fisher non è particolarmente interessato a mettere in discussione la presunta radice biochimica della depressione, ma a spostare il focus dalla patogenesi all’eziologia: quali fattori socio-economici possono produrre una determinata alterazione della chimica cerebrale?
Ecco allora che la depressione, in quest’ottica, diventa perfettamente funzionale al capitalismo nella sua variante neoliberale: da un lato, permette di ottenere margini di profitto ingenti proprio dal trattamento delle ripercussioni psichiche di dinamiche strutturali; dall’altro, patologizzando il malessere incentiva ad introiettare ulteriormente una dinamica di colpevolizzazione – il sentirsi, per citare il titolo di un famoso articolo di Fisher, delle persone buone a nulla se non si ottiene il successo all’interno di un contesto che lo promette a tutti ma lo offre a pochi.
Di nuovo: nessun riduzionismo naif. Realismo capitalista non prova a sostenere che tutte le forme di depressione abbiano la propria origine scatenante nel processo di soggettivazione capitalistica; piuttosto, contrasta la retorica dominante secondo cui nessuna lo sarebbe.

Ph Michael Wolf.
A chi non abbia familiarità con certi temi, la tesi di Fisher potrebbe nondimeno apparire semplicistica o addirittura sconclusionata, ma basta inserirla nel contesto temporale della prima pubblicazione del libro (2009) per coglierne l’originalità. Nel 2006 David Healy, un riferimento internazionale nel campo della psicofarmacologia, pubblicava Let Them Eat Prozac, una corposa denuncia della relazione malsana tra gli interessi delle industrie farmaceutiche e la prescrizione sempre più ingente di farmaci antidepressivi. Pochi mesi più tardi due esperti altrettanto autorevoli nel campo della diagnostica psichiatrica, Allan Horwitz e Jerome Wakefield, davano alle stampe The Loss of Sadness, un’opera che smontava con forza il mutamento nei criteri diagnostici che aveva consentito nei decenni precedenti di definire (e trattare) come patologiche forme di malessere che costituivano risposte fisiologiche a condizioni personali o sociali. Gli sviluppi di questo dibattito all’interno della psichiatria sono complessi e contraddittori (ad esempio: la nuova versione del DSM, il manuale statistico-diagnostico dell’American Psychiatric Association, non ha accolto le modifiche proposte da Wakefield e Horwitz, ma i criteri per diagnosticare la depressione sono oggetto di critiche crescenti all’interno della disciplina) e sicuramente non possono venire affrontate in questa sede, ma l’esistenza stessa di un acceso confronto sul tema nella comunità scientifica rende le osservazioni di Fisher tanto tempestive quanto plausibili. Del resto, l’operazione (apparentemente radicale) compiuta in Realismo capitalista e altri scritti rispetto alla depressione non è qualitativamente diversa da quella, allo sguardo odierno quasi mainstream, sviluppata mezzo secolo fa da Fanon nei confronti della supposta impulsività criminogena dei nordafricani – la cui radice egli rinveniva non in un difetto mentale, ma nel contesto coloniale.
Quel che è certo è che anche questo secondo fronte di ri-politicizzazione inquadra una linea di faglia significativa del capitalismo contemporaneo, che nel periodo immediatamente successivo è stata indagata da una pluralità di voci – da Ann Cvetkovich a Byung-Chul Han.
Mark Fisher, tuttavia, non è stato solo un critico del neoliberismo, ma anche e forse prima di tutto – come ci ricorda Valerio Mattioli nella sua bella prefazione – un interprete profondo delle forme culturali che hanno accompagnato il suo sviluppo. Autore per circa un decennio di un seguitissimo blog dedicato (non solo) alla scena musicale, riscontrava nella produzione artistica attuale l’incapacità di andare oltre il mero rispecchiamento delle contraddizioni del presente, la tendenziale mancanza di slanci utopistici (o anche solo autenticamente distopici) che consentissero di prefigurare un futuro diverso. Proprio per questa ragione amava prestare attenzione alle saltuarie eccezioni a tale dinamica, che si trattasse della musica di Burial o del cinema di David Lynch.
Questa dimensione, più accentuata nei suoi altri libri, non è assente nemmeno da Realismo capitalista, che non a caso si apre con una folgorante rilettura de I figli degli uomini: un film la cui distopia è spuria in quanto non costituita da un’ambientazione realmente alternativa, ma da una mera – e per certi versi terribilmente plausibile – esacerbazione dei tratti del nostro mondo.
Qual è, verrebbe da chiedersi in conclusione, il senso di questo notevole esercizio testuale? A cosa ci porta l’impietosa radiografia dell’orizzonte asfittico del capitalismo contemporaneo? Una possibile risposta potrebbe sottolineare l’importanza della produzione di Fisher nello stimolare l’immaginazione politica, nel concepire il radicalmente altro – un tema evidente fin dal titolo della sua ultima opera, The Weird and the Eerie.
Se c’è una cosa che il volume appena uscito ci trasmette, tuttavia, è la necessità di non essere ridotto all’ennesimo esercizio intellettuale: non ci sono pose nella malinconia dell’autore, la sofferenza di cui ci parla non gli è estranea. Come molte altre persone che hanno letto l’edizione inglese di Realismo capitalista in un momento difficile della propria esistenza, chi scrive ha trovato in quelle pagine anzitutto un rimedio alla solitudine “deliberatamente coltivata dal potere”, uno stimolo a ricercare antidoti collettivi al malessere diffuso.
Non c’è nessuna garanzia che ciò basti a rendere la realtà sopportabile e lo sforzo per cambiarla sensato – ma proprio in questo sta la grandezza di Mark Fisher, la sua inarrivabile innocenza: nel non negare né l’enormità del compito, né la speranza di portarlo a compimento.
La vita di Mark Fisher appartiene ormai al passato, eppure le sue parole non smettono di mostrarci la flebile, e perciò tanto più preziosa, scintilla del futuro.