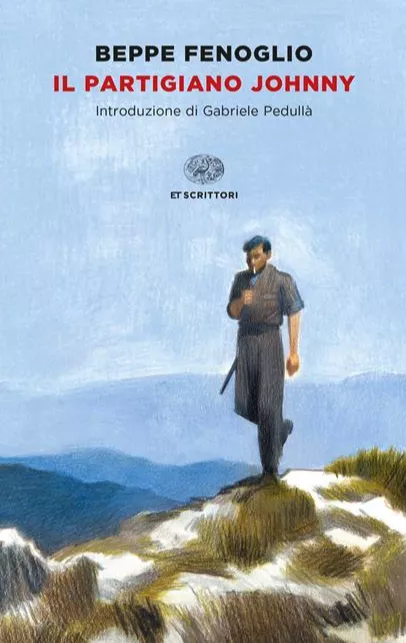Dizionario Fenoglio / Beppe Fenoglio. Solitudine
Nel cimitero di Alba, “partigiano e scrittore” sono le due parole scolpite in ferro battuto sul marmo della lapide di Beppe Fenoglio, di cui ricorre il centenario della nascita. Sono un’endiadi, come “notte e ruina” della Ginestra leopardiana. Fenoglio fu difatti un partigiano-scrittore con la stessa intensità e pienezza con cui fu poi uno scrittore-partigiano, che diede vita a uno dei libri più belli dedicati alla resistenza italiana. Nel 1964, a un anno dalla scomparsa di Fenoglio, lo stesso Italo Calvino non stentò a riconoscere, malgrado un pizzico di invidia, che Una questione privata era a tutti gli effetti “il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se lo aspettava”. Morto nel pieno dei suoi quarant’anni, Fenoglio non ebbe però la possibilità di completare l’opera, né tantomeno di vederla pubblicata.
Ma la parola che, forse, al meglio, si adagia su di lui, descrivendone al contempo la vita e l’opera, è da ricercarsi sempre tra le pieghe disinvolte della scrittura di Calvino: “solitario”. Posto ai margini dei salotti letterari dell’Italia postbellica, poco noto in vita per le sue opere di narrativa, che pure avevano ottenuto un posto nella prestigiosa collana einaudiana dei «Gettoni» con I ventitré giorni della città di Alba (1952), Fenoglio fu un traduttore, uno scrittore abilissimo e un narratore di caratura internazionale che pose al centro delle sue storie se stesso, o meglio la propria solitudine. I suoi personaggi sono come lui, uomini solitari tesi verso una quête senza freno, tra follia amorosa e cavalleresco inseguimento, sotto l’ombra delle gesta di Orlando, e spinti a calpestare con frenesia e condizioni climatiche spesso avverse lo spazio delle Langhe, teatro d’elezione delle sue opere e delle sue azioni di combattente badogliano, dopo lo scioglimento dell’esercito regio nel quale aveva mosso i suoi primi passi militari, mentre studiava letteratura all’università di Torino.
La storia di Una questione privata, edita per l’editore Garzanti nel 1963, coinvolge un giovane partigiano, Milton, il cui nome tradisce la passione per il mondo della letteratura inglese e il ricordo per quelle giornate che, come un paradiso perduto oramai a causa della guerra, erano state consumate con gioia in compagnia di Fulvia. Sul loro amore, ora che la ragazza è ritornata in città e lui si è dato alla macchia, pesa un malizioso accenno della custode della villa, lasciato cadere con apparente noncuranza, «…ultimamente veniva troppo spesso, e quasi sempre di notte…», il quale sottintende una passione segreta per Giorgio, un secondo partigiano, più bello e meno sgraziato di lui. Si ingenera così una vorticosa caccia del rivale che imprime una decisa accelerazione al racconto: Milton, prima, alle prese con la ricerca di Giorgio, e poi con il tentativo di liberarlo dal momento che era caduto in mano al nemico fascista, vive ora l’ossessione del tradimento e l’irrinunciabile bisogno di scoprire la verità:
Milton si rivolse alle alture che stavano tra Treiso e Mango, il suo itinerario di domani. Il suo occhio fu magnetizzato da un grande albero solitario, con la cupola riversa e come impressa in quella fascia argentata che rapidamente si ossidava. ‘Se è vero, la solitudine di quell’albero sarà uno scherzo in confronto alla mia’. Poi, con infallibile istinto, si orientò a nord-ovest, in direzione di Torino, e disse audibilmente: ‘Guardami, Fulvia, e vedi come sto male. Fammi sapere che non è vero. Ho tanto bisogno che non sia vero’.

L’antagonista e l’amata non compaiono mai sulla scena. In quelle pagine dominano atmosfere rarefatte che colgono il protagonista, come la nebbia costante, nei suoi pensieri, con i suoi dubbi, con il fantasma passato della donna che appare solo nella dimensione del ricordo, anticipando così la natura perduta di quella passione. Fenoglio è un maestro nella resa di quel paesaggio langarolo che riflette, attraverso la propria spettralità, l’ossessività della mente di Milton, sul cui corpo il narratore onnisciente installa una macchina da presa che non lo abbandona quasi mai, e ci fa percepire persino il respiro della folle corsa finale, dove il protagonista, ritornato nella villa per raccogliere nuove prove, cade (forse) vittima di un rastrellamento dinnanzi a un muro di alberi che sembra respingerlo dalla verità.
Ma Beppe era un solitario non solo per i personaggi che aveva creato o per la vita che aveva vissuto, ma anche per il modo in cui aveva scritto. Come non ricordare, a questo proposito, l’altro capolavoro, il «libro grosso», Il partigiano Johnny, frutto di numerose riscritture e rifacimenti, volti a non cedere il passo all’abbondanza, ma a elidere il superfluo; egli stesso ricordava come la sua pagina più facile uscisse «spensierata da una decina di penosi rifacimenti. Scrivo with a deep distrust and a deeper faith». Quest’opera, che fu pubblicata postuma nel 1968, e la cui storia editoriale fu oggetto di un acceso dibattito tra gli specialisti (non ancora del tutto risolto), è costruita sull’«epica di un antieroe disperato», come constatò Dante Isella, curatore dell’edizione critica che ancora oggi si legge nella union edition di Einaudi, appena pubblicata nell’occasione di questo anniversario. La storia, il cui finale è incerto, a sottolineare l’avversione generale di Fenoglio nel concludere le proprie opere, racconta le gesta di uno studente, appassionato di letteratura inglese, che abbandona una villetta alle porte di Alba dove si era rifugiato per darsi alla lotta clandestina contro il nemico nazifascista. Ma la solitudine del libro rispetto alla letteratura che si andava allora pubblicando la si misura soprattutto in quel linguaggio chiamato «fenglese» (E. Saccone), una lingua magmatica in cui l’italiano mescolato all’inglese assomiglia a un campo di battaglia dove l’occhio del lettore incespica, fatica a procedere, si ferma per prendere fiato, tornare infine alla carica sino all’ostacolo successivo:
Nessuno veniva in vista in quella estremità del concentrico, nemmeno una bestia, un cane mezzo cittadino e mezzo campagnolo nella sua libera uscita serotina: ma dalle prime case, al di sopra del lutulento murmure del torrente, saliva il consueto bruire serale ma d’un tono sotto il consueto. Era orribile quella privazione della sua città per colpa della sua posizione e dei fascisti. D’un tratto, nell’ombra franante, ebbe il raggelante sogno di trovarsi lui solo in quella posizione, un solitario fuorilegge, autobanditosi per motivi non chiari nemmeno a lui stesso, precisatisi in un incubo, e che ora si trovasse, solo, di fronte a tutto un mondo inferocito e vendicativo, un mondo di lawsticking and armate guardie già tutte a lui sguinzagliate…
Ridurlo a questo significherebbe però fargli un torto, perché lo stile del libro è esemplato in modo raffinato sulla struttura profonda della morfo-sintassi inglese, da cui discendono molte neoformazioni che si trovano qua e là disseminate (quali: immaneggevole, nonridente, impressivo, provocativo e via discorrendo). Sul versante del contenuto, le cose non cambiano. Non solo perché anche questo personaggio è colto nella sua miseria umana dinnanzi alla ruota della Storia, ma in particolare perché la sua posizione di partigiano non comunista lo spinge a sentirsi “in the wrong sector of the right side”. Questo fu ancora più stringente per Fenoglio stesso: Il partigiano è un libro solitario e anticomunista, soprattutto se lo si commisura al momento in cui fu scritto, durante gli anni Cinquanta in cui il comunismo italiano si era attribuito un ruolo di primordine nella nascita della Repubblica italiana: «Comunista? Ma che significava, e che comportava esattamente l’essere comunista? Johnny non ne sapeva nulla, all’infuori della stretta relazione con la Russia». Johnny preferisce la letteratura, isolarsi con Shakespeare o Marlowe. Non amava tanto gli autori americani, che piacquero invece a Pavese o a Vittorini, lui amava l’Inghilterra elisabettiana e rivoluzionaria. D’altronde in quegli autori, Fenoglio, come il suo personaggio, scorse un modello umano, una specie di formazione che, coniugata alla passione per la filosofia studiata sotto l’egida di Pietro Chiodi, offrì un modello da contrapporre a quanto il fascismo metteva allora in campo.
All’indomani della guerra, prima che un tumore provocato dal vizio del fumo lo portasse via anzitempo lasciando così incomplete le sue opere maggiori, senza un definitivo imprimatur autoriale, Fenoglio dichiarò che avrebbe voluto abbandonare il tema della Resistenza, “… basta con i partigiani…”. Dopo Primavera di bellezza, opera edita nel 1959 in cui narra le prime gesta di Johnny, si sarebbe voluto dedicare ad altre storie. Eppure, un istinto monomaniacale lo ricondusse sempre con forza verso quei luoghi, verso quel tempo, quando oramai quel filone narrativo era divenuto inattuale. Secondo Gabriele Pedullà, in La strada più lunga, un saggio (ahimè) non più in commercio, Fenoglio ribadisce «l’ambizione di essere scrittore di una sola storia». E a questo demone fu debitore per il resto della sua vita: in quel volgere di pochi anni, tra il 1943 e il 1945, egli esaurì difatti la propria esperienza umana, il suo senso e il suo universo erano là racchiusi, e travasati nel decennio successivo nella trasparenza di quelle pagine rarefatte e così fresche ancora oggi. Era lui stesso ad ammetterlo allorquando, nelle prime pagine del Partigiano, ammoniva: «partigiano, come poeta, è parola assoluta, rigettante ogni gradualità».
E ogni assolutezza, d’altronde, si paga con la solitudine.