Dizionario Fenoglio / Beppe Fenoglio. Memoria
Quando si parla della storicità dei libri di Fenoglio si pensa ovviamente al periodo nel quale sono ambientate le vicende, dunque soprattutto alla Resistenza. Il ciclo di Johnny va letto però anche e soprattutto alla luce delle passioni degli anni Cinquanta e a una competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica che ormai, pure in provincia, riscaldava gli animi assai più di quella tra fascisti e antifascisti. Persino Alba rimaneva una città molto divisa: al punto che – come ha ricordato di recente un giovane testimone di allora, Pierdomenico Gallo – nel dopoguerra «alla sera la passeggiata in via Maestra divideva i licei in due gruppi: i cattolici sulla sinistra verso piazza Savona e i laici sulla destra». Una frattura netta, che si proiettava anche sulla memoria degli eventi storici più recenti, quando repubblichini e partigiani si erano affrontati con le armi in pugno, tanto più che su molti muri delle strade periferiche erano ancora visibili i fori lasciati dai proiettili dei plotoni d’esecuzione.
Oggi è facile non rendersene conto, ma al momento della sua composizione il romanzo di Fenoglio veniva per forza di cose a inserirsi in una polemica cittadina sugli avvenimenti del biennio 1943-1945 che, nonostante il tempo trascorso, era tutt’altro che sopita. Di chi era stata la decisione di occupare Alba nell’ottobre del 1944, quando era facile prevedere che non sarebbe stato possibile tenerla davanti un contrattacco fascista in forza? Quali erano stati i meriti di ciascuna delle diverse formazioni partigiane? Davvero la Resistenza dei badogliani era stata più facile di quella dei garibaldini, grazie ai lanci degli inglesi e agli scambi di prigionieri con i fascisti, da cui invece i partigiani comunisti rimanevano esclusi? A dieci anni dalla fine della guerra, quando Fenoglio si mise verosimilmente a stendere il ciclo di Johnny, domande del genere continuavano a mantenere una precisa attualità nelle discussioni cittadine ed è impossibile che non abbiano condizionato anzi la sua scrittura, tanto più che, all’indomani del conflitto, alcuni dei protagonisti della lotta partigiana nelle Langhe avevano messo per scritto e pubblicato tempestivamente i loro ricordi, scatenando una vera e propria battaglia di memoria tra i diversi gruppi. Alcuni aspetti della narrativa resistenziale di Fenoglio degli anni Cinquanta si possono capire davvero solo in dialogo con questi testi.
I volumi si erano addensati soprattutto nell’immediato dopoguerra. Nel 1945 era uscito Classe 1912 del capo di stato maggiore della VIII e IX divisione Garibaldi del Basso Monferrato, Davide Lajolo (1912-1984); l’anno dopo era toccato a Banditi del filosofo esistenzialista e comandante partigiano (di fede socialista ma distante dai comunisti) Pietro Chiodi (1915-1970) e a La tortura di Alba e dell’Albese del vescovo della città, monsignor Luigi Maria Grassi (1887-1948); infine, nel 1947 il comandante badogliano (liberale) Enrico Martini, detto «Mauri» (1911-1976), aveva pubblicato Con la libertà e per la libertà (successivamente ristampato da Mondadori con il titolo Partigiani penne nere). Di loro, Chiodi e Martini/Mauri (soprannominato da Fenoglio «Lampus») sono personaggi importanti del ciclo di Johnny, mentre il vescovo di Alba vi è appena menzionato, e Lajolo, che era originario di Asti, di Fenoglio e Chiodi era, o si fingeva, addirittura amico (una domanda che si impone alla luce della sua stroncatura sotto pseudonimo di I ventitré giorni della città di Alba che si apre con queste parole: «Beppe Fenoglio, dice una nota di presentazione sulla copertina del libro, esercita ad Alba il mestiere di procuratore presso una ditta vinicola.
Noi non sappiamo se questo mestiere egli lo esercita onestamente, oppure vende del vino annacquato. Certo è che in fatto di racconti non possiamo parlare di onestà: e questo libro lo dimostra»).
A rileggerli assieme, colpiscono però soprattutto le numerose sovrapposizioni tra i racconti: Lajolo parla ripetutamente di Mauri; Mauri evoca a più riprese monsignor Grassi («Il nostro Vescovo, il Vescovo partigiano»), oltre che parecchi personaggi del ciclo di Johnny: Piero Balbi detto «Poli» (il «Nord» di Fenoglio), Piero Ghiacci (il «Pierre» fenogliano), Arturo Daidola soprannominato «Kyra», Dario Scaglione alias «Tarzan»; monsignor Grassi riferisce dei suoi incontri con Mauri e menziona «Poli» e Cocito, collega di Chiodi al liceo di Alba e professore di italiano di Fenoglio (il quale, come si vedrà, lo rappresenta invece con scarsa simpatia nel ciclo di Johnny), partigiano comunista e medaglia d’oro al valor militare, impiccato dai tedeschi i 7 settembre 1944; attorno alla figura eroica di Cocito, al suo esempio e al vuoto lasciato con la sua morte, ruota in gran parte il diario di Chiodi.
A volte, addirittura, la medesima vicenda è raccontata da due prospettive diverse, come la cattura di 153 ostaggi da parte dei tedeschi per ottenere la liberazione di quattordici loro soldati che erano scomparsi, con monsignor Grassi che si reca da Mauri per chiedergli notizie, e Mauri che, pur sapendo che sono già stati fucilati, finge di ignorare la loro sorte nonostante mentire a un vescovo lo metta a disagio. Oppure l’incontro tra i comandanti partigiani e i comandati fascisti per parlamentare alla vigilia dell’attacco di questi ultimi contro Alba (anch’esso raccontato da tanto da Grassi quanto da Mauri, prima di riapparire nel ciclo di Johnny).
Dei quattro libri, Banditi è l’unico che oggi venga ancora letto dai non specialisti di storia locale in virtù dei suoi meriti letterari. Secco, riscritto dopo la guerra in forma di diario per brevi annotazioni, senza alcuna concessione alla retorica, il memoriale di Chiodi si distingue da gran parte dei testi analoghi anzitutto perché per quasi metà del testo ricostruisce la propria cattura, prigionia ed evasione. A questa parte centrale vanno aggiunti però una sorta di breve preambolo, in cui Chiodi narra il lento precipitare degli eventi e la decisione di seguire l’amico Cocito nella lotta attiva, e una parte finale dedicata invece alla ripresa dell’attività partigiana del solo Chiodi dopo la fuga dal campo di lavoro a Innsbruck, sino ai primi di maggio del 1945. Cocito rimane però il centro gravitazionale del libro anche dopo che è uscito di scena. Prima che Chiodi organizzi una propria banda di partigiani molte delle annotazioni riguardano le visite che nonostante il pericolo l’amico continua a fargli e i racconti delle sue prime imprese; quando vengono catturati assieme e i loro sentieri si dividono (perché Chiodi viene deportato in Austria, mentre Cocito, che è assai più compromesso di lui, rischia la fucilazione immediata e di lì a poco finirà in effetti impiccato), il pensiero del narratore non smette di riandare all’amico; il difficile rientro nelle Langhe coincide infine con la dolorosa scoperta che Cocito è morto, e l’ultima parte del libro culmina nella liberazione di Torino, quando Chiodi torna nel carcere delle Nuove dove i due amici erano sono stati rinchiusi assieme, e nel verbale steso dal medico di Carignano sul contegno eroico dell’amico davanti al patibolo e sull’enorme impressione da lui prodotta anche nei tedeschi.
Caduto Cocito, il suo posto è destinato a non essere preso da nessun altro. E infatti Chiodi scrive, raccontando la breve visita alla cella dove era stato prigioniero con i suoi compagni che prepara il finale: «No, quei mesi non erano riempiti dalla mia salvezza, dalle mie lacrime, dalla vittoria dalla libertà, erano riempiti dalla loro morte. La differenza fra allora e adesso era questa che allora Noi c’eravamo e ora Noi non c’eravamo più».
Proprio la centralità dell’amicizia fa di Banditi un libro diverso dagli altri dedicati alla lotta antifascista nelle Langhe, anche perché le grandi questioni politiche e militari vengono lasciate implicite da Chiodi a beneficio di un racconto che, nella sua asciuttezza, privilegia invece i piccoli avvenimenti privati, talvolta in tono volutamente dimesso. Su una nota completamente diversa, baldanzosa e a tratti addirittura euforica, squillante, è scritto invece il volume di Lajolo. Dei quattro memoriali, a dire il vero, Classe 1912 è quello che oggi si legge nettamente con meno simpatia nonostante almeno un episodio felice, quando il protagonista – nome di battaglia Ulisse, come lo stesso Lajolo – è costretto a nascondersi per giorni sottoterra senza cibo né acqua assieme ai propri uomini mentre fuori imperversa un rastrellamento e i fascisti brutalizzano invano i contadini della cascina dove sono occultati nel tentativo di farsi rivelare il loro nascondiglio (il lettore di Fenoglio non può non ripensare a tante situazioni analoghe a proposito terribile novembre del 1944).
È anzitutto una questione di stile: bellurie poetiche, sobbalzi lirici, facili commozioni, rigurgiti di retorica fascista appesantiscono il libro di Lajolo ad ogni pagina rendendolo indigeribile anche ai lettori meglio disposti («Quanti giorni terribili, quante notti terribili, quanti mesi terribili, quanti anni terribili», «La campagna maturava, la terra dava ancora all’Italia il suo pane e i suoi frutti»; «Come un tempo, i fratelli uccidono i fratelli»; «Il volto dell’Italia si sta macchiando di sangue», «Il passo mi moriva allora, lentamente, sulla strada; col passo, il cuore moriva»; «Cerco dentro il cuore uno spiraglio di luce»; «Com’è grigio il mondo. L’inverno continua gelido e la campagna brulla gli prepara uno squallido letto»; «Il canto, con voci maschie e profonde, si propagava nella valle più sacro di una preghiera. Mi sento l’anima piena di coraggio»; «Contro il suo viso bianco di ragazzo morto a vent’anni avevo fatto il mio giuramento»; «Finché venne la sera, tristissima e lenta nelle stelle lucenti»; «Alla guerra partigiana si va in allegria»; «Fuori le stelle sono allegre e la luna ride tutta aperta nel cielo»; «Sale dalla terra un senso di profonda quiete e questa guerra che la sentinella segna nel suo passo crudele ha un contrasto crudele»; «La tristezza ricama gli occhi e fa velo»…).
La cattiva prosa, come la buona, si evolve col tempo: e, dopo qualche pagina di Classe 1912, ci si persuade che Lajolo non abbia rivali nel mostrare ai lettori di oggi che cosa volesse dire scrivere male in Italia attorno all’anno 1945. A rendere il libro più insopportabile è però il misto di cattiva fede e di orgoglio che sembra avere ispirato il narratore – in definitiva, le troppe reticenze sul suo passato che la prosa goffamente fiorita del suo memoriale non riesce a occultare. Contrariamente a quello che si potrebbe credere, Lajolo non era un semplice ragazzo del popolo ingannato dalla propaganda del regime e finito per errore nel tritacarne delle guerre fasciste, come il libro lo presenta al lettore, ma niente meno che il federale di Ancona (fino al 25 luglio 1943!), per giunta veterano della guerra di Spagna, alla quale aveva partecipato in qualità di volontario a supporto delle forze golpiste del generale Franco (un’esperienza raccontata con entusiasmo e retorica fascistissima nel suo libro d’esordio, Bocche di donne e di fucili, 1939). Classe 1912 è concepito così anzitutto come una grande apologia, a giustificazione di un percorso che, secondo Lajolo, avrebbe sempre avuto come stella polare l’amore per il popolo italiano.
L’ingenuità – spiega il narratore – lo ha indotto sì a riporre inizialmente la propria fiducia nelle persone e negli ideali sbagliati (Mussolini e il fascismo), ma lo sfaldamento del regime e la guerra civile gli hanno offerto un’opportunità di correggere la rotta aderendo alle formazioni partigiane prima che l’errore di gioventù diventasse irreparabile. Pur riconoscendo i propri abbagli, Lajolo si mostra insomma persuaso di non essere mai stato troppo lontano dalla verità: nemmeno nei momenti di più convinta adesione al regime. E, affinché non ci siano dubbi in proposito, offre al lettore un lungo dialogo con un membro del Partito comunista, che si conclude con la piena assoluzione dello stesso Lajolo da parte del suo interlocutore (anche lui un ex fascista), che gli confessa:
La nostra tragedia è stata in questo inganno. Da noi non riuscivamo a sganciarci. Io ho avuto più fortuna, ho trovato alcuni che mi hanno parlato di un’altra onestà, di un’altra Italia e sono riuscito a disincagliarmi prima. Tu sei venuto con noi più avanti, ma se ci troviamo ora affiancati nella lotta, se ci comprendiamo, io comunista e tu garibaldino, è perché a questo ci ha finalmente condotti l’istanza d’onestà sincera che era in noi, di amore verso il popolo.
A conti fatti, senza saperlo, Lajolo era insomma sempre stato comunista: anche quando i comunisti andava a stanarli casa per casa e li metteva al muro in Spagna, Grecia, Jugoslavia e Albania. E questo gli permette di ribattere a sua volta, in una generale remissione dei peccati che arriva a coinvolgere tutta la sua generazione (appunto la «classe 1912»): «Penso con rammarico che se potessero risuscitare tanti di quei commilitoni che sono morti nelle guerre fasciste, oggi sarebbero, compresa la realtà e l’inganno patito, con noi e combatterebbero con raddoppiato vigore».
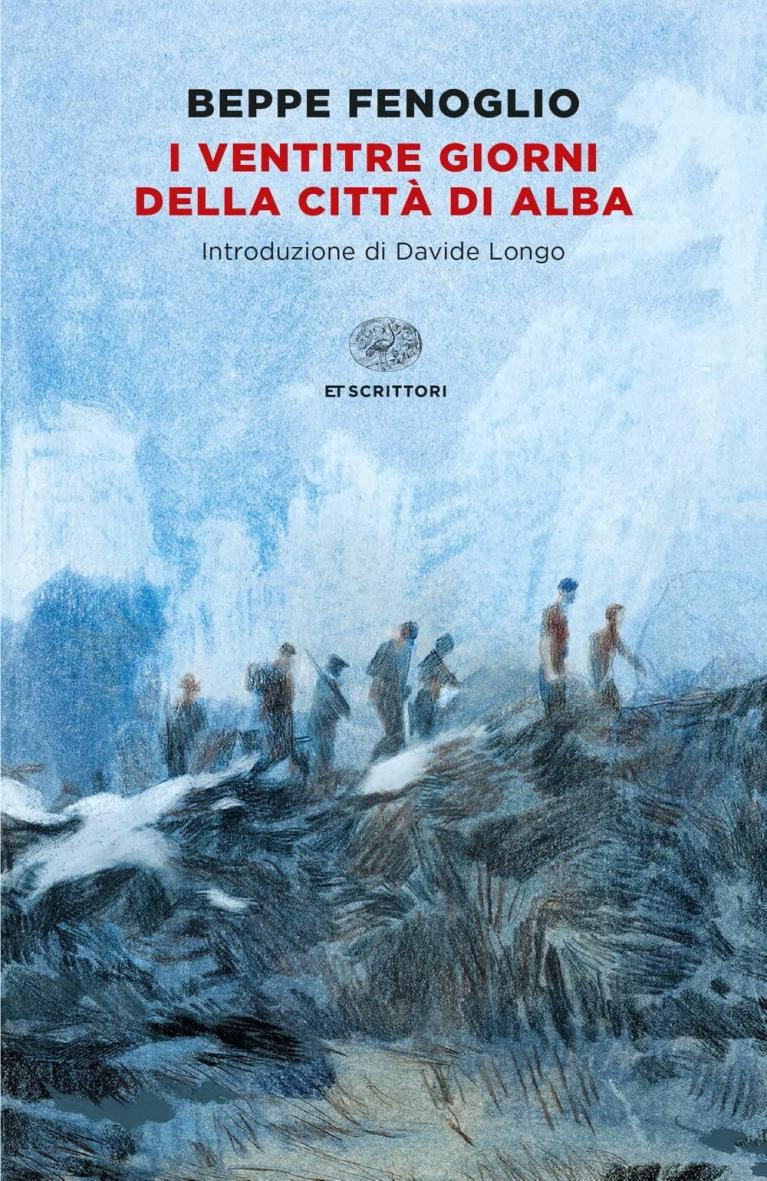
Il coraggio da lui dimostrato nella lotta partigiana spinse nel dopoguerra quasi tutti a perdonare a Lajolo l’iniziale adesione al fascismo, almeno a sinistra (tra il 1958 e il 1972 fu eletto ininterrottamente parlamentare nelle liste del Pci). Comunque si giudichi la sua traiettoria politica, rimane il fatto che Classe 1912 è un libro innaffiato della peggiore retorica, dove, per fare solo qualche esempio, i comunisti muoiono dicendo «Dirò che son stato garibaldino anche al padreterno», e, quando un chirurgo informa uno di loro che occorrerà amputargli un arto, non trova di meglio che commentare: «Certo, perdere un braccio è triste, ma sono un comunista e non ho paura».
Non c’è dubbio: da un punto di vista letterario, sarebbe difficile fare di peggio. Al netto di qualche scivolone – «La neve continuamente si arrossa di sangue partigiano. Ma il sangue cementa di più l’edificio che si sta riedificando e getta nuovo seme per i germogli di domani»; «Quando l’erba sarà cresciuta e coprirà anche la rustica croce, quando sulla montagna e nella pineta tutto sarà silenzio e sola verrà a salutarvi la voce del vento, voi sarete ancora nei nostri cuori» – il racconto di Martini/Mauri generalmente si fa apprezzare invece per la maggiore sobrietà. Mentre a Lajolo piace rappresentarsi in azione, in genere Martini/Mauri opta invece per uno sguardo dall’alto, che glissa sulle vicende individuali (a cominciare dalle proprie) per soffermarsi sulla dimensione più ampia del conflitto: i movimenti delle truppe, gli spostamenti della linea del fronte, le grandi sfide logistiche di un esercito di straccioni. In qualche modo, nel suo caso i suoi ricordi di partigiano si identificano quasi completamente con le scelte del comandante che pianifica la lotta con i nazifascisti su ampia scala; la strategia ha la meglio non solo sulla tattica, ma anche sulla propria biografia.
Questo non toglie che, qua e là, Martini/Mauri dia una sfumatura più personale al racconto, rievocando per esempio la morte di un compagno (la principale fonte di pathos del racconto), l’ansia di un rastrellamento o la propria cattura e fuga tempestiva dalla prigionia (un evento così rocambolesco che nel dopoguerra venne addirittura accusato – senza alcuna prova – di essersi accordato sottobanco con i fascisti per permettere che venissero eliminate le bande garibaldine nell’Albese). L’aneddoto più bello del libro sembra ispirato all’Odissea, e al ritorno a Itaca di Ulisse, quello vero, sotto mentite spoglie: dopo una incursione fascista particolarmente letale, in cui sono caduti molti partigiani, Martini/Mauri e alcuni dei suoi uomini sono accolti con speciale calore da alcuni contadini, che li rifocillano e, non avendolo riconosciuto e credendolo morto nell’attacco, cominciano a tessere le sue lodi senza che nessuno dei presenti li smentisca, perché la voce della sua scomparsa (pensano lui e gli altri partigiani) potrebbe servire a confondere i nemici, finché – del tutto casualmente – la sua identità viene scoperta e, dopo un momento di silenzio, i contadini erompono in manifestazioni di giubilo, e vorrebbero costringere i loro ospiti a ricominciare il pranzo da capo…
Questi sprazzi più personali non tolgono che la vocazione di Martini/Mauri sia un’altra, e che la sua intelligenza brilli anzitutto nelle analisi generali. Con la libertà e per la libertà contiene per esempio pagine magnifiche sulla conformazione geografica del Piemonte meridionale e un’analisi assai acuta dei motivi per cui, nonostante l’alta montagna assicurasse ai partigiani un rifugio in apparenza più sicuro contro le incursioni fasciste, alla lunga le postazioni alpine rischiassero di trasformarsi in una trappola, condannando «alla distruzione le forze vive e migliori del movimento»:
La montagna e le valli hanno esaurito il loro compito. Esse offrono, è vero, delle posizioni dominanti estremamente favorevoli alla difesa, ma è ormai anche provato che di fronte alla strapotenza nemica non c’è posizione e valore individuale che possano tenere indefinitamente.
In questo quadro erano invece le Langhe, «coll’intrico dei loro boschi e dei loro valloni», a offrire l’ambiente ideale per le bande: da cui la decisione di trasferire lì le proprie formazioni dopo aver originariamente operato in altura, nella Val Maudagna, nella Val Casotto e nella zona di Boves. In particolare, la pagina che Martini/Mauri dedica all’analisi dei rapporti di forza nella zona di Alba e al modo in cui la conformazione del terreno, la rete stradale e il gran numero di piccoli centri erano destinati a condizionare il futuro modo di combattere dei partigiani offre probabilmente la migliore introduzione sintetica al conflitto mordi-e-fuggi che il lettore del ciclo di Johnny si vede raccontare così bene da Fenoglio.
Il nemico ha stabilito forti presidi un po’ dappertutto, e non solo nei centri demograficamente più importanti. La «Muti» e la «X Mas» ed altre nere milizie neofasciste pattugliano e scorrazzano ora per le strade già nostra.
A tutto ciò non possiamo reagire se non dotando i reparti di una estrema mobilità.
Ma la mobilità è funzione di due fattori egualmente importanti: il terreno che consenta l’abbandono di una certa linea senza compromettere l’esistenza di tutto il dispositivo, le risorse locali che siano così diffuse da permettere ai reparti di vettovagliarsi là dove si trova.
Le Langhe rispondono perfettamente a tali esigenze.
Tuttavia esse presentano non pochi svantaggi.
La valle, in generale, consentiva di localizzare da un lato solo la pressione del nemico e la montagna, con la sua carenza di comunicazioni, si prestava più al movimento dei partigiani, appiedati e leggerissimi, che a quello delle pesanti colonne nemiche. Per giunta le linee ed i punti obbligati del terreno erano tali che il nemico non poteva che svolgere una azione organica e metodica. Bastava dunque avere la fortuna di intuire in tempo il concetto di manovra dell’avversario per avere la certezza di sfuggire a qualsiasi accerchiamento.
Nelle Langhe, invece, il nemico può sopraggiungere da ogni parte ed avere a sua disposizione una tale rete di comunicazioni e di risorse da permettere i movimenti più sciolti ai suoi reparti, mentre il terreno fuori strada consente un agevole transito ai carri armati.
Non sorprendentemente, Martini/Mauri affronta anche le questioni politiche su questo piano più generale e astratto. Due sono i punti che lo interessano. Anzitutto, un invito alla concordia tra le diverse forze antifasciste che hanno reso possibile la liberazione dell’Italia. Con spirito affine a quello di Piero Calamandrei (il quale avrebbe voluto che la costituzione italiana recasse un riferimento ai caduti della Resistenza in un preambolo che i costituenti preferirono non includere nella carta), Martini/Mauri conclude il proprio memoriale dando la parola ai partigiani morti e facendo pronunziare a loro un accorato appello all’unità (questo sì non immune dalla retorica), di cui vale la pena di riportare almeno le ultime frasi:
Non vi lasciate dividere dalle passioni di parte, non cedete agli allettamenti, ai richiami, alle false lusinghe di chi mira a speculare sui vostri dissensi.
Restate uniti contro chi ci offende, contro la viltà, l’ipocrisia, la vergogna.
Per l’Italia restate uniti, per la nostra Italia.
L’altro punto decisivo per Martini/Mauri (chiaramente legato al primo) è la difesa della scelta di non schierarsi politicamente nemmeno dopo che i partiti che componevano Comitato di Liberazione Nazionale avevano cominciato a promuovere formazioni chiaramente riconducibili alle diverse aree politiche per evidenziare «il contributo apportato da ciascuno» nella lotta antifascista (le «Giustizia e Libertà» del Partito d’Azione e le «Matteotti» del Partito Socialista, mentre i comunisti avevano già le divisioni «Garibaldi»). In questo quadro, a Martini/Mauri preme soprattutto difendere i partigiani «autonomi» dall’accusa di apoliticità.
Perché apolitici? Forse perché non volendo combattere sotto le insegne di un partito piuttosto che d’un altro sentiamo meno degli altri i problemi politici del momento e la necessità di un profondo rinnovamento nella struttura del Paese? O forse che vogliamo rinunciare a partecipare alla lotta politica che tende a dare un nuovo assetto alla Nazione?
No. […] Quando la guerra sarà finiti e vinta, noi, con piena coscienza, daremo la nostra opera alla feconda lotta politica, secondo le nostre inclinazioni.
Prima di allora, però, gli uomini di Mauri sarebbero rimasti soltanto «l’espressione della Nazione nella sua collettività, un vero Esercito democratico senza preferenze di parte».
Se Con la libertà e per la libertà rappresenta la Resistenza delle Langhe dall’alto, La tortura di Alba e dell’Albese coglie piuttosto gli stessi eventi da una prospettiva laterale – tanto più che, come lascia intendere il titolo, al di là della memorialistica personale, il libro di monsignor Grassi si presenta come un’offerta a Dio delle sofferenze patite dalla comunità dei fedeli, secondo un preciso percorso di identificazione collettiva con il calvario e il supplizio di Gesù. Il vescovo della città fu senza dubbio uno dei protagonisti del periodo ma osservò gli eventi da una posizione completamente diversa rispetto a comandanti militari come Lajolo, Martini/Mauri e, a un livello più basso, Chiodi. Da lui non dipendevano soldati. Sulle sue spalle non ricadevano le difficili decisioni della giustizia partigiana.
Nessuna preoccupazione di logistica (le munizioni, l’approvvigionamento degli uomini…) dovette mai sfiorarlo. In pochi, tuttavia, si mostrarono altrettanto solleciti nel tentativo di risparmiare alla popolazione civile le terribili sofferenze che la guerra civile minacciava a tutti, donne e bambini compresi. Come il ciclo di Johnny mostra assai bene, la Resistenza fu costellata di catture di ostaggi, rappresaglie e contro-rappresaglie, fucilazioni di massa minacciate e messe in atto, incendi di paesi, perquisizioni e prelievi indebiti di animali e di derrate alimentari, che spesso infierivano anzitutto sui più inermi. Quando poi un fascista, un tedesco o un partigiano veniva catturato, l’intervento del vescovo poteva rivelarsi decisivo per concordare uno scambio con un parigrado tenuto prigioniero dagli avversari mettendo a frutto la posizione di terzietà che la Chiesa si sforzava deliberatamente di mantenere rispetto ai due belligeranti: e in questi delicatissimi frangenti monsignor Grassi non fece mai mancare la sua assistenza, spesso accollandosi viaggi estenuanti (e non privi di pericoli) per le colline della sua diocesi. L’affetto manifestatogli dalla comunità albese nel dopoguerra è un segno della riconoscenza per il suo straordinario impegno.
Era una posizione difficilissima, ma con grande accortezza il vescovo riuscì a districarsi lo stesso tra mille pericoli: le ripetute richieste del governo ufficiale affinché prendesse esplicitamente posizione a favore della Repubblica di Salò (sempre rifiutate); la tendenza dei fascisti a considerarlo direttamente responsabile per ogni trattativa fallita con i partigiani; le costanti minacce alla propria incolumità (alimentate da un gran numero di lettere delatorie in cui veniva accusato di essere addirittura alla testa del movimento resistenziale); le ripetute violenze contro diversi sacerdoti (spesso imprigionati con i pretesti più diversi, e talvolta addirittura fucilati senza processo dai repubblichini); addirittura un tentativo di farlo cadere in trappola facendogli domandare da un finto partigiano un abito talare dietro al quale nascondersi. Per quanto i nazifascisti gli fossero odiosi (e così appaiano nelle sue memorie), era fuori questione un coinvolgimento diretto della Chiesa.
Come scrisse infatti a guerra conclusa, «a parte ogni sentimento personale, poteva il vescovo schierarsi con una delle parti senza tradire la sua missione?». Il rifiuto di prendere posizione di monsignor Grassi non significò mai, tuttavia, equidistanza, e La tortura di Alba e dell’Albese intende anzi far emergere con chiarezza la differenza tra i partigiani e i fascisti: i primi sempre rispettosi e addirittura deferenti verso l’autorità ecclesiastica (nel caso dei cattolici), i secondi violenti e pronti a rimangiarsi la parola data in spregio di qualsiasi promessa. Nel suo memoriale, così, se si riconosce che anche i ribelli possono aver «talvolta» calpestato «i diritti del giusto e dell’onesto», dei repubblichini si dice invece con la massima chiarezza che indulgevano «dovunque e ogni giorno» in «barbare nefandezze». Una tale inclinazione privata – precisa il vescovo – era peraltro resa ancora più salda dai sentimenti della comunità che si sentiva chiamato a rappresentare e a proteggere:
La verità era che io m’ero proposto di agire nell’ambito della carità per tutti, fuori di ogni quadro politico e d’ogni simpatia; ed era anche un’altra verità che io non potevo disinteressarmi dei partigiani, quando la mia diocesi era partigiana almeno al 90 per 100 e la gioventù atta alle armi era nelle file dei patrioti forse con una percentuale non molto inferiore.
È impossibile stabilire con esattezza quali di questi quattro testi Fenoglio conoscesse al momento di comporre i suoi racconti e romanzi partigiani. Sicuramente deve aver letto Chiodi, come pure Martini/Mauri – non fosse che perché erano stati il suo professore di filosofia del liceo e il suo comandante partigiano (in questo secondo caso una sicurezza giunge dal fatto che il 25 giugno 1947 regalò una copia di Con la libertà e per la libertà a Marco Scaglione, segnalandogli che vi si parlava molto bene del fratello Dario, morto eroicamente).
Degli altri dobbiamo credere che, come minimo, Fenoglio sentì parlare a lungo: troppo scottante era in quegli anni la materia ad Alba perché non arrivassero anche a lui i commenti che se ne facevano in giro e non venisse preso dalla curiosità di sfogliarli. Dopo tutto, quei memoriali parlavano tutti di persone ben note, e rievocavano una serie di eventi luttuosi che negli anni dell’immediato dopoguerra rimanevano ancora inscritti nella memoria locale. Alcuni dettagli dei libri di Lajolo e Grassi potrebbero far pensare però a una vera lettura: in Classe 1912 compare per esempio l’espressione (non comune) «mestiere di partigiano» che ricorrerà anche in Il libro di Johnny, e certi passaggi di Lajolo sulla necessità di far ripartire la lotta partigiana con l’azione, dopo la pausa invernale, ricordano considerazioni analoghe nell’ultimo capitolo del romanzo fenogliano; in Con la libertà e per la libertà è descritta la morte del partigiano Ivan nella difesa di Alba, il 2 novembre, in termini pressoché identici a quelli usati da Fenoglio; mentre in La tortura di Alba e dell’Albese il vescovo dà grande rilievo alla scena dei fascisti che dopo la battaglia entrano in città e vanno a suonarsi «personalmente le campane», proprio come in I ventitré giorni della città di Alba (ma con un doppio senso che nel racconto non si coglie):
E avvenne un fatto ben buffo e pieno di profonda ironia. Non essendo stato possibile trovare il campanaro del Duomo, andarono a suonare tre soldati che, ignari dei nostri usi, mossero assieme le campane nello stesso identico modo che si usa da noi suonarle quando ci sono dei funerali solenni, sicché la poca gente rimasta pensò che s’annunziasse per l’indomani un solenne funerale per i caduti della triste giornata. I repubblicani avevano invece involontariamente suonato in anticipo di sei mesi il trapasso della Repubblica.
Ovviamente nessuna di queste analogie (e delle tante altre che potrebbero essere elencate) offre di per sé una prova decisiva, dato che Fenoglio potrebbe avere benissimo attinto alla memoria personale o al racconto orale di qualche compagno. Il punto importante però è un altro. Alla luce di queste opere, quando si leggono i suoi testi più esplicitamente impegnati dal punto di vista politico – il racconto dedicato ai Ventitré giorni della città di Alba nell’omonima raccolta e il ciclo di Johnny – è impossibile trascurare la sua precisa volontà di inserirsi in questa battaglia di memoria, implicitamente in dialogo, e talvolta in polemica, con i resoconti di quanti lo avevano preceduto (compreso quello di Martini/Mauri, che Fenoglio criticò sempre per la decisione di aver voluto occupare Alba nell’ottobre del 1944, dando inizio a quella che a lui era parsa dall’inizio una grande pagliacciata). La narrativa di finzione è uno strumento per tramandare una visione particolare del passato. E Fenoglio ha scritto i suoi romanzi e i suoi racconti anche per imporre la sua lettura dei venti mesi di lotta partigiana nelle Langhe diversa da tutti coloro che lo avevano preceduto.
Leggi anche
Nunzia Palmieri, Beppe Fenoglio. Corpo
Riccardo Gasparini Geroni, Beppe Fenoglio. Solitudine









