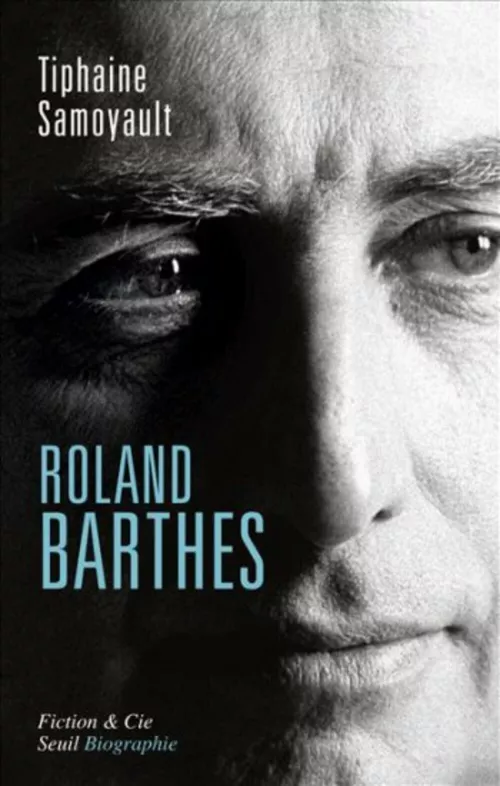Speciale
Roland Barthes, chi era costui?
Incontro Tiphaine Samoyault, autrice della monumentale biografia Roland Barthes (Seuil 2015) in occasione di una piccola maratona barthesiana fra Urbino e Roma, svoltasi sotto una pioggia scrosciante il 23-26 marzo scorsi. Mentre i riduzionisti domenicali si sono precipitati sul centenario di Barthes per liquidarlo con qualche supponente cliché, qui si è optato per una rilettura orientata dal tema della scrittura della storia, caro a Barthes fin dalla sua precoce determinante lettura di Michelet, cui fa ora riscontro il suo stesso divenire personaggio storico.
Se non ha dato luogo a una scuola nel senso istituzionale del termine, Erbé ha però saputo scegliere i suoi amici e i suoi allievi. I quali dalla sua morte, in accordo col fratellastro Michel Salzedo, ne curano il lascito, che si rivela assai più ricco del previsto proprio in occasione di questi cento anni dalla nascita: dopo François Wahl (scomparso alla fine del 2014), soprattutto Eric Marty, curatore dell’Opera Completa uscita in V volumi da Seuil, e poi supervisore di molti inediti, finora gli ultimi Corsi al Collège de France, i seminari all’École Pratique des Hautes Études da cui sono nati i suoi libri più famosi, i Carnet del Viaggio in Cina, il Journal de deuil scritto per sé alla morte della madre… E potrebbe essere solo l’inizio, perché, come racconta appunto Samoyault, Barthes era alla lettera un uomo di scrittura: scriveva, schedava e annotava tutto e sempre, e non solo i pensieri e le letture per i corsi, i seminari, gli articoli e i convegni, ma anche gli incontri e gli eventi quotidiani più minuti. Non compilava solo appositi carnet durante i viaggi, ma ogni giorno un paio di diverse agende – vecchia abitudine protestante – iniziando dal meteo, dal proprio peso e dal proprio umore, che registrava dai tempi del sanatorio. Per non parlare delle cartoline, i biglietti e le lettere agli amici, di cui una corposa selezione, intitolata Album. Inedits, correspondances et varia, sempre a cura di Marty per Seuil, è ora in bozza.
È anche per avere il primo libero accesso a questi archivi personali di Barthes, conservati fra Caen (IMEC) e Parigi (BNP) che Samoyault ha accettato la proposta di Bernard Comment di scriverne la biografia, cinque anni fa. Samoyault, all’inizio della sua conferenza, ci mostra un repertorio di queste diverse scritture, e dei loro diversi supporti: Barthes aveva una vera passione per la cartoleria, carte e cartoncini di varie qualità e colori, penne e pennelli, matite e acquarelli… – tutto ciò che rinvia alla pratica della scrittura nelle sue forme, che non a caso si prolunga in lui, a un certo punto, in una specie di pittura. Se in sanatorio aveva messo da parte più di duemila schede leggendo Michelet, negli ultimi anni aveva iniziato a mischiare, permutare e riorganizzare le sue schede, personali e intellettuali, in un complesso archivio-opera denominato “Grand Fichier”, una sorta di anticipazione visionaria e manuale delle scritture ipertestuali cui oggi ci ha abituato l’uso del computer. Una cifra importante del suo modo di lavorare, questa ricerca sempre nuova del “libro a venire”, che si manifesta con tutta evidenza già a partire da Roland Barthes par Roland Barthes (1975): contro l’Ordine tradizionale del Discorso, delle testualità assestate che in un modo o nell’altro formattano qualche forma di Potere – ecco la scrittura per frammenti, l’organizzazione tabulare degli argomenti e dei pensieri, le successioni lineari in ordine alfabetico, la ricerca di relazioni fra vari tipi di scritture, fra testo e immagine, fotografia e teatro, fisiognomica e pittura, l’istituzione di vari livelli di discorso, delle sue persone e delle sue modalità, l’iscrizione e l’apertura dei margini testuali… modalità, “tecniche” di scrittura parallele a quelle di una lettura radicalmente nuova, anche dei testi più classici, da Racine a Poe, Verne e Balzac, oltre alla triade dei “costruttori di linguaggio” Sade, Fourier, Loyola.

Roland Barthes nel 1975
Tiphaine Samoyault, il cui nome è bretone, nata nel 1968 non è stata allieva di Barthes, e ha letto il suo primo libro, Il piacere del testo, durante un corso di filosofia all’università, trovandolo profondamente liberatorio rispetto ai suoi programmi di studio. Di qui il suo desiderio di saperne di più, anzi forse di saperne tutto, anche per situare il proprio tempo rispetto a un passato così prossimo e così remoto insieme. Ora insegna Letterature comparate a Paris III, ma è al tempo stesso scrittrice: classifica i propri testi come “récit”, categoria di difficile traduzione in italiano, forse “narrazioni”, mai pura finzione. In questo porre la sua scrittura al confine fra i generi e nel radicamento nell’esperienza personale un po’ barthesiana lo è. Non lo è affatto in senso mimetico – per intendersi, non “barthesizza” – e non assomiglia nemmeno a quelle poche ragazze moderatamente decorative e tranquillizzanti che Barthes, a detta dei suoi amici, ammetteva nel suo entourage.
Il suo libro, costato cinque anni di lavoro, è l’ampio documentatissimo fluire discorsivo che risulta da una lunga e sistematica immersione quotidiana nelle carte di Barthes e in tutto ciò che da esse irradia, puntigliosamente ricostruito, comparato e commisurato, rivisto con i propri occhi, come nel caso dei luoghi, ascoltato con le proprie orecchie, come nel caso delle persone ancora viventi che Barthes hanno conosciuto e frequentato. Il compito biografico è assunto con energica determinazione, e l’immagine che avevamo di Barthes a partire dai suoi testi isolati nella forma libro ne risulta in qualche modo saturata, come in un gioco che faccia reagire insieme positivo e negativo, visibile e invisibile. Ne esce anzitutto una vita e il suo valore intrinseco, come ci tiene a sottolineare l’autrice: in realtà quella specifica forma di vita in cui tutto ciò che accade, col senno di poi e con un lavoro certosino di analisi, scomposizione e ricomposizione, smontaggio e rimontaggio, diventa quel “romanzesco senza romanzo” che Barthes perseguiva. Anche la biografia della Samoyault ne è contagiata. L’indice è solo relativamente cronologico, i diciotto capitoli, corredati ciascuno da immagini rare, molte di manoscritti, hanno titoli brevi che fanno pensare alle canzoni della Piaf. Inizia dalla fine e non dal principio, come insegna l’analisi del racconto. E quindi dalla morte di Barthes, in seguito a questo incidente bête che eccede subito il fatto di cronaca e che dà luogo a una mitologia: sarebbe in realtà una specie di suicidio. Una scoperta che emerge dalle sue carte è (invece?) che la lavorazione del libro oggetto indiretto del suo ultimo corso al Collège de France, e cioè il romanzo/non romanzo Vita nova, era molto più di un abbozzo, procedeva con regolare intensità, seguendo le stesse fasi di lavoro dei precedenti libri di Barthes.
La sua vita ordinaria risulta comunque straordinaria, non solo o tanto per gli accidenti biografici – in ogni caso letterari: il nonno esploratore in Africa, il padre che muore in guerra, la tubercolosi che lo affligge da giovane… – ma perché straordinario è anche il momento in cui vive, e di cui riesce a cogliere le centralità. Basta il suo percorso intellettuale, gli incontri e le discontinuità che lo determinano: Barthes e Gide (cap. 4); Barthes e Sartre (cap. 8); Barthes e Sollers (cap. 13); Barthes e Foucault (cap. 16). E molti molti altri ancora, pensiamo solo a Brecht, sul teatro del quale scrive una dozzina di articoli, o a Lévi-Strauss, con il quale non c’è intesa, o ancora a Kristeva, Lacan, Derrida, per citare i soliti noti. Memorabile l’amicizia, nel 1949-50, con un altro grande “marginale”, il lituano Algirdas Greimas, e la comune scoperta di Saussure, mentre sono entrambi a Alessandria d’Egitto con un incarico di ripiego rispetto alla carriera universitaria, per cui non hanno i titoli canonici, e che per la loro scommessa intellettuale è in realtà una fortuna. E dunque, una volta tornati a Parigi, c’è per Barthes un lavoro come lessicologo sulla storia operaia del XIX secolo, e la difficile peregrinazione alla ricerca di un direttore per la tesi di dottorato – su un oggetto atipico come la Moda, un vero sistema semiologico su cui testare la sfida strutturale. Facile dire, seguendo i passi barthesiani fra maestri e istituzioni, letture e scoperte, affetti e relazioni, che è un buon momento, in cui in Francia emergono nuovi metodi e nuovi oggetti di studio – il quotidiano, per esempio, o i consumi; nuove discipline – le scienze umane, dalla semiologia alla sociologia, dall’antropologia alla nuova storia; nuove scuole, nuove riviste e nuovi modi di insegnare e fare ricerca.
Fra le cesure c’è il sessantotto, che turba profondamente Barthes. Un tema che ritorna è l’apparente sottrazione che sembra contraddistinguerlo rispetto ai momenti della grande storia che incrociano i suoi giorni: dalla seconda guerra mondiale, “saltata” per la malattia e che comunque gli costa il padre, alla Guerra d’Algeria, in occasione della quale rifiuta di firmare il manifesto che invita i soldati francesi alla diserzione, al sessantotto, appunto – fino al famoso viaggio con il gruppo di Tel Quel in Cina, sulla quale si esprime al ritorno con una prudenza che la sinistra gli rimprovera. È questo l’unico punto in cui la sua biografa ha un momento di severità nei suoi confronti. Altro che “assentement” nei confronti della Cina maoista, o “fadeur” come suo tratto peculiare: in questo caso avrebbe dovuto denunciare con chiarezza la dittatura, che gli si era manifestata in tutta la sua prosopopea nelle tre settimane di viaggio, dove oltretutto aveva dovuto sopportare Sollers che sul pullmino cantava a squarciagola L’internazionale.
Inutile chiedersi, allora, se dopo la strage del 9 gennaio a Parigi Barthes avrebbe condiviso “Je suis Charlie”. Sarebbe stato troppo facile. Barthes non sopportava in nessun modo i conformismi, le identificazioni generali, viscerali e generiche. Avrebbe, come negli altri casi, cercato una via di riflessione personale, magari più indiretta ma più articolata e complessa, per prendere una posizione che gli appartenesse realmente, nella cui efficacia credesse davvero, a partire da una responsabilità intellettuale nei confronti di sé e del suo mondo che prendeva assolutamente sul serio. Come forse dovremmo fare anche noi.