3 febbraio 1909 - 3 febbraio 2022 / Simone Weil: l'ombra e la grazia
«Twice or thrice had I loved thee/Before I knew thy face or name»
(J. Donne, Air and angels)
Simone Weil fu visitata da un angelo. Accadde durante la Settimana Santa a Solesmes nel 1938, l’anno che per molti segna l’inizio dell’esperienza mistica di Weil e la sua conversione al cattolicesimo. Nella lettera che scrisse a Padre Joseph-Marie Perrin raccontandogli l’incontro, Weil ricorda questo messaggero divino in termini febbrili: per primo le aveva mostrato la «virtù soprannaturale dei sacramenti», trafiggendola con «lo splendore veramente angelico di cui pareva rivestito dopo essersi comunicato». È difficile non immaginarlo avvolto in un manto di luce, il capo cinto da un’aureola di stelle. «Il caso – preferisco sempre dire caso anziché Provvidenza – fece di lui, per me, un vero messaggero», dice senza nascondere l’amore e la gratitudine che prova per lui. Nella sua Vita di Simone Weil (Adelphi, 1994) Simone Pétrement sostiene che questo angel boy – così lo chiamava Weil – si chiamasse John Vernon, ma i dettagli sono incerti. La stessa Pétrement ricorda chiaramente solo una cosa: le «parlò dell’angel boy e della luce che emanava dal suo volto».
La sua apparizione fu il culmine di un periodo violento e straordinario nella vita di Simone Weil. Due anni prima aveva partecipato alla guerra civile spagnola. Si era sempre considerata una pacifista, ma era perfettamente convinta che quando non si può più fare nulla per evitare la guerra l’unica alternativa percorribile è la lotta. Per sua stessa ammissione, Weil non poteva vivere stando nelle retrovie. Superò il confine spagnolo in agosto. Dai racconti che ci sono giunti l’atteggiamento di Weil durante la guerra oscillò selvaggiamente: a volte sembrava una bambina pestifera tutta presa a tentare di intrufolarsi oltre le linee nemiche, altre veniva travolta dall’assurdità di una guerra che perdeva, nel sangue e nel fango, ogni carattere rivoluzionario. Il mondo si faceva sempre più cupo ai suoi occhi ma, ci racconta Pétrement, «mentre pensava che forse [i nemici] avrebbero tagliato loro la ritirata e li avrebbero uccisi, il mondo le era parso straordinariamente bello». La sua esperienza si interruppe bruscamente a causa di quello che Perrin descrive amorevolmente come un «incidente provocato dalla sua mancanza di senso pratico»: infilò un piede nell’olio bollente, procurandosi una profonda ferita.
Passò il resto del 1936 e del 1937 fra la Francia e l’Italia. Un movimento carsico stava erodendo le sue certezze. Le sue posizioni filosofiche erano sempre state radicali e aveva sempre criticato ogni forma di progressismo, specialmente quello marxista. Per lei supporre che il mondo, per qualsiasi motivo, tendesse più o meno naturalmente al bene era un eccesso di sentimentalismo. Era più materialista dei materialisti; in questo mondo non c’è né bene né male, la natura è indifferente e la società non migliora da sé. Il progresso è un’illusione che vela la verità del mondo, e lo mantiene immobile. La libertà si conquista lottando con i più deboli, chi viene schiacciato dalle violenze dei forti, e sottraendosi al potere in tutte le sue forme: lo stato e i suoi partiti, la polizia, le fabbriche, tutte le meschinità che ci infliggiamo quando ci riconosciamo in un “noi”. Ma in questi anni Weil scoprì lentamente, dolorosamente la vera radice della sua radicalità. Scoprì la natura profonda della libertà per cui voleva lottare. Quando incontrò il suo angelo, questa scoperta divenne una vera e propria rivoluzione interiore.
Nel frattempo, la sua salute peggiorava. Le sue crisi emicraniche diventavano sempre più pesanti. Le sue piccole catastrofi cognitive l’avevano perseguitata da quando aveva dodici anni, ma la loro frequenza continuava ad aumentare facendole odiare il suo stesso corpo. Scriverà qualche anno dopo all’amico e poeta Joë Bousquet di essere: «[…] abitata da un dolore localizzato intorno al punto di congiunzione dell’anima e del corpo». L’incontro con il suo angelo accade in un periodo nero, di profondo dolore. Quando lo raccontò a Padre Perrin confessò subito: «Avevo intensi mal di testa; ogni suono mi faceva male come un colpo […] un estremo sforzo di attenzione mi consentiva di uscire fuori dalla mia miserabile carne, di lasciarla soffrire sola, rannicchiata in un angolo, e di trovare una gioia pura e perfetta nella inaudita bellezza del canto e delle parole».
Questa bellezza, però, era entrata nella sua vita.
Per capire il dono che le fece l’angelo bisogna riconoscere l’ombra lunga, demoniaca che trascinava con sé. La sua apparizione fu accompagnata, infatti, da un gemello oscuro. Weil lo soprannominò devil boy, rendendo manifesto sin da subito quanto, per lei, l’illuminazione che le avevano regalato fosse prodotta dalla loro sizigia. Il nome del demone era Charles Bell, studioso di letteratura inglese. Nel suo unico libro sopravvissuto all’oblio, The half gods, lo stesso Bell ricorda l’incontro con Simone Weil come un evento che lo colpì profondamente, che lasciò un marchio indelebile sulla sua vita. Secondo alcuni, John Vernon, il nome dell’angelo, altro non era che lo pseudonimo di Charles Bell. L’angelo era la luce soprannaturale che sfuggiva dalla sua carne. Certamente, il dono che entrambi le concessero fu identico: una nuova conoscenza.
Le due figure introdussero nella sua vita una sapienza che Weil aveva fino ad allora ignorato. Angel boy le portò le opere metafisiche dei poeti inglesi del sedicesimo secolo. John Donne, certamente, ma soprattutto George Herbert, autore di una poesia semplice dal titolo Love. Weil la imparò subito a memoria, la ripeté costantemente fra sé e sé. Solo dopo un po’ di tempo si accorse di star facendo una profonda esperienza di preghiera, che quelle parole le stavano mostrando una luce che i suoi occhi non avevano mai avvertito prima d’ora. La poesia di Herbert aveva squarciato il cielo e le aveva dischiuso un mondo che nulla ha a che vedere col nostro. Al contrario, devil boy la tenne ben piantata per terra. Arricchì la sua esperienza dell’universo umano e dei suoi intrighi. Le donò il Re Lear di Shakespeare che divenne per lei, insieme all’epica della forza dell’Iliade e le storie più sanguinose dell’Antico Testamento, una chiara rappresentazione della fisica di questo nostro mondo: dei suoi meccanismi, delle sue meschinità, delle sue forze.
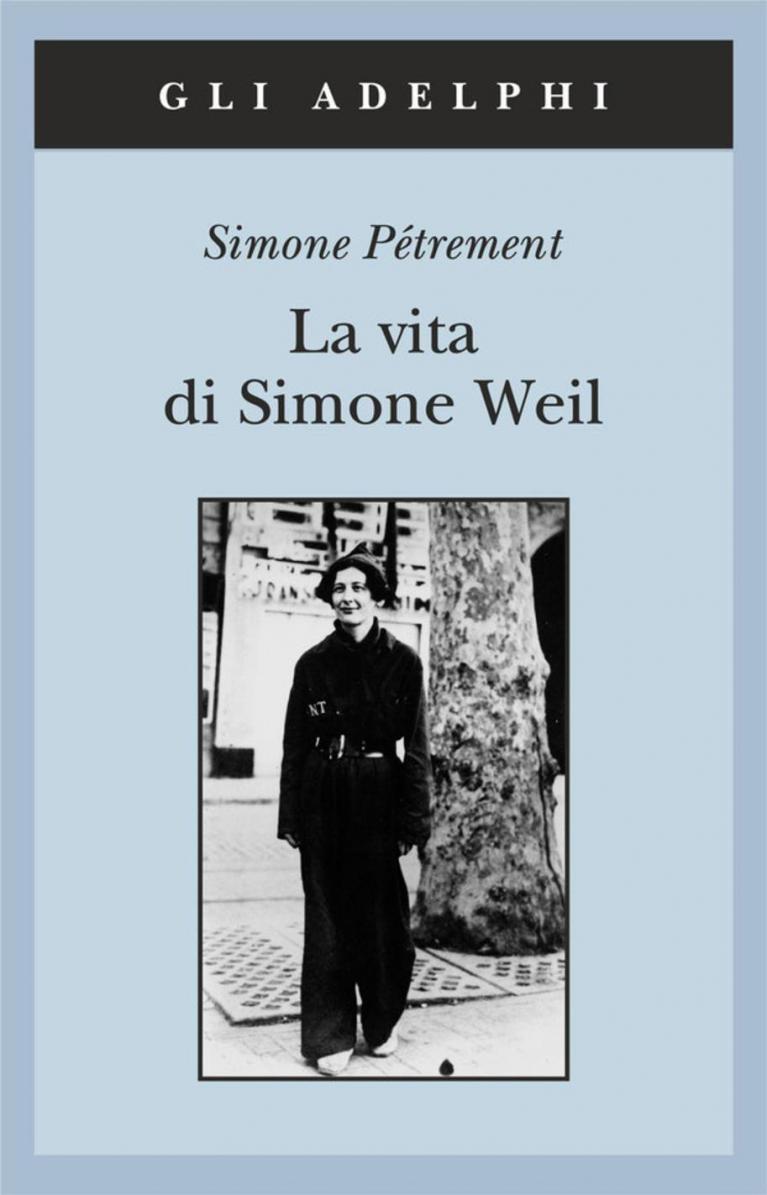
Questi due universi non furono un affare semplicemente teorico o letterario per Weil. Al contrario, gli anni che seguirono questo incontro furono segnati dal tentativo di tenere insieme questi due spazi totalmente eterogenei, il luogo preternaturale della luce e dell’amore e quello fisico della carne e delle forze. Queste nuove conoscenze la portarono ad abbracciare completamente ed esplicitamente quello che lei stessa definiva un dualismo platonista, basato sull’idea che il mondo dell’amore, sostanza impersonale e libera, non appartenga al mondo fisico in cui lottiamo ogni giorno, fatto di vincoli, meccanismi, trappole. Si potrebbe dire, senza timore di smentita, che il resto della vita di Simone Weil fu speso nell’affannoso tentativo di tracciare i contorni di questi due spazi e di cercare con tutta sé stessa i rari punti in cui la luce di quel Grande Fuori soprannaturale riesce ad aprirsi un varco fra le forze mortali e le interrompe. Dopo essere caduta davanti al suo angelo e al suo demone, cercò in ogni modo di cicatrizzare lo strappo fra due regni che non comunicano: questo mondo, e l’altro.
Testimonianza lampante di questo sforzo sovrumano è sicuramente L’ombra e la grazia, antologia di passi scelti da Gustave Thibon dei diari intimi che Weil scrisse fra il 1940 e il 1942. Nella sua veste italiana, fra l’altro, è specialmente e manifestamente una creatura esemplare del terribile dissidio, sin dal titolo. Nella sua edizione originale il libro porta il titolo La pesanteur et la grâce, che si potrebbe tradurre come la gravità e la grazia. Un titolo che rimanda certamente a due leggi, l’inesorabilità della legge di gravità e le vie misteriose della grazia, che operano in modi assolutamente diversi, che, però, non implicano necessariamente un’aperta contraddizione. Il titolo italiano, scelto dal traduttore Franco Fortini e riproposto nel 1951 per Edizioni di Comunità, nel 1985 per Rusconi, nel 2002 per Bompiani e poche settimane fa per SE Edizioni, evoca, invece, immediatamente un universo diviso nettamente fra luci e ombre – un cosmo manicheo, gnostico, in cui la grazia è metafisicamente estranea al regno delle ombre. Come ammette lo stesso Fortini: «Ombra, senza dubbio, tradisce la corporeità del sostantivo [nda. pesanteur]; spiritualizza, disincarna, è poeticistico.
Ma è anche associato al contrasto luce-buio, rivelazione- tenebra». Una scelta coraggiosa che rispecchia il senso profondo di queste pagine dolorosissime, scritte in bilico fra la sua rivoluzione interiore e la morte. Una scelta che, in fondo, rende giustizia a un libro che risulta a tutti gli effetti un trattato di etica austero, radicale, struggente scritto per chi pensa che la giustizia non abbia nulla a che fare con l’umano e che la verità stia altrove.
Come gli amanti sublunari di John Donne, l’autrice di L’ombra e la grazia girovaga in un mondo in cui competono due leggi, la fisica, fatta di distanze e pesi, e l’amore stellare che la costringe a rispondere a leggi esterne a questo universo. Nelle primissime pagine, infatti, Weil descrive immediatamente un universo spezzato in due, irrimediabilmente scisso in due parti quasi completamente discoste, che comunicano solo in momenti assolutamente eccezionali. «Due forze regnano sull'universo: luce e pesantezza».
Da un lato, il mondo fisico, da descrivere con il materialismo più intransigente: tutto ciò che possiamo trovare qui sono leggi prive di senso, forze che si attraggono e repellono, frizioni e armonie comprensibili solo nella maniera più fredda e deterministica possibile. A questo punto le era più chiaro che mai: non c’è bene o male in questo mondo, solo le regole e gli accidenti della materia cieca. Il suo Dio creò questo modo senza alcuna morale: «La necessità inflessibile, la miseria, le difficoltà, il peso agghiacciante del bisogno e del lavoro che sfinisce, la crudeltà, le torture, la morte violenta, la costrizione, il terrore, le malattie – tutto ciò è amore divino». Anche i rapporti sociali che occupano le ore e i giorni della nostra specie non sono altro che movimenti meccanici in questo regno delle ombre; rapporti fra forze inesorabili quanto la legge della gravitazione e i moti degli astri e le maree. Tutta la nostra vita si svolge nelle grinfie delle macchinazioni della «meccanica umana». «Tutti i moti naturali dell'anima sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale».
Dall’altro, unica eccezione fra le leggi prive di senso della nostra fisica, la grazia. Non dobbiamo però pensare che la grazia sia per Weil una sorta di consolazione divina, un’isola felice che appare fra le regole draconiche del mondo. La grazia per Weil ci appare solo come una «notte oscura», un vuoto incolmabile, che i nostri occhi riescono a malapena a vedere. La grazia è una fiamma aliena che destituisce ogni necessità materiale e ci espone all’amore più straziante e insensato, spingendoci fino in fondo, deracinando completamente la nostra vita e facendoci provare sulla pelle la presenza della morte e del nulla nero pece. «Il vuoto è la suprema plenitudine, ma l'uomo non ha il diritto di saperlo». La grazia, e il regno da cui proviene, è l’esperienza interiore più luminosa e l’assenza più dolorosa, toccata solo nell’incontro sconvolgente con il proprio angelo e con l’amore che necessariamente ne consegue.
Allestito questo palcoscenico e superata la nausea e la vertigine che un paesaggio del genere non può che creare, Weil sposta la sua concentrazione sul vero problema che la tormenta: come vivere nella consapevolezza di questo amore, di questo vuoto?
Come mantenersi, in altre parole, fermi nella grazia, senza che una luce del genere ci strappi la vita dal petto? E come riuscire a stare in equilibrio sul solco dello strappo fra i due regni? Un problema che, al di là delle nostre particolari sensibilità religiose, interessa tutti, senza eccezione. Le convinzioni del lettore sono un fatto contingente e di poco conto davanti all’immensità della questione. Dopotutto, ciò che l’etica di Weil esplora sono esperienze estreme, contrarie ad ogni buon senso, che capitano quotidianamente anche a chi abita sotto un cielo vuoto: l’amore che corrode come malattia, i morsi del desiderio e la morte che simuliamo nelle nostre teste quando proviamo a immaginarci sotto qualche metro di terra. Lei stessa invita a praticare un «ateismo purificatore» per capire davvero di cosa sta parlando, al di là di ogni consolazione e preconcetto.
La risposta che lei si dà è sconvolgente: «Il peccato in me dice “io”». Per Weil, l’unica via percorribile davanti all’immensità della grazia e alle richieste insostenibili dell’amore è spogliarsi di sé stessi, della propria umanità, percorrendo un via più radicale di qualsiasi post-umanismo contemporaneo, e accogliere ciò che ci chiama, senza esitazioni. «Amate come il sole illumina», dare tutto il proprio cuore al silenzio. Non c’è davvero modo di restare sé stessi davanti alla luce che preme oltre i confini del nostro mondo, l’unica etica davanti all’amore dischiuso dalla grazia, per Weil, è la resa e la fede assoluta in quel vuoto incolmabile che ci brucia nel profondo. Farsi totalmente trasfigurare, fino a lasciarsi da parte. Weil chiama questa resa decreazione, che non è una distruzione ma un chinare il capo davanti alle lacerazioni della grazia.
A ben guardare, Weil sostiene, specialmente in L’ombra e la grazia, un filone sotterraneo che ha attraversato tutta la storia del pensiero Occidentale da Antigone in giù: amare i propri morti seguendo una ragione priva di alcuna ragione, una legge che sta al di là della legge degli uomini.
Questo non significa, però, negare il mondo o vivere in assoluto ascetismo. Ciò che rende quest’etica dell’abbandono all’amore interessante, o, quanto meno, un’opzione degna di nota anche per chi non condivide lo strano cattolicesimo, a tratti vagamente doloristico, di Weil, è, anche al culmine del suo aspro gnosticismo, il suo radicarsi nelle cose del mondo. È un’etica dell’abbandono innanzitutto davanti alla vera natura delle cose e delle persone, nella loro fragilità, forza e, soprattutto, finitudine. È un’etica che ci costringe a vivere la fine, la morte, l’assenza di ciò che si ama come doni straordinari, che sciolgono i legami fisici di quanto ci è più caro. Ci impartisce una disciplina preziosa: amare chi abbiamo perso, perché ci ha liberati dal peso del mondo. «Distruzione di Troia. Caduta di petali dagli alberi da frutto fioriti. Sapere che le cose più preziose non sono radicate nell'esistenza. Saperlo è bello».
Poco prima della sua morte, Simone Weil scrisse questo nella sua prima lettera a Joë Bousquet: «A pochissimi spiriti è dato scoprire che le cose e gli esseri esistono». C’è qualcosa di profondamente violento in queste parole. La lettera è del 13 aprile del 1942, scritta da una donna che vede la sua vita travolta di nuovo dalla guerra. Sin dalle prime battute l’apprensione che attanaglia Weil è soffocante: «Devo chiederle poi di non tardare troppo a mandarmi la lettera di cui abbiamo parlato; è possibile che io parta fra pochi giorni». La lettera è indirizzata a un uomo che a soli ventun anni fu paralizzato da una pallottola nel ventre. Un poeta a cui il destino diede in sorte l’essere ricordato per aver passato buona parte della sua vita nella stessa stanza, senza mai aprire le imposte delle finestre. Eppure, nella lettera non c’è nemmeno un sospetto di abbattimento o commiserazione. Ci si trova solo la veemenza di due cospiratori, uniti da uno stesso impegno: «È questo, ai miei occhi, l’unico fondamento legittimo di ogni morale; le cattive azioni sono quelle che velano la realtà delle cose e degli esseri oppure quelle che assolutamente non commetteremmo mai se sapessimo veramente che le cose e gli esseri esistono». Al di là di questo mondo, amore angelico e senza riserve.
«E loro mi troveranno lì/ed essi vivranno/ed essi non moriranno di nuovo»









