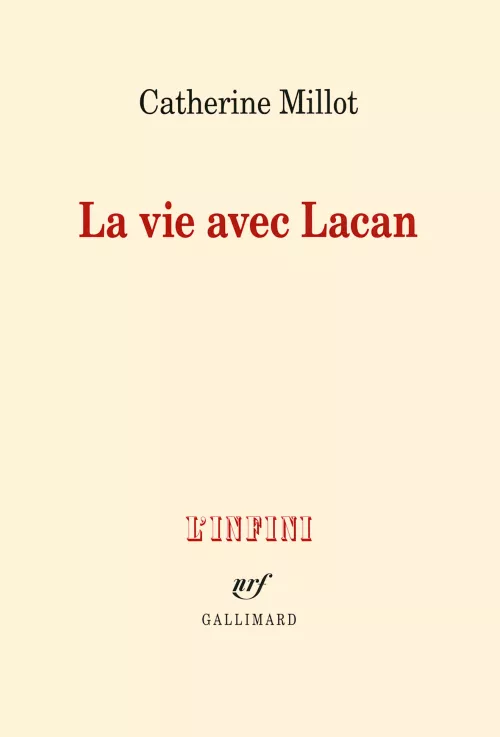Catherine Millot “Con Lacan, la vita" / L'enigma Lacan (guidatore spericolato)
Il film celeberrimo di Orson Welles Citizen Kane (Quarto potere) si snocciola come una ricostruzione biografica. Un giornalista deve ricostruire la vita del magnate della stampa e tycoon Charles Foster Kane, giusto dopo la sua morte. Il giornalista compone una sorta di puzzle intervistando varie persone che hanno condiviso parte della vita di Kane. Le molteplici testimonianze vengono a comporre un’immagine sfaccettata del personaggio, ma il giornalista vuole capire soprattutto perché prima di morire Kane abbia pronunciato la parola rosebud. Chi o che cosa era questo Rosebud? Questo significante sembra indicare un pezzo mancante nel puzzle.
Rosebud letteralmente significa bocciolo di rosa, ma viene usato anche come bocca di rosa, una bocca con labbra delicate e rosee. Come orifizio con mucosa, il termine evoca anche le piccole e grandi labbra della vagina. Rosebud sembra insomma riferirsi a una donna, ma è anche significante di qualcosa che in francese si chiama béance, ciò che resta aperto come una vena tagliata o una bocca socchiusa. Il giornalista non scoprirà nulla, la rivelazione finale – un MacGuffin come si dice nel cinema – è riservata allo spettatore, una rivelazione che però lascia aperta la domanda sul significato ultimo di quel significante pronunciato sull’orlo della morte.
Mi sono ricordato del film di Welles dopo aver letto Vita con Lacan (La vie avec Lacan) di Catherine Millot (Raffaello Cortina editore). Costei, psicoanalista e scrittrice, negli anni ‘70 fu amante, allieva e compagna di Lacan. Tra loro c’erano 43 anni di differenza, e l’autrice nota che oggi scrive questo libro avendo l’età che aveva Lacan quando lei l’aveva conosciuto, attorno ai 72 anni. Questa di Millot è una testimonianza sulla sua esperienza personale con Lacan. Che si aggiunge a varie altre testimonianze, pubblicate nel corso degli anni da parenti amici allievi o analizzanti di Lacan, da prospettive tra loro diverse, a cui bisogna aggiungere la lunga biografia di Lacan scritta da Elisabeth Roudinesco. Abbondano aneddoti anche gustosi, altri più o meno immaginari, sul personaggio Lacan. Dobbiamo mettere queste testimonianze una accanto all’altra, un po’ come fece il giornalista di Citizen Kane, se vogliamo costruire il puzzle Lacan. Ma ci resta un rosebud a cui dare risposta? Penso di sì. Insomma, per me c’è un enigma Lacan.
Vari amici, che stimo, mi hanno detto che questo libretto secondo loro non vale granché. Mi chiedo che cosa abbia potuto motivare questo giudizio severo. Un libro-testimonianza deve il suo interesse non al fatto che sia scritto più o meno bene, che sia più o meno profondo, ma al fatto che testimoni appunto, che ci informi su aspetti a noi ignoti di una vita. Certi lacaniani aborriscono gli scritti biografici su Lacan in genere, “sono solo pettegolezzi” dicono, ma in fondo ogni storiografia è una forma di pettegolezzo. E la stessa analisi appare in qualche modo un pettegolezzo su se stessi, un tradurre in parola qualcosa di intimo e inconfessabile. Forse alcuni vorrebbero che di Lacan si scrivessero non biografie ma agiografie. Le biografie serie comportano sempre un alone di demistificazione, e posso capire che chi vota a Lacan una forma di culto della personalità non possa accettarle.
A me interessano invece anche i “pettegolezzi” su Lacan perché, come la psicoanalisi insegna, le teorie psicoanalitiche non sono il prodotto di menti disincarnate, ma di soggetti particolari con la loro storia, il loro inconscio, le loro ferite. D’altro canto è vero che ogni biografia fa appello al nostro voyeurismo. Al limite, ci saremmo aspettati che Millot ci parlasse anche dei suoi rapporti sessuali con Lacan, o dei suoi rapporti con la moglie di Lacan Sylvia, perché no? Ma più ne sappiamo di uomini e donne eminenti, più un tarlo, simile a Rosebud, ci assilla: resta sempre qualcosa che ci sfugge, una sorta di buco. Insomma, chi era veramente Lacan?
Di Lacan colpisce un comportamento che i suoi più intimi mettono in evidenza: il suo modo di guidare l’auto. Correva oltre i limiti di velocità, non dava la precedenza, passava col rosso, prendeva anche la corsia d’emergenza pur di superare un ingorgo, insomma metteva a repentaglio la vita propria e di chi gli stava accanto. Anche se un altro guidava, di fronte a semafori rossi si spazientiva subito e talvolta usciva dall’auto. Questo anarchismo automobilistico sorprende perché Lacan è stato, tra tutti gli psicoanalisti, quello che ha dato più peso al ruolo della legge nell’inconscio e nel destino individuale. Per Lacan, come per S. Paolo, la legge non è un ostacolo posto al nostro desiderio, è anzi la condizione del desiderio stesso, ciò che lo costituisce e lo sferra. Ora, come vedere il fatto che il teorico della legge non tenesse in alcun conto la legge più banale, il codice stradale? Cogliamo qui una discrasia tra la teoria e la vita?
La trasgressione, appunto. Non credo sia un caso che Lacan sia venuto in rotta di collisione con l’International Psychoanalytic Association – l’organizzazione ufficiale e più antica degli psicoanalisti – non per il contenuto del suo insegnamento, ma per ragioni direi fiscali: il fatto che facesse sedute a tempo variabile (e non a tempo fisso, di solito 45 minuti, come fanno gli analisti ortodossi) e che queste sedute fossero di solito troppo corte. Non c’è nulla di male in sé nell’ideare una nuova tecnica analitica, nel fare sedute corte, ma trovo significativo che la rottura sia avvenuta perché Lacan non rispettava il codice del setting analitico. Ritroviamo questo suo rapporto problematico con “le regole” in molti altri comportamenti, in particolare nel fatto che abbia preso Catherine Millot come sua amante quando era ancora sua analizzante e allieva.
Lo stesso Lacan racconta quando incontrò il famoso psicoanalista austriaco Ernst Kris al congresso psicoanalitico di Marienbad nel 1936 (“La direzione della cura”, Scritti). Il giovane Lacan gli disse di voler andare poi alle Olimpiadi di Berlino, che si tenevano allora. Il punto è che queste dovevano essere le Olimpiadi di Hitler… E Kris, ebreo, gli disse in francese “Cela ne se fait pas!”, “Questo non si fa!” Lacan ci andò lo stesso.

Appunto, cela ne se fait pas. Non si passa col rosso, non si va a letto con le pazienti, non si fanno sedute eccessivamente corte, si deve dare la precedenza in strada… E dico questo non per gettare l’anatema su Lacan, tutt’altro. Piuttosto per dire che Lacan era un dandy.
Nessun biografo o testimone di Lacan, a quanto io ne sappia, ha presentato Lacan come un dandy. Forse perché i grandi dandies – Baudelaire, Oscar Wilde, Raymond Roussel, ecc. – non ci appaiono eticamente corretti. Essi si escludevano dai valori e dai gusti della massa, vantando la loro libertà rispetto alle regole che valgono per la gente comune, ovvero per i mediocri. Ora, sembra che la fascinosa arroganza del dandy non possa conciliarsi con la psicoanalisi, che è pur sempre, lo si riconosca o meno, un’attività di cura, di aiuto, un servizio alla persona. Può essere il dandy un filantropo, o semplicemente un medico? Millot sottolinea come Lacan facesse sentire la gente comune a proprio agio, come sapesse interloquire bene con gli psicotici; insomma, sapeva aiutare. E poi, quando si ha quel fascino misterioso che oggi chiamiamo carisma, si riesce ad aiutare meglio il prossimo che quando non lo si ha.
Il dandy, dunque, si sente libero. Ora, si dà il caso che Lacan abbia sempre disdegnato di predicare la libertà, cosa che lo separa nettamente da Sartre, il filosofo della sconfinata libertà dell’essere umano.
Quando una giornalista televisiva gli chiese qualcosa sulla libertà, Lacan si mise a ridere e alla fine disse “Io non parlo mai di libertà”. Non ne parlava, ma la praticava, anche a costo di rompersi l’osso del collo.
Millot accenna all’allievo di Lacan Giacomo Contri, traduttore degli Ecrits, e qui lei commette un errore. Dice che Lacan era esasperato dal fatto che Contri avesse chiamato Comunione e Liberazione la sua scuola di Milano. In realtà Contri aveva chiamato il suo gruppo Scuola freudiana (di cui io stesso feci parte per qualche anno), ma era anche membro del movimento Comunione e Liberazione che noi italiani conosciamo bene. Di fatto Lacan rimproverava a Contri la sua adesione all’integralismo cattolico. In un incontro a Milano con gli allievi di Contri, disse che i due significanti “comunione” e “liberazione” erano profondamente estranei al suo insegnamento, che certamente non era catto-comunista. In particolare, l’analista non è mai libero: “Non si può dire che il mio discorso vi prometta una liberazione da alcunché, perché si tratta, al contrario, di incollarsi alla sofferenza delle persone…” (Lacan in Italia/En Italie Lacan, La Salamandra, 1978, p. 122).
Scrive Millot: “A un transessuale che rivendicava la sua qualità di donna, non smise di ricordare durante il colloquio il fatto che era un uomo, che lo volesse o no, e che nessuna operazione ne avrebbe fatto una donna” (p. 42). Ecco una posizione che oggi apparirebbe retrograda, che il movimento LGBT contesterebbe. Oggi prevale la concezione per cui il proprio gender è qualcosa che ci si assegna, non qualcosa che si è oggettivamente. Ma appunto, egli non compiaceva l’ideologia liberal secondo cui si deve essere liberi di essere quello che si vuole, con l’aiuto anche della chirurgia e della tecnologia. La retorica della liberazione, che all’epoca andava per la maggiore sia a sinistra che a destra – “è proibito proibire”, la teologia della Liberazione, ecc. – gli era del tutto estranea.
In effetti, all’epoca altre teorie si contrapposero a Lacan rivendicando, sulla scia del ’68, una liberazione incondizionata: era il caso dell’apoteosi orgasmica di Wilhelm Reich, o delle macchine desideranti di Deleuze e Guattari, o della critica liberatoria da parte di Jean Baudrillard… Rispetto a queste filosofie di esaltazione della libertà del desiderio, il pensiero di Lacan appare un dolente richiamo al determinismo in cui l’essere umano è preso.
Eppure Lacan si sentiva libero da ogni regola. Quindi, il suo pessimismo sulla libertà era solo una faccia della medaglia, l’altra era quella di una liberazione direi in extremis che nasce proprio da una sorta di sottomissione inaugurale. Lo si può così accostare ad Antigone – su cui tenne bellissimi seminari – l’eroina che si ribella alla legge della città per seguire la propria legge, la legge del proprio desiderio.
Perché le trasgressioni di Lacan erano contro le leggi di Creonte – dalle sedute standard dell’IPA fino ai semafori rossi – per affermare un’altra legge, quella del desiderio. “Ci si sente colpevoli – diceva – quando si cede sul proprio desiderio”. Egli non voleva cedere sul proprio desiderio. “Per lui, non c’erano piccoli desideri, la minima voglia era già sufficiente” dice Millot (p. 69), comprese le voglie delle persone che amava, voglie che doveva soddisfare subito, senza mai rimandare all’indomani ciò che poteva essere fatto immediatamente.
Non a caso in gioventù fu amico di surrealisti, tra i quali Dalì, anche se Millot preferisce definirlo “dadaista”. E forse non a caso sposò la ex moglie di Georges Bataille, che possiamo considerare il massimo filosofo libertario. È proprio negando teoricamente la libertà umana, come fece Lutero (De servo arbitrio), che la si deve praticare, in modo ingenuamente disperato.
Lacan voleva sempre godere di tutto: delle donne, del danaro, del sapere, del pensare. Insomma, di Lacan non si può dire affatto che fosse saggio – in barba al pregiudizio secondo lui l’analista deve essere un campione di saggezza. Lacan esprimeva piuttosto una straordinaria vitalità, una passione quasi futurista per il movimento, gli sport, la velocità, i viaggi. Una vitalità quasi infantile, che Lacan stesso riconosceva quando diceva che aveva l’età mentale di un bambino di cinque anni. In fondo, quel che alla fine decide tra chi è semplicemente intelligente, anche molto intelligente, e il genio è proprio la vitalità, l’energia. Lacan non aveva bisogno di amfetamine, come Sartre che ne prese a bizzeffe, per essere sempre un po’ su di giri. E in effetti, come Erik Porge, potremmo interpretare il titolo del libretto di Millot come “Con Lacan, la vita”.
Questa vitalità si esprimeva anche nell’opposto del movimento: Lacan passava lunghe ore assorto, silenzioso, immobile. Questo vuoto immoto che faceva attorno a sé, in casa, assorbito dalle sue riflessioni, esprime in realtà la vitalità del suo pensare, che, frustato dall’urgenza di una soluzione forse impossibile, lo inchiodava. Un correre veloce per la vita che però si dirigeva dritto verso la morte, e non nel senso che ciascuno di noi deve morire. Dopo aver avuto la diagnosi di cancro all’intestino, Lacan rifiutò di curarsi. E alla figlia che gli chiedeva perché, rispose “Così, per capriccio”. Un’ombra di quasi-suicidio plana così su di lui; e gli stoici dicevano che il suicidio è uno dei pochi atti veramente liberi che l’essere umano possa permettersi.
Chi è molto vitale, non teme la morte. E Millot insiste sulla impavidità di Lacan. Una volta, mentre faceva una supervisione, dei ladri entrarono con le pistole puntate chiedendogli soldi; ma lui si rifiutò assolutamente di darglieli. Quando la morte gli si presentava davanti, non la fuggiva.
Come il dandy, pagava il prezzo di una solitudine di fondo. “Non c’era mai un ‘noi’, c’era lui, Lacan, e c’ero io che lo seguivo… D’altronde se a me il ‘noi’ non è mai stato congeniale, a Lacan era del tutto estraneo… La sua profonda solitudine, il suo apartismo [sentirsi “a parte” rispetto agli altri] rendevano il ‘noi’ qualcosa di fuori luogo” (p. 19). Il ‘noi’ è quella dimensione di comunione che, come abbiamo visto, rimproverava agli emuli di don Giussani. Perciò non credeva nel comunismo, e sono allergici a Lacan quelli che praticano l’analisi di gruppo. Freud si era occupato della dimensione del ‘noi’ in Psicologia delle folle e analisi dell’Io, in cui descrive ogni Mass, ogni collettivo, ogni ‘noi’, come qualcosa di essenzialmente fascista. Perché l’unità nel ‘noi’ presume sempre un Führer, un leader, una sorta di alienazione del desiderio in lui. Come ha potuto Lacan fondare allora una scuola quasi di massa di cui lui era il capo indiscusso? Il fatto che poco prima della sua morte l’abbia sciolta ci dice però che non era fatto per il potere sulle folle. “Aveva con l’esercizio del potere un rapporto che definirei minimalista” (p. 52).
Qual era allora il rosebud di Lacan? Direi proprio averci detto che ogni esistenza singolare – anche la propria – gira attorno al mistero di una bocca socchiusa che si presenta come dolcissima. Egli era a un tempo Kane con il suo buco e il giornalista che lo cerca. Quell’enigma che Lacan è per noi, è il suo modo di girare attorno a quell’enigma che ogni essere umano, anche per se stesso, è. In fondo, ha indicato sempre un buco fondamentale che rompe la coerenza del soggetto-organismo. Una beanza – se mi si permette questo neologismo – nella teoria psicoanalitica, certo, anche nella propria teoria, che però a sua volta esprime una beanza fondamentale dell’essere umano. Come ci ricorda Millot, chiamò l’essere umano “il singolare”, separandolo dal particolare. Egli cercava una singolarità senza senso con cui ciascuno di noi deve confrontarsi.
In fisica si chiama singolarità ogni fenomeno per cui le leggi della fisica normale cessano di valere, come nei buchi neri. Lacan pensava che il fondo di ciascuno è qualcosa di “impossibile” per il quale non valgono le nostre leggi e che lui chiamava il Reale, un buco nero che lo ha polarizzato negli ultimi anni.
Allora Lacan fu completamente assorbito, direi assillato, dai nodi borromei. Si tratta di un numero indefinito di anelli – minimo tre – allacciati in un certo modo che, se se ne taglia uno, tutti gli altri risultano liberi.
Millot ci ricorda che gli spaghi per fare catene borromee avevano ormai invaso le due case di Lacan. Negli ultimi tempi, nei suoi seminari si limitava a disegnare sulla lavagna anelli e nodi sempre più complessi, in silenzio; quasi non parlava più.
Non discuto qui l’eventuale utilità dei nodi borromei nella pratica e nella teoria analitiche; ma certamente la passione di Lacan per essi erano il suo godimento e il suo sintomo. Bisogna psicoanalizzare anche la teoria psicoanalitica, e lo psicoanalista che la elabora. Evidentemente Lacan si interrogava: come mettere assieme il fatto che riusciamo a legare aspetti della nostra soggettività in modo da “chiuderci” felicemente, con il taglio, lo spezzarsi del nodo, che getta tutto nella baraonda della libertà? In quei nodi vedo il tentativo di una risposta a un paradosso fondamentale, quello dell’esistenza umana che la psicoanalisi non fa altro che ricalcare.
Attorno a questo paradosso, il vortice del modo di vivere e di pensare di Lacan. Questo vortice lo rende indigesto a molti, proprio perché non ci si può mai riposare in una definitiva consistenza della teoria. In questo vortice faceva girare insieme gran parte dello scibile, in una bulimia simile a quella speculativa di Hegel: psicoanalisi e opere letterarie, matematica e filosofia, logica arte e linguistica. Questo ciclone girava attorno a un occhio che egli chiamò Reale. Con questo qualcosa che manca al puzzle – e che in qualche modo ci libera pericolosamente da ogni legge – si è confrontato tutta la vita.