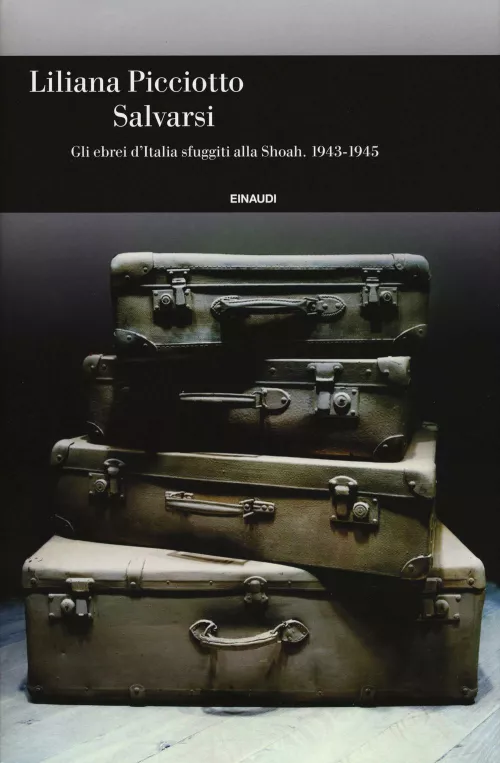Liliana Picciotto, Salvarsi / Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah
«Nell'Europa occidentale da secoli ormai l'umanità non aveva più sperimentato, antropologicamente, una caccia all'uomo nel vero senso del termine. In quel biennio 1943-45 si tornò, per salvarsi, alla pura fisicità: al correre come lepri, al fuggire in punta di piedi, al nascondersi sotto un letto, al trattenere il respiro dentro un armadio». In queste poche parole si condensa forse il senso di un lavoro ciclopico e al medesimo tempo enciclopedico quale quello che Liliana Picciotto, studiosa, autrice di numerose opere, responsabile delle ricerche storiche del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, consegna ora all’attenzione del pubblico italiano con il volume Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945 (Einaudi, Torino 2017, pp. 565, euro 38). Poiché si tratta di un’importante opera dedicata alle traiettorie di quegli ebrei che nel nostro Paese si salvarono dalla cattura e dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti, necessita di una pluralità di approcci per essere adeguatamente inteso. Non di sola storia si parla, chiamando in causa, attraverso il prisma delle persecuzioni e delle deportazioni, la questione del comportamento umano in condizioni eccezionali, quando la legge non tutela il diritto alla vita, semmai introducendo il quotidiano arbitrio della morte.
Intanto occorre richiamare il contesto del quale questo volume è un naturale prodotto, costituendo il risultato del progetto di ricerca dedicato alla «Memoria della salvezza», durato poco meno di una decina d'anni, a cura del CDEC medesimo. Il fuoco dell'attività di identificazione, analisi, elaborazione e valutazione dei dati di storia orale raccolti nel corso del tempo ed organizzati in chiave esplicativa dall'autrice, insieme a Chiara Ferrarotti, Luciana Laudi e Gloria Pescarolo, è il tentativo di spiegare attraverso quali percorsi, per il tramite di chi, con il concorso di quali fattori «un alto numero di ebrei d'Italia si sia potuto salvare durante il biennio 1943-45, mentre l'occupante nazista e il suo alleato fascista misero in pratica ogni sforzo possibile per opprimerli e non lasciare loro alcun margine di scampo». Elettivamente – ovvero per una specularità di significati, prima ancora che per una immediata congruità logica – si riallaccia al «Libro della memoria», ultimato e pubblicato la prima volta nel 1991, nel quale sono raccolti i nomi e il ricordo dei circa settemila ebrei che furono deportati dalla nostra Penisola nei campi di sterminio e di concentramento, dai quali, nella quasi totalità dei casi, non fecero ritorno. Le cifre, al riguardo, sono conosciute e più volte richiamate da Picciotto come termine ad quem per comprendere la natura del rapporto tra “sommersi” e “salvati” nel nostro Paese: su 38.994 ebrei identificati, italiani e non, 31.822 di essi si salvarono dalla morte nei Lager.
Tra gli arrestati e i deportati, invece, la cifra oscilla intorno ad un margine compreso tra le 6.806 e le 6.850 persone. In patria morirono 322 soggetti, compresi 42 perseguitati che perirono durante l’arresto o per suicidio oppure, ancora, a causa delle conseguenze delle intollerabili privazioni e dei gravissimi disagi ai quali furono sottoposti. Segnatamente, vale la pena di ricordare che tra i deportati solo 837 sopravvissero. La questione del salvataggio di quegli ebrei che invece riuscirono a sottrarsi a un tale destino – la cui concreta dimensione fattuale si disperde letteralmente in una pluralità di iniziative, eventi, attori, situazioni così come di gesti, parole e pensieri – come già si diceva richiama diversi ordini di riflessione. Il primo tra tutti rimanda al come maturò, tra i perseguitati e tra i loro salvatori, la cognizione che con l’8 settembre del 1943 si fosse collettivamente superata una soglia fatale, oltre la quale tutto sarebbe precipitato. Non si tratta di un mero dato fattuale o empirico, poiché chi dimostrò di avere colto qual era la sfida del momento rivelò anche di avere intuito il disegno degli eventi. Sicuramente più per un dato epidermico che non per una coscienza complessiva che si sarebbe imposta, in non pochi casi, solo a fatti compiuti. L’elemento stesso della tardività con la quale in non pochi casi si è riconosciuto il valore sociale dell’azione di salvataggio, è un indice di questa premessa. Rimane tuttavia il dato della moralità assoluta che contraddistingueva la gran parte dei salvatori.
Più che per lo sprezzo dei rischi o del pericolo (in Italia tale soprattutto se collegato all’eventuale identità antifascista di chi si prestava ad aiutare i perseguitati, nel qual caso perseguitabile anch’egli a prescindere), soprattutto per l’impegno, del tutto spontaneo, nel contrapporre a un’età di amoralità diffusa, incentivata dall’occupazione tedesca e dal declivio apertamente delinquenziale del neofascismo saloino, un canone etico basato sull’identificazione empatica. Al di là dei singoli gesti, che pure fecero la differenza tra la vita e la morte per coloro che ne beneficiarono, il sedimento che rimane, a distanza di così tanti anni, è forse quello di una moralità intrinseca al proprio agire sociale. L’autrice mette in rilievo come gli ebrei salvatisi facessero parte a pieno titolo di un’Italia sommersa, tale perché dipendente dalla parte restante del Paese per potersi garantire la sopravvivenza. A fronte del repentino spiazzamento generato dal crollo istituzionale, militare e politico avvenuto dopo l’ufficializzazione dell’armistizio con gli Alleati, per gli ebrei intervenne da subito la necessità di rielaborare la propria traiettoria di vita, passando dalla prassi di attenuazione degli effetti delle norme di esclusione, depauperamento, stigmatizzazione e marginalizzazione volute dal regime fascista a quelle di fuga e preservazione dell’esistenza umana e biologica.

Allo scompaginamento generato da una vera e propria dissonanza cognitiva, così come da una gigantesca frattura emotiva, subentrò quindi l’impellente necessità di riordinare, con le pochissime risorse esistenti, il profilo della propria quotidianità, laddove la clandestinità e il cambio di identità divennero due paradigmi ineludibili. Tempi e modi potevano conoscere differenze in base ai luoghi e, soprattutto, alle relazioni che ogni perseguitato viveva e vantava, ma le scelte si imponevano per tutti, a prescindere dalle singole volontà. Se di scelte, in un tale contesto, è ancora accettabile parlare, mancando semmai i presupposti per optare tra possibilità alternative, in un tempo invece estremamente compresso, dove le notizie erano scarse, le informazioni difficilmente discernibili dalle “voci”, i gesti quotidiani completamente stravolti. Il tutto era aggravato, in molti casi, dal fatto che ad essere rese oggetto di persecuzione e arresto non erano solo le singole persone ma l’intero nucleo famigliare, spezzando definitivamente l’anello che legava l’individualità al tessuto sociale: la soppressione di una famiglia, infatti, comportava non solo l’eliminazione, in un qualche luogo lontano e sconosciuto, dei soggetti che ne facevano parte ma anche la cancellazione della memoria di intere generazioni dal rapporto umano e storico che avevano concorso a costruire e a rinnovare negli ambienti, non solo ebraici, di cui erano stati parte attiva fino al momento dell’arresto.
Già le leggi razziali avevano lavorato in tale senso, adoperandosi nell’elisione dei rapporti di reciprocità tra ebrei e non ebrei. Ora, tuttavia, il passo era ben più ampio, chiamando in causa la continuità della vita biologica (e non solo di quella civile, sociale e culturale). Salvarsi, quindi, non era per molti un’azione esclusivamente individuale, mentre richiedeva un impegno di gruppo, senza il quale la sopravvivenza dell’uno sarebbe stata comunque vanificata, quanto meno moralmente e affettivamente, dalla scomparsa degli altri membri del contesto famigliare. A questo primo quadro di riferimento si accompagnava l’eterogeneità delle condotte dei persecutori. Mentre gli italiani procedevano all'arresto di tutti quanti fossero considerati ebrei in basi alle leggi razziali emanate nel 1938 e corroborate dall’azione zelante dei supporti amministrativi, non facendo quindi eccezione per i coniugi di matrimoni misti, i tedeschi propendevano per rispettare la loro legislazione in materia, che discriminava temporaneamente invece coloro che, in quanto ebrei, erano spostati con non ebrei. D'altro canto, gli italiani salvaguardavano i malati gravi e gli ultrasettantenni, mentre i tedeschi erano di avviso diverso, quindi di condotta opposta. Da ciò si generò un disorientamento nelle vittime, non sapendo esattamente a quale categoria considerarsi ascrivibile e, soprattutto, non potendo prevedere sempre e comunque il comportamento delle autorità. A prescindere da ciò, tuttavia, la percezione del pericolo prevalse un po' ovunque quasi da subito. L’atmosfera di intimidazione generale si coniugò, già nell’autunno del 1943, alla netta percezione del pericolo immediato al quale le vittime erano esposte.
Gli elementi strutturali, di cornice, che concorsero alla salvezza di molti perseguitati in Italia, e che Picciotto mette ripetutamente in rilievo, furono in primis la condizione di apparente “irriconoscibilità” dell’ebraismo italiano, quanto meno da un punto di vista delle condotte esteriori, rispetto alle prassi prevalenti nella popolazione peninsulare. L’indistinguibilità fu quindi trasformata in irreperibilità, fino al momento dell’arrivo degli Alleati. A ciò, come già abbiamo richiamato, si sommò la diversità delle pratiche persecutorie derivanti dall'antisemitismo italiano rispetto a quello tedesco. Forse sarebbe meglio parlare di concorrenzialità, la quale comportava una “amichevole competizione” nel dare seguito al rastrellamento degli indifesi. Un errore comune, per nulla casuale poiché intende depotenziare la responsabilità repubblichina, è infatti quello che continua ad attribuire al primo una minore solerzia vessatoria rispetto al secondo. Ma la relazione, semmai, andrebbe ribaltata. Gli occupanti, infatti, confidavano sull’azione, più o meno concertata ed efficace, della ridda di amministrazioni civili, di polizie fantoccio, di reparti di redivivi fascisti che meglio di loro conoscevano il territorio nazionale, la composizione e l’ubicazione della popolazione, l’eventuale presenza in essa di ebrei, italiani e non.
Il concorso del neofascismo saloino fu quindi rilevante, peraltro aderendo integralmente alle motivazioni ideologiche del «camerata germanico», con una solerzia che invece non seppe mostrare in molti altri campi. A suggello del fatto che, allora come oggi, l’unica cosa che riesca bene ai fascisti è sopraffare gli inermi e gli indifesi, ovviamente quando i primi sono in condizione di conclamata superiorità numerica. Un ulteriore aspetto da evidenziare è il peso che la notevole integrazione della componente ebraica nella società italiana, nonché l’alto livello di relazioni e di scambi con i non ebrei, ebbero nell’impedire di rescindere del tutto i rapporti quando le cose precipitarono. Se il regime fascista, almeno dal 1938 in poi, si era attivamente adoperato per revocare la cittadinanza civile all’ebraismo italiano, i legami umani non vennero mai meno, manifestandosi oltre e comunque a prescindere dai veti di ordine politico e dal peso dell’occupazione militare. Fattore che incise fu poi la durata complessiva dell'occupazione tedesca, circa seicento giorni, nel pieno di una guerra che attraversava l’intera Penisola.
Gli aspetti legati al conflitto, alla mobilità della linea del fronte, al crescere di un’opposizione popolare alla guerra stessa, come anche di una Resistenza sempre più articolata e inserita in seno al Paese, contribuirono almeno in parte a filtrare l’impatto, altrimenti devastante, delle razzie tedesche e della volenterosa collusione neofascista. Non di meno, la prossimità di alcune comunità ebraiche settentrionali con le frontiere, soprattutto quella svizzera, garantì, laddove non avvenissero respingimenti e quindi arresti, la via della salvezza a chi cercava di praticarla. Ben 4.265 persone sconfinarono clandestinamente. Sul territorio nazionale importante fu la presenza di strutture ecclesiastiche che offrirono protezione ai fuggitivi, a fronte dell'assenza di una specifica presa di posizione pubblica delle maggiori autorità del clero, a partire dal Papa. L'abitudine, maturata nel frangente bellico, ad accogliere profughi e fuggitivi, contraddistinse quindi una parte considerevole della popolazione italiana.
Non fu tanto questione di “buon cuore”, come la vulgata, prevalsa nel dopoguerra e durata a lungo – poiché intesa essenzialmente come esercizio autoassolutorio rispetto alle responsabilità del fascismo – amava invece affermare, quasi a fare intendere che ciò costituisse un tratto genetico nazionale. In linea generale, rileva Picciotto, per i soccorritori si trattava non di salvare gli ebrei come tali ma in quanto parte di un mondo che stava per essere sopraffatto. Ciò comportava sia una manifestazione di resistenza civile che di disobbedienza morale. La quale si materializzò attraverso un comportamento solidale, spontaneo e collettivo allo stesso tempo. Affinché tutto ciò potesse avvenire occorreva un mutamento di disposizione d'animo nei confronti del regime, fatto che si compì dall'8 settembre 1943 in poi. Il contatto con la barbarie nazista alimentò questi atteggiamenti, la cui spontaneità riposava nel non essere la conseguenza di un complesso processo di elaborazione razionale, così come la dimensione collettiva derivava dalla loro diffusione senza che vi fosse consapevolezza reciproca né, il più delle volte, reti di sostegno che andassero oltre l’operato dei medesimi salvatori. In buona sostanza, un ripetuto esercizio di «moralità privata di grande impatto sociale». Non a caso, antesignano del salvataggio degli ebrei fu il soccorso portato ai militari italiani in fuga dalla cattura tedesca.
A tale riguardo fanno premio su tutto le parole di Herbert Kappler, contenute nella relazione rivolta al suo superiore, il generale delle SS Karl Wolff, nel merito della «razzia nel ghetto» di Roma compiuta il 16 ottobre 1943: «la condotta della popolazione italiana è stata di resistenza passiva che, in molti casi individuali, si è espressa in partecipazione attiva. Per esempio, in un caso la polizia è entrata nell'abitazione di un fascista in camicia nera, fornito di documenti d'identità che, senza dubbio, erano stati usati un'ora prima in una casa ebraica da un individuo che li aveva fatti passare per propri. Mentre la polizia tedesca penetrava nelle case, si sono notati alcuni tentativi di nascondere ebrei in appartamenti vicini, e si ritiene che abbiano avuto successo. La parte antisemita della popolazione non si è mossa nemmeno durante l'azione. Sono stati invece notati individui che, in alcuni casi, hanno tentato di intromettersi fra la polizia e gli ebrei». La valutazione delle strategie di autotutela ebraica, partendo dal presupposto che, come rilevava già Walter Laquer, sapere non vuol dire necessariamente capire, erano in funzione dell’avere accumulato risorse sufficienti per garantirsi la sopravvivenza, nel disporre di informazioni adeguate e nel sapere identificare con anticipo gli eventuali segnali di pericolo, nel potere confidare su una cerchia sociale e di amici ampia, in grado di offrire concretamente un aiuto nel momento del bisogno come anche nel sapersi disperdere e nel non lasciare tracce di sé non meno che della precedente vita comunitaria, poiché «far perdere le tracce comportava un rischio minore che nascondersi fisicamente». Il libro ci offre quindi una panoramica, ampia e polifonica, non solo degli eventi storici, dei protagonisti perlopiù involontari, degli scenari e delle partiture ma anche e soprattutto di una straordinaria torsione alla quale persone e collettività furono sottoposte in un arco di tempo relativamente contratto, restituendoci il ritratto di un’umanità che nella sopravvivenza costruisce la rete di significati di una nuova esistenza.