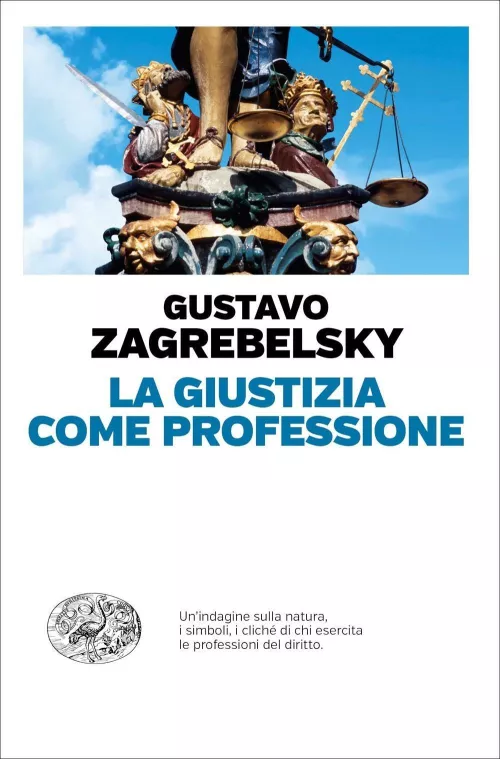Gustavo Zagrebelsky, La giustizia come professione
Non vi è giorno in cui le cronache e le riflessioni non si occupino della Giustizia, tra processi, malfunzionamenti, aspirazioni, critiche. E questo avviene comprensibilmente in quanto, oltre ad essere formalmente un potere dello Stato, è una macchina onnivora che colpisce con lo strumento dei processi, demolisce le traiettorie di cittadini, compensa le vittime, mostra le devianze, ne ipotizza il superamento. È una macchina che ha i caratteri dell’azienda in quanto gestisce uomini, siano essi magistrati o personale di supporto, spende denari, richiede spazi, fornisce servizi pubblici, con l’anomalia curiosa e poco trattata di non rendere conto a nessuno del proprio operato salvo in termini statistici e dei propri investimenti finanziari nei processi. Colpire la criminalità non ha prezzo, si osserva, e quindi diventa urticante e indisponente cercare di sapere ‘quanto costa’ la giustizia e quale sia la sua economia. Soprattutto quella penale tra intercettazioni telefoniche e perizie spesso naufragate.
Del resto quella giustizia è gestita da professionisti, siano essi dipendenti come magistrati o assistenti vari, siano essi indipendenti come avvocati che svolgono una professione per contribuire ad animarla. La sua funzione dal passato sacrale respinge il termine di “corpo”, troppo sanguigno e lontano dall’astrattezza, invece calzante per altre funzioni statali come quelle militari, ritenute più vicine alla concretezza.
Anche di questo parla l’ultimo saggio di Gustavo Zagrebelsky, La giustizia come professione (Einaudi, 2021), professore emerito di diritto costituzionale e già Presidente della Corte Costituzionale, che si occupa di chi fa funzionare quell’apparato e delle figure necessarie per adempiere ai suoi compiti.
L’avvio è bruciante: perché resiste ed è radicato il disamore verso l’attività giudiziaria? Perché letteratura e arte si sono impegnate a denigrare, a anche solo trattare con sorriso cinico, chi opera in quel mondo? Difficile rispondere con sicurezza, ma il dato non è scalfibile. Forse per le aspettative di chi attende giustizia, forse perché la giustizia attesa è diversa da quella che la professione giudiziaria può rendere, forse per la discutibile attività di qualcuno di quei professionisti, forse perché talora tocca interessi che reagiscono con il disprezzo, forse per il circuito stritolante e tossico con l’opinione pubblica.

Un coacervo di aspetti, i cliché come recita uno dei capitoli del saggio, ciascuno meritevole di approfondimento con un dato di fondo, valorizzato dall’autore: ogni epoca ha i suoi giudici in quanto ogni epoca colloca queste figure tra le pieghe dei rapporti con il potere e con i cittadini. Ogni epoca ha i suoi simboli e l’autore tratta del tema ampiamente in quanto la giustizia si è nutrita di simboli e in conseguenza di riti. Il panorama storico consente al lettore di cogliere i diversi modi di rappresentare la giustizia, il significato dell’essere bendata, di reggere la bilancia. E quale diffusione queste modalità esteriori hanno avuto nelle strutture giudiziarie, nell’ispirazione degli artisti, come un ammonimento a seguirne i segnalatori simbolici. Altrettanto dotati di senso erano gli spazi interni, le aule con il giudice in alto su tutti e le parti di fronte, su banchi laterali per fornire a chi giudica la posizione più elevata e quindi imparziale. Oggi, aggiungiamo noi, quei riti stanno scomparendo, la toga è un ornamento superfluo come la cravatta, le aule sono vuote di pubblico, gli edifici popolano le periferie perdendo la centralità urbana del passato, assumono i modelli di un comune ufficio pubblico non sempre funzionale.
L’autore tratta dei professionisti con ampiezza, tra tutti giudici e avvocati, dedicando spazio non solo alla loro professione, ma anche alla loro professionalità. Come noto i due termini non coincidono necessariamente: il professionista è colui che svolge una funzione e possiede una tecnica, una modalità per raggiungere quel fine, ma quella tecnica può appartenere anche a chi non è professionista. Il politico, Max Weber “docet”, e il medico come peraltro l’avvocato, sono conferme in tal senso.
Per il giudice si tratta di approfondire la sua figura, compito ampiamente svolto nel volume: chi è, come può giudicare, come si comporta di fronte a una legge ingiusta, da chi vorresti essere giudicato sono le domande classiche che affronta l’autore. Questi peraltro non si esime dal fornire una sorta di galleria di ritratti, ciascuno meritevole di approfondimento, dal giudice tecnico, al politico, al redentore, al sacerdote, al vendicatore, all’empatico, quest’ultimo soprattutto oggi con l’emersione della vittima nel processo sarebbe meritevole di una riflessione a parte.
In merito all’avvocato il saggio ritiene, circostanza difficile da smentire, che questo attore sia un imprenditore, metta a disposizione della clientela i servizi, abbia i suoi problemi con la ricerca della clientela e le limitazioni alla pubblicità. Di qui, osserva l’autore riferendosi peraltro al settore più civile che penale, ha la necessità di colpire l’immaginazione con la fisicità dello studio e gli ornamenti di contorno, di apparire solido e prestante per affascinare anche esteriormente il cliente. La sua posizione è anfibia perché investito di una duplice lealtà, quella verso lo Stato nel senso di non alterare o disperdere le prove e quella verso il cliente nel senso di non danneggiarlo ma curarne gli interessi. Si pongono a questo punto, scavando, alcuni problemi cui l’autore soltanto accenna. Da un lato il rapporto con la clientela, tanto più forte tanto più esigente soprattutto nel risultato, dall’altro il rapporto con la verità. Su questo secondo profilo le pagine offrono considerazioni intransigenti: il processo punta alla verità effettiva e l’avvocato quale difensore deve collaborare a questo fine. Pertanto suo dovere è non difendere l’imputato che nega quando lo sa colpevole, oppure tentare di raggiungere la prescrizione che rappresenta la sconfitta dello stato (p. 106 e 107). Sono affermazioni forti che appartengono alla teorica sostanzialistica della funzione dell’avvocato, in urto radicale con chi ritiene, come i sottoscritti, che il processo abbia la sua verità, che non esista una fine superiore, come recitava il passato, che l’uso delle regole presenti nei codici sia un dovere e non un abuso del diritto (p. 106). Potremo riparlarne.