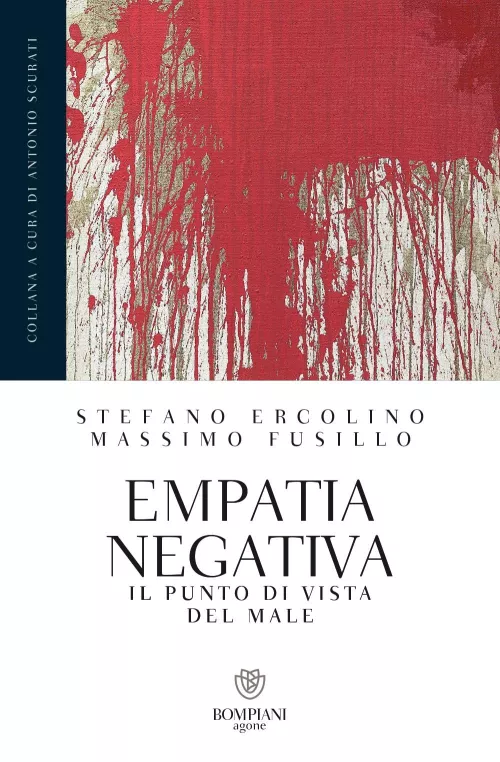Il lato oscuro dell’empatia
Essere empatici. Più che un invito o un auspicio, un dovere, un imperativo categorico. Fra i vari diktat che periodicamente e freneticamente si susseguono nel mainstream del discorso culturale, questo comando a mettersi nei panni degli altri – nelle loro scarpe o nella loro pelle, come preferiscono dire rispettivamente gli inglesi e i francesi – sembra particolarmente longevo e resistente. Correva il 2006 (un’era fa, se misurata con il cronografo delle mode), e Barack Obama, rivolgendosi agli studenti della Northwestern University di Chicago, lamentava un “empathy deficit”: “In questo paese si parla molto del deficit federale. Ma credo che dovremmo parlare di più del nostro deficit di empatia: la capacità di metterci nei panni di qualcun altro, di vedere il mondo attraverso chi è diverso da noi, il bambino che ha fame, l’operaio in cassa integrazione, l'immigrata che pulisce la tua stanza nello studentato”.
Da allora abbiamo assistito a varie repliche, sotto varie forme (nella psicologia e nella pedagogia, in etica e in politica), di questo riferimento al bisogno di essere empatici. E anche a un suo significativo ampliamento oltre la sfera dei rapporti interpersonali fra esseri umani. Lo confermano in maniera paradigmatica due libri specificamente dedicati al tema – a firma l’uno di Jeremy Rifkin, l’altro di Frans de Waal –, usciti in simultanea tre anni dopo il discorso del presidente statunitense. Nel primo, La civiltà dell’empatia (tradotto in italiano nel 2010 per Mondadori), l’economista americano preconizza il sopravvento dell’homo empathicus sull’homo homini lupus come l’unica possibile soluzione alla esiziale inclinazione all’autodistruzione dell’umanità: «La civiltà dell’empatia è alle porte. Stiamo rapidamente estendendo il nostro abbraccio empatico all’intera umanità e a tutte le forme di vita che abitano il pianeta. Ma la nostra corsa verso una connessione empatica universale è anche una corsa contro un rullo compressore entropico in progressiva accelerazione, sotto forma di cambiamento climatico e proliferazione delle armi di distruzione di massa. Riusciremo ad acquisire una coscienza biosferica e un’empatia globale in tempo utile per evitare il collasso planetario?».
Nel secondo, L’età dell’empatia (uscito in italiano per Garzanti nel 2011), il primatologo olandese propone di considerare due accezioni del termine “age” nella locuzione “age of empathy”. La prima è rivolta al nostro presente, che sarebbe caratterizzato a suo parere da una generale presa di coscienza del fatto che “l’avida ingordigia è out, l’empatia è in”. La seconda abbraccia invece la vertiginosa scala temporale dell’evoluzione delle specie: l’empatia umana si collocherebbe all’ultima (per ora) stazione di una lunghissima storia evolutiva pre-umana che mostra come gli skills empatici – essere in grado di sintonizzarsi con i membri di un gruppo, di coordinare le attività comuni, di prendersi cura degli individui fragili – siano stati e continuino a essere competenze sociali fondamentali per la sopravvivenza e l’adattamento di molte specie animali. Il ricorso a un’abbondanza di esempi (riguardanti non solo le scimmie antropomorfe, ma anche i delfini, gli elefanti, gli ippopotami, i pesci, i gatti e i topi) sostiene l’argomento per cui noi esseri umani saremmo capaci di empatia innanzitutto perché lo è l’animale che siamo stati e che sopravvive in noi.
Nel loro approccio eco-empatico, Rifkin e de Waal sono perfettamente complementari e circolari: se quest’ultimo guarda all’indietro lungo la catena evolutiva per rintracciare gli incunaboli pre-umani della disposizione empatica, il secondo guarda in avanti, all’unico futuro per lui possibile per il pianeta, quello empatico universale, che ci possiamo garantire solo recuperando e rilanciando proprio quel passato animale, per estenderlo alla biosfera nella sua totalità.
Facciamo un passo avanti, nel decennio successivo. Siamo a metà degli anni Dieci del nuovo millennio, e l’imperativo categorico dell’empatia stringe una santa alleanza con le nuove tecnologie digitali, in particolare quelle immersive rese possibili dalla Realtà Virtuale. Registi e artisti visuali di consolidata fama internazionale fanno il salto nel nuovo medium sintetico: nel 2017 Alejandro Iñárritu presenta al Festival di Cannes il suo Carne y Arena. Virtually Present, Physically Invisible: una sorta di polittico, in cui il segmento fruibile con caschi VR ti teletrasporta per sei minuti nel deserto ai confini fra Messico e USA, in mezzo a un gruppo di migranti sudamericani che cerca di attraversare illegalmente il confine e viene intercettato dalle guardie di frontiera. Solo sei minuti, che sembrano però durare ore: un tempo dilatato in cui ti senti visceralmente coinvolto nell’odissea della speranza, nel pericolo della traversata, nella minaccia dei fucili a pompa. Nello stesso anno, Kathryn Bigelow si converte al virtuale con il suo documentario The Protector. Walk in the Ranger’s Shoes, per trasferirti nel Garamba National Park nella Repubblica Democratica del Congo, e coinvolgerti nel pattugliamento di una squadra di ranger che combattono quotidianamente per difendere gli elefanti dai bracconieri. Sempre sul tema elefanti: nel 2019 Ai Weiwei realizza Omni, un’opera in VR che combina due video – Displaced Working Elephants in Myanmar e Rohingya Refugees in Bangladesh –, offrendo al suo pubblico un’esperienza immersiva nello sradicamento (tanto animale quanto umano) che va a braccetto con un comune destino di sfruttamento.
Perché questo abbandono del medium filmico tradizionale e questa conversione agli ambienti virtuali a 360°? La risposta è una sola: empatia. Invece di mostrarti una situazione di crisi umanitaria mettendoti davanti allo schermo di un cinema o della tv, ti portano dentro la scena, per farti diventare parte integrante della stessa. Lo ha detto con una formula definitiva un altro autore passato dai videoclip alla VR, Chris Milk: questa tecnologia è la “ultimate empathy machine”. Lui l’ha sfruttata girando dei documentari VR per le Nazioni Unite: Clouds over Sidra (2015), che ti immerge nel quotidiano di una ragazzina siriana dodicenne in un campo rifugiati in Giordania; Waves of Grace (2015), che ti fa incontrare Decontee Davis, una giovane liberiana sopravvissuta all’epidemia di Ebola; My Mother’s Wing (2016), che ti presenta una madre che ha perso due figli nella Striscia di Gaza. La scelta di convertirsi al VR è, almeno nelle intenzioni programmatiche, politica: mostriamo queste opere ai potenti della terra (Milk stesso lo ha fatto al World Economic Forum di Davos), facciamo appello alla loro empatia, così che cambieranno la policy internazionale su migranti e rifugiati (si veda sul tema il bel lavoro di Francesco Zucconi, Displacing Caravaggio: Art, Media, and Humanitarian Visual Culture, uscito per Palgrave nel 2018).
Al diktat “empatia” si unisce dunque in abbraccio solidale il diktat “immersione”: tutto oggi, si sa, deve essere immersivo: la didattica, i concerti, i musei, le mostre d’arte, l’archeologia, i videogiochi. Il decentramento del Sé proposto dall’atteggiamento empatico (svestirsi dei propri panni per mettersi in quelli dell’altro, assumere la sua prospettiva sul mondo, grazie a quel che appunto viene definito “perspective taking”) si rispecchia nel decentramento spazio-temporale promosso dalla bilocazione in VR: sei nella tua stanza, comodamente installato sulla tua sedia ergonomica da gaming in modalità “safe zone”, e al contempo ti trovi a empatizzare con i diseredati in Messico o in Congo o in Bangladesh.
Vi è tuttavia un’equazione che sottende, in maniera più o meno surrettizia, questo abbraccio: l’identificazione senza resti fra empatia ed empatia positiva. Si dà cioè per scontato che essere empatici promuova le nostre inclinazioni pro-sociali e l’altruismo, e che alla fine il generoso “perspective taking” si traduca immediatamente in un affettuoso “care taking”. Nelle frequenti volgarizzazioni di questa equazione, la conseguenza che se ne trae sfocia sostanzialmente in una soluzione più o meno a metà fra l’embrassons-nous e il finire a tarallucci e vino: Empatizzate! E sarete più buoni. Intanto, le policies nazionali e internazionali sulla crisi umanitaria continuano a essere quelle di prima…
Fortunatamente, in questi ultimi anni si è sviluppata in controcanto una riflessione che ha puntato ad arginare questa semplicistica caricaturizzazione dell’empatia, esplorandone opportunamente i lati più oscuri, subdoli e inquietanti. Se Simon Baron-Cohen (La scienza del male. L’empatia e l’origine della crudeltà, pubblicato nel 2011 e tradotto in italiano per Cortina) aveva sostenuto che l’“evil” nell’uomo è dovuto a una forma di “empathy erosion”, Anna Donise ha controbattuto osservando che “l’empatia può essere una preziosa alleata della crudeltà” (Critica della ragione empatica. Fenomenologia dell’altruismo e della crudeltà, il Mulino, 2019).

Forse che il sadico torturatore non deve esser dotato di capacità empatica per capire dove e come più efficacemente operare sul corpo della sua vittima? Forse che l’astuto manipolatore non deve empatizzare con i percorsi mentali e affettivi della sua malcapitata preda per poterla più compiutamente manovrare asservendola così alle proprie mire? Forse che tutte quelle opere che ci invitano a una sorta di empatia forzata nei confronti di reietti e sciagurati non saranno alla fine nient’altro che delle scorciatoie estetizzanti per scaricarci comodamente la coscienza, in modo che poi tutto possa rimanere (eticamente e politicamente) come prima: ho empatizzato, mi sono commosso, ho persino pianto, ho dunque già fatto la mia parte, andiamo avanti.
Questo dark side si chiama “empatia negativa”. Lo aveva precocemente identificato ai primi del Novecento uno dei principali teorici dell’Einfühlung (letteralmente un “sentire-in”): Theodor Lipps. Ma le sue riflessioni sul tema erano state marginalizzate dall’evoluzione successiva del dibattito, che si sarebbe concentrata a ribadire da varie prospettive – psicologica, psicoterapeutica, pedagogica, etica, estetica, neuroscientifica – il valore prosociale dell’empatia positiva. Oggi, molto opportunamente, quella pista trascurata viene ripresa, rilanciata e approfondita da Stefano Ercolino e Massimo Fusillo in un volume a quattro mani di ampio respiro e dal titolo inequivocabile: Empatia negativa. Il punto di vista del male (Bompiani, 2022).
Due sono gli assi portanti che strutturano il libro: da un lato, un esame delle componenti teoriche che informano il concetto di empatia negativa, condotto in una prospettiva interdisciplinare e intermediale; dall’altro un’indagine di casi di studio esemplari, tratti da ambiti diversi e anche molto eterogenei dell’ambito delle arti (letteratura, teatro, melodramma, performance, pittura, fotografia, installazioni, cinema, televisione) e affrontati non solo in un’ottica comparativa, ma anche in un costante dialogo e feedback con la dimensione della concettualizzazione.
Sotto il profilo della definizione concettuale della nozione di “empatia negativa”, gli autori convocano un’ampia letteratura che in questi ultimi anni si è impegnata a ridefinire lo statuto dell’empatia da un punto di vista psicologico e neurocognitivo. Ma soprattutto risalgono a quella stagione particolarmente feconda dell’Einfühlungstheorie che si è sviluppata in Germania fra la seconda metà dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, grazie a teorici come Robert Vischer e il già citato Lipps. Pur nella diversità degli approcci (più somatico il primo, più spiritualista il secondo), entrambi condividono l’idea secondo cui l’empatia può declinarsi non solo come consonanza della propria condizione psicofisica e costituzione vitale con uno stato di cose o una relazione intersoggettiva, ma altresì come dissonanza, conflitto e dissidio. E ammettono che, da questo punto di vista, il nostro rapporto con gli oggetti sia strutturato secondo quelle stesse dinamiche che regolano le nostre interazioni con altri soggetti: che sia cioè possibile (altro aspetto poi marginalizzato nella ricerca successiva) una vera e propria empatia oggettuale.
È, questo, un punto cruciale, che Ercolino e Fusillo recuperano e amplificano, proprio in relazione al rapporto che intratteniamo con le opere come quasi-soggetti: leggendo un romanzo, guardando un film o una serie tv, è possibile empatizzare non solo con un personaggio (rappresentante, nell’opera, dell’Altro umano), ma anche con una situazione, un’ambientazione, uno stile, un tono emotivo, una tessitura affettiva dell’opera. Che può assumere la marca spiazzante del negativo. Si perviene così a una definizione di tale esperienza: “L’empatia negativa è un’esperienza estetica consistente in un’empatizzazione catartica di personaggi, figure, performance, oggetti, composizioni musicali, edifici e spazi connotati in maniera negativa e seduttiva in modo disturbante, o che evocano una violenza primaria destabilizzante, capaci di innescare una profonda angoscia empatica nel fruitore dell’opera d’arte, di chiedergli insistentemente di intraprendere una riflessione morale, e di spingerlo ad assumere una posizione etica”. Se l’empatia estetica positiva si allinea solidale con la disposizione morale, quella negativa dischiude un dissidio fra l’adesione al personaggio e l’allontanamento da esso, provocato dal fatto che non possiamo sintonizzarci sui suoi atti e sulle sue motivazioni.
Poste queste basi, gli autori dipanano nei capitoli successivi una serie di scrupolose analisi di casi di studio, a testare le premesse teoriche. Incontriamo così, nel capitolo secondo (dedicato alla letteratura), i Miserabili, Lolita, e soprattutto Le Benevole di Jonathan Littell; nel capitolo terzo (rivolto alla dimensione performativa in senso lato), il teatro di Milo Rau, Medea in Euripide e nelle sue svariate reincarnazioni, Deafman Glance di Robert Wilson, il melodramma con Wagner e Verdi, l’inquietante performance eseguita da Marina Abramović alla Galleria Morra di Napoli, il Teatro delle Orge e dei Misteri di Hermann Nitsch; nel capitolo quarto (che ruota attorno all’empatia nelle arti visive e in architettura), il Caravaggio del Martirio di san Matteo, ma anche la polarità di figurativo/astratto; nel capitolo quinto (che si divide fra fotografia e installazioni), i grandi formati di Andreas Gursky, gli scatti di Nan Goldin, X Portfolio di Robert Mapplethorpe, I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. L’ultimo capitolo indaga il tema dell’empatia negativa nel medium dell’immagine in movimento: a una considerazione della questione relativa all’immedesimazione nel “cattivo” segue un esame del Nastro bianco di Michael Haneke per il cinema, e di Breaking Bad per le serie televisive.
Il catalogo non è questo: nel senso che quanto ho appena elencato, che già di per sé sarebbe un menu molto ricco, è in realtà solo una lista parziale di una costellazione molto più ampia di autori e opere evocati da Ercolino e Fusillo, che si premurano di premettere a ogni capitolo dedicato a un medium specifico una sezione introduttiva che cala i fondamenti teorici generali affidati al primo capitolo nella specificità mediale di volta in volta presa in esame.
Grazie a questo libro possediamo ora uno strumento prezioso per correggere il tiro riguardo a un concetto, quale quello di empatia, che come pochi altri si è inflazionato in questi ultimi vent’anni, diluendosi nella retorica del “vogliamoci bene”. Grazie a questo libro siamo trattenuti dall’impulso di buttare il bambino empatia con l’acqua sporca, perché ne riscopriamo la complessità, le sfumature, le interne tensioni, il suo lato oscuro finalmente condotto in piena luce. E lo riscopriamo attraverso le arti e il loro punto di vista esemplare sul male.