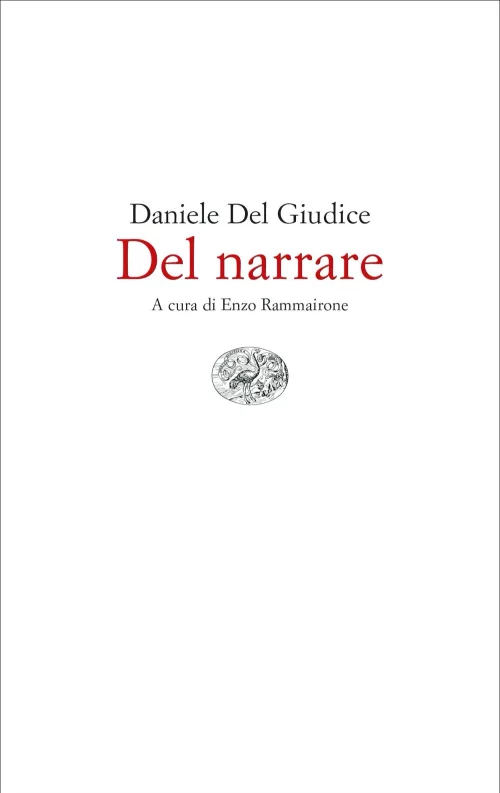Il narrare di Daniele Del Giudice
Nel saggio intitolato La zona del narrare, in parte inedito e in parte no, Daniele Del Giudice avvia il suo ragionamento da una distinzione chiara, ma in parte critica, tra le analisi letterarie operate da teorici della letteratura e quelle fatte direttamente dagli scrittori su altri scrittori. I saggi di Todorov, Škovskj, Jakobson, Blanchot, Barthes, Frye, Genette, Bachtin o Ricoeur, dice, «descrivono l’atto del narrare, ne arricchiscono e ampliano l’orizzonte ermeneutico, lo fondano storicamente» e quindi «non possiamo farne a meno» ma, aggiunge subito dopo: «tutto questo non consente di accedere alla zona».
Subito dopo elenca una serie di scrittori che hanno parlato di altri scrittori e dice: «io sentivo che lì c’era fortissima l’esperienza della zona, non mi dicevano solo la natura della zona, la fondazione dell’atto narrativo, né solo il modo in cui un determinato autore c’era stato, mi dicevano anche che chi cercava di capire cosa fosse la zona ne aveva esperienza» (p. 168).
Quando esce un libro di saggi di uno scrittore, come in questa edizione di Del narrare di Daniele Del Giudice, pubblicata da Einaudi in una veste di pregio per la cura di Enzo Rammairone, è naturale cercarvi una collocazione: lo scrittore saggista è dunque diverso dal saggista tout court? La produzione saggistica di Del Giudice, come ricorda il curatore nell’introduzione «risulta ben maggiore rispetto a quella narrativa», e dunque siamo di fronte a uno scrittore saggista, che quindi rientra nella seconda categoria, o a un saggista scrittore, che forse sarebbe più vicino alla prima? Non serve catalogare né cercare etichette ovviamente, ma per un autore le cui opere letterarie – da Lo stadio di Wimbledon a Orizzonte mobile, passando per Atlante occidentale o Staccando l’ombra da terra – sono apparentemente, almeno nel loro innesco, così prossime alla saggistica, la domanda risulta più pregnante.
Quando nel 1988, Del Giudice partecipa a un convegno in memoria dell’amico e maestro recentemente scomparso Italo Calvino, lo definisce «scrittore di formazione» proponendo così una nuova categoria valida ben oltre l’autore di Palomar e che anzi pare caratterizzare l’intero Novecento. «Lo scrittore di formazione» fa ricadere l’attenzione del lettore su di sé anziché favorire l’identificazione col personaggio: «già con Kafka siamo in un’era nuova e non potremmo mai identificarci con Gregor Samsa, sperare che ci sia un’occasione nella nostra vita in cui comportarci come un bacarozzo» (p. 54).
Pur molto lontano dalla sovraesposizione dell’io che va di moda negli ultimi anni, ed anzi autore aperto all’altro ma caratterialmente schivo, reticente verso ogni forma di esposizione di sé, Del Giudice riconosce che viviamo in un tempo in cui il ruolo dell’autore – il suo modo di abitare la zona – è fondamentale per comprenderne la parola letteraria. Perciò guardiamo con curiosità questo libro, benché molti dei saggi inclusi fossero già noti: perché vi compare a sprazzi l’io dell’autore, come personaggio di una narrazione privata – anche se sempre legata alla scrittura –, ma anche come voce, come occhio che guarda, legge e si confronta con altri scrittori a lui più o meno vicini:
Io credo che sia difficile essere un buon scrittore se non si è anche una persona, nel senso che il mestiere e la tecnica ti aiutano senz’altro e sono indispensabili. Ma quello che conta in un libro è quello che va al di là della tecnica e del mestiere: se non c’è un modo di essere di chi scrive, è difficile che ci sia soltanto un modo di scrivere, oppure capita che ci sia soltanto un modo di scrivere e questo si sente, si sente che i libri non hanno un doppio fondo, non hanno una profondità. (p. 201)

Questo libro si compone di due parti, la prima, intitolata Scrittori, raccoglie una serie di saggi già editi in sedi più o meno note, dedicati a grandi autori della letteratura passata e presente cari a Del Giudice; la seconda raccoglie saggi che ragionano più in generale sulla scrittura e sulla narrazione, in qualche caso parlano della esperienza di scrittura, altri dei fondamenti di una vera e propria teoria della narrazione. Il lettore dello Stadio di Wimbledon non si stupirà della consapevolezza metaletteraria dell’autore, della sua capacità di portare avanti un ragionamento sulla letteratura. Eppure cercherà il doppiofondo, la profondità, magari legando la prima parte con la seconda, o cercando di interrogare parti di testo.
A partire per esempio dal punto dal quale anche questo articolo ha preso le mosse: la zona. È un concetto importante per Del Giudice: «Penso il romanzo come la zona. Più esattamente come “zona” e “campo di energie”» (167). Purtroppo il curatore del libro non dà alcuna informazione bibliografica e filologica che permetta di risalire alla genesi di questa idea (si dice solo vagamente che il saggio deriva da interviste messe insieme, e infatti la scrittura resta in parte frammentaria, diversa dalla consueta prosa saggistica dell’autore), ma questo termine, “zona”, esattamente nella stessa accezione utilizzata da Del Giudice, compare nel 1987 nel volume Postmodernist Fiction di Brian McHale, che lo usa per definire non solo genericamente, a partire da Foucault, l’«eterotopia» della scrittura, ma proprio i caratteri della scrittura postmoderna, ricavando il termine peraltro da L’arcobaleno della gravità di Pynchon.
La coincidenza della definizione, zona, – che certo è generica, ma non così immediata – non sarebbe così interessante se McHale non prendesse le mosse, nel capitolo intitolato In the Zone, proprio da Le città invisibili di Calvino, creando perciò una rete di riferimenti che possono essere significativi. Per Del Giudice dunque la zona
È campo di forze del tutto contrastanti e molteplici, vitali, potenti […]. È la zona dove davvero diventa difficile, e forse anche ridicola, qualunque distinzione tra «io» e «mondo», tra memoria e invenzione, tra linguaggio e realtà, tra visionarietà e ricerca, – e dove cade la comodità oppositiva di cui ci serviamo nel nostro orientamento percettivo, corporale e sentimentale. (167)
Scrive del medesimo termine nella medesima accezione McHale:
So far, Pynchon’s zone would seem to be a realistic construct, closely corresponding to historical fact, and a far cry from the heterotopian empire of Calvino’s Great Khan. But the collapse of regimes and national boundaries, it turns out, is only the outward and visible sign of the collapse of ontological boundaries.
In un altro saggio, Del Giudice afferma con decisione di rifiutare le etichette generazionali, ma in questo caso la corrispondenza è troppo evidente per non saltare agli occhi. Ovviamente non sappiamo se e quanto lo scrittore italiano conoscesse del critico americano, ma la coincidenza ha importanza in ogni caso. Sarebbe difficile definire Del Giudice uno scrittore postmoderno: la dominante conoscitiva della sua prosa lo colloca probabilmente altrove, ma alcuni temi che emergono da questo libro, lo legano strettamente al suo tempo.
Innanzitutto c’è una ridefinizione degli oggetti, che hanno ampia parte nella sua narrativa, e in diversi saggi sottolinea l’importanza di questa mutazione: «Gli oggetti di oggi hanno perso la loro materialità: sono direttamente immaginazione, comunicazione, fantasia prefabbricata, rappresentazione: cose destinate al rapido smercio, e come cose senza più nessuno di quei caratteri che una volta appartenevano alle cose» (p. 244), scrive in Gli oggetti, la letteratura, la memoria, utilizzando gli stessi termini che impiegherà poi Remo Bodei in La vita delle cose (2011).
Questa mutazione delle cose crea una parallela mutazione del linguaggio, come dice in Ci sono nuovi sentimenti da raccontare?: «ogni volta che noi nominiamo attraverso il linguaggio, diciamo bottiglia, scarpe, orologio, occhiali, cravatta, è come se facessimo un piccolo raggio di luce e attorno a questo raggio di luce si creasse immediatamente un cono d’ombra» (p. 225).
Così si ritorna alle Città invisibili di Calvino, in cui l’invisibile dell’immaginazione scaturisce dall’evanescenza del visibile: «già con Calvino, nei primi anni Settanta, le città diventano “invisibili”, e quelle che Marco Polo descrive a Kublai Khan sono soltanto immaginarie; sono le città che potrebbero esistere, quelle che ciascuno di noi potrebbe inventarsi una volta che la città in cui vive, non più mutevole, diventa invisibile ai suoi occhi» (p. 233). In un’epoca dominata dal «carattere all pervading della visività» (p. 211), l’invisibile, l’ombra diviene il territorio della letteratura, il carattere peculiare della zona.
In questo contesto cambia anche la percezione dei sentimenti. Del Giudice si ritiene, forse imprevedibilmente, un autore di sentimenti, dove però il sentire è condizionato dal pensare, dallo spavento di percepire il mondo razionalmente mutato e il narrare deve dare conto di questo. Per questo più volte si parla di phantasia logistiké, di «pensiero che immagina», come «una molteplicità di rappresentazioni che si è costituita e sedimentata strato dopo strato» (p. 196).
Questo termine, phantasia, è usato spesso nell’analisi degli altri scrittori che occupa tutta la prima parte del testo. Vi si trovano autori che notoriamente abitano la costellazione delle fonti di Del Giudice, da Primo Levi, sul quale l’autore scrive la nota introduzione al volume delle opere qui ripresa, a Italo Calvino, a Svevo, fino all’amico Claudio Magris, ma si trova anche qualche presenza per molti versi inaspettata, come per esempio Thomas Bernhard, uno scrittore almeno apparentemente lontano da lui, per forme e contenuti, ma che piaceva anche a Calvino che ne propose a Einaudi la pubblicazione. Del Giudice è affascinato dal suo uso della lingua, da quella sorta di «malattia» che «è nel fatto che “ogni frase” è piena di significato, piena da scoppiare; e ogni frase pretende di essere “quella frase”, specifica, individuale, mentre in realtà sono tutte equivalenti. […] Sono tutte legittimamente equivalenti come principio di realtà, nel momento in cui la realtà si ritrae dalle cose e dal mondo» (p. 104).
Il problema chiave, dunque, nell’analisi delle opere di Bernhard ma forse anche di ognuno degli scrittori qui rappresentati, è il conflitto che si crea tra – direbbe Calvino – mondo scritto e mondo non scritto. È probabilmente questa la modalità di critica che fanno gli scrittori che parlano di scrittori e, anche leggendo questo libro, si potrebbe dire: «io sentivo che c’era fortissima l’esperienza della zona».