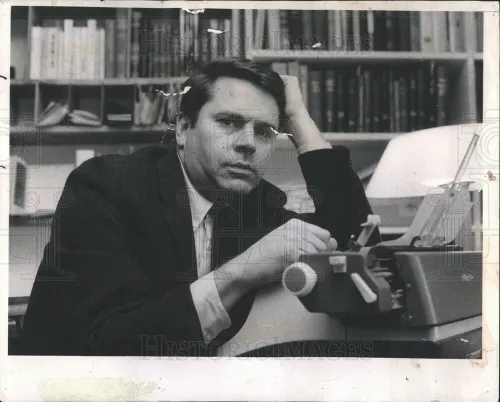Tradizione vs. progresso / Christopher Lasch sulla strada per il nessun-dove
Il videoclip Road to nowhere dei Talking Heads (band incensata da Sorrentino in più occasioni) racconta con ritmo compulsivo la crisi dell’America degli anni ottanta attraverso un vasto campionario di icone e simbologie tipiche della società dei consumi. I membri di una comunità di provincia si stringono in coro per intonare le note e le parole dell’incipit, che parla appunto del loro spaesamento dinnanzi alla “strada per il nessun-dove”. Una nutrita serie di microsequenze della durata di pochi secondi squarcia la consistenza del sogno americano, mettendone in discussione la sostanza. L’immagine più significativa ed esplicita è forse quella del giovane che insegue il carrello della spesa, segno inequivocabile di uno strumento – il consumo – che si è fatto fine e ha spiazzato definitivamente il ruolo di colui che lo aveva creato per soddisfare determinati bisogni. Il personaggio simbolo di tutta un’epoca, lo yuppie, litiga con un suo antagonista mascherato da catch messicano, ma la loro mimica ricorda quella dei bambini che si contendono un giocattolo. Il clip si conclude con il delirio schizofrenico del protagonista (David Byrne) amplificato dagli effetti di stop motion mentre resta seduto su un trono instabile.
Poche opere dell’epoca hanno saputo esprimere tanta consapevolezza sulla criticità di quel passaggio storico con le sue implicazioni sull’uomo e sulla società. Lo scrittura del video pare quasi infarcita dei temi chiave che caratterizzano la riflessione di C. Lasch. Risuonano infatti nel video del 1985 le questioni che caratterizzano la riflessione laschiana tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni novanta (ovvero poco prima della sua scomparsa): da La cultura del narcisismo a L’io minimo, da Rifugio in un mondo senza cuore a Il paradiso in terra.
Con La cultura del narcisismo lo studioso americano fu consacrato come uno degli autori più profondi ma anche più capaci di impattare sul mercato, anticipando il ruolo di grandi autori di saggistica “pop” come J. Rifkin e Z. Bauman. Il libro in questione riflette sulla crisi culturale che anima l’Occidente e che decreta la trasformazione del narcisismo da disturbo psicologico a forma mentis di un’intera società. In varie opere del resto l’autore ammise il suo apprezzamento per la Scuola di Francoforte, soprattutto per l’idea di conciliare la dottrina marxista – da cui egli stesso proviene – con i temi e i modelli della psicoanalisi. Se l’individualismo borghese si era edificato a partire dall’idea della “terra di nessuno” (p. 23) da modificare attraverso un atteggiamento autoassertivo (lo spirito della frontiera), il narcisista invece vede il mondo come uno specchio in cui verificare continuamente lo stato della propria identità messa in crisi dal progresso.
Il narcisismo impatta potentemente sulla percezione del tempo e della storia, determinando ciò che in modo diverso i teorici del postmoderno avrebbero chiamato “presentificazione”. Per dirla con le parole di Lasch “dal momento che la società è senza futuro, acquista un senso vivere solo in funzione del presente, occuparsi soltanto delle proprie “realizzazioni personali”, diventare fini conoscitori della propria decadenza, coltivare un'“auto-osservazione di ordine trascendentale”” (p. 19). La visione del manager è quella più propriamente narcisista, proprio perché egli vede “il mondo come specchio di se stesso e non si interessa degli avvenimenti esterni tranne nel caso in cui gli rimandino un riflesso della sua propria immagine” (p. 62).
In una posizione non distante ma diversa dall’analisi della merce di G. Debord, che Lasch cita senza nominare parlando appunto di “società dello spettacolo”, qui il fattore profondo che innesca l’epidemia narcisistica è la burocrazia. Questo perché “l'ambiente densamente interpersonale della burocrazia moderna sembra provocare e gratificare una risposta narcisistica – un'ansiosa preoccupazione riguardo all'impressione che si produce sugli altri, una tendenza a trattare gli altri come specchio di sé” (p. 265). Si tratta dunque di uno spunto di riflessione utilissimo dato che, anche recentemente, le scienze sociali tornano a porsi il problema della burocrazia, proprio all’epoca dei Big Data e di una razionalizzazione ancor più intransigente della società, del diritto e della politica (come nella “regolazione algoritmica” di E. Morozov). La cultura del narcisismo è quella che ha consacrato come dominante la metafora dello specchio, ma è anche quella che, seguendo le dichiarazioni di A. Warhol, scopre che di fronte allo specchio c’è il vuoto assoluto (Warhol si descriveva appunto come uno specchio che si guarda in uno specchio). I’ll be your mirror, cantava Nico insieme ai Velvet Underground, “rifletto ciò che sei, nel caso tu non lo sappia”, e anche questo anticipava la dimensione puramente speculativa ma personalizzata dei nuovi specchi, ovvero quelli che popolano i nostri quotidiani attraverso le piattaforme digitali, offrendoci appunto risorse rispecchianti esattamente il nostro profilo.
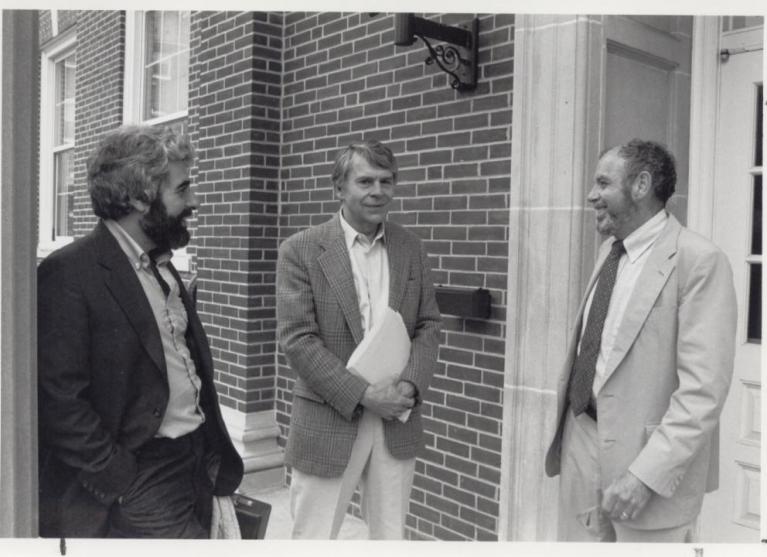
Se negli anni novanta abbiamo imparato a considerare la riflessione laschiana come obsoleta per via dei valori emergenti che confutavano l’ipotesi narcisista, i primi decenni del nuovo millennio ci ricordano invece che parecchi cambiamenti culturali del nostro tempo sono riconducibili alle matrici studiate da Lasch. Il dispositivo della confessione ad esempio, che solitamente riconduciamo alla Storia della sessualità di M. Foucault e che oggi diventa strategico per capire il web 2.0, viene qui esplorato in modo diverso, passando soprattutto per il lavoro degli artisti.
Mentre la Cultura del narcisismo è tornata in auge oggi anche sulla scia di alcune innovazioni tecniche come i social media e i selfie, Il paradiso in terra spaventa per la sua capacità di sistematizzare tematiche talmente attuali da aiutare lo sguardo prospettico sul passato e sul futuro. Dal populismo alla postverità, passando per la questione chiave del libro che è lo sfondo valoriale sul quale si è innestata la ideologia/utopia del progresso dalle dottrine liberali fino a ciò che oggi chiameremmo neoliberismo: la produzione e la soddisfazione di un bisogno illimitato (il “crazy greed” cantato in Society di Eddie Vedder), l’idea squisitamente moderna che “gli appetiti insaziabili, in precedenza condannati come fonte di instabilità sociale e di infelicità personale, potessero trainare la macchina economica” (p. 49). L’analisi del populismo, ad esempio, non si limita a discutere le ragioni di tale orientamento politico ma lo considera una variabile dipendente dell’economia, anzi quasi un meccanismo di compensazione che tendeva a contenere la “brama sconfinata dei beni in sempre maggiore quantità” e allo stesso tempo di preservare il senso della comunità drasticamente messo in discussione dalla stessa logica dello sviluppo illimitato. Temi ancora oggi presenti nei programmi e nelle proposte delle formazioni populiste che tentano di resistere al meccanismo dissipativo e universalistico della globalizzazione.
Allo stesso modo Lasch mette in discussione alcuni atteggiamenti tipici degli intellettuali nei confronti della questione del progresso, tra cui i più radicati sono specularmente un “pessimismo malinconico” alla ricerca del bel tempo che fu e un “ottimismo fatalistico” che si abbandona completamente a uno slancio verso il futuro, sacrificando la valutazione ponderata delle conseguenze. Certo, in una fase immediatamente successiva alla Guerra fredda, non era difficile ragionare nei termini di obsolescenza dei concetti di destra e sinistra. Ma l’autore è anche capace di penetrare nel profondo lo schema logico che deriva dal collasso delle ideologie politiche – e che Lyotard anni prima aveva già individuato come atteggiamento pragmatico ed efficientista – sottolineando come le differenze di posizionamento politico sarebbero perlopiù riducibili a scelte tattiche. Sempre sullo stesso punto, l’autore sviscera una questione che, se studiata attentamente, avrebbe forse aiutato Matteo Renzi a risolvere alcuni problemi di carattere programmatico. Lasch difatti criticava la scelta del senatore Paul Tsongas di invitare i “liberali” (così tradotti ma in realtà riferiti ai “liberal” americani), a diventare “più conservatori sulle questioni economiche e più radicali su quelle “sociali” come i diritti degli omosessuali…” (p. 16). Rispetto alla quale egli prediligeva decisamente la posizione inversa, sostenuta da Bernard Avishai del Mit, per cui la “sinistra doveva combinare il radicalismo economico con il conservatorismo culturale” (p. 16).
Senza nominare il vero oggetto del suo discorso, ovvero l’affermazione della postideologia neoliberista, Lasch ci regala uno spaccato degli anni ottanta americani in cui al contempo si celebrava disperatamente il mito del successo, come nel caso del “carrierismo” (p. 29) degli Yuppies, mentre s’innescava un dispositivo di “degradazione del lavoro” che, a detta degli attuali teorici del capitalismo cognitivo, è diventato oggi del tutto patologico. Oltre ai suddetti motivi, il senso di sfiducia dei cittadini comuni nei confronti della politica era inoltre indotto da quelle che Lasch chiama strategie “legalistiche” adottate dai democratici per imporre forzosamente e al di là del consenso popolare una parità di diritti che produceva delle frizioni tra le placche sociali ed etniche del tanto decantato villaggio globale. Infine, ancor più simile a ciò che oggi stiamo vivendo, la relazione tra populismo e postverità era già del tutto presente nell’America degli anni ottanta, condensata nell’icona di R. Reagan. Il presidente che da un punto di vista comunicativo inaugurò l’epoca della politica spettacolare, fu anche colui che giunse al potere grazie alla “rivolta della classe lavoratrice contro il liberalismo” (p. 34). La figura di Reagan fu assolutamente paradossale perché tentava di coniugare la difesa dei valori tradizionali – a cui lo stesso Lasch in vari momenti prova ad appellarsi – con invece uno spietato culto della crescita economica e dell’iniziativa commerciale, ovvero “quelle forze che hanno minato la tradizione”. Lo stridente contrasto tra le due vocazioni in realtà si risolveva in un uso ipocrita e dunque menzognero del pretesto della tradizione. In ultima analisi, mentre il conservatorismo difendeva una concezione etica della politica come scienza del limite, l’esordiente ideologia neoliberista spingeva già verso la messa in discussione di ogni limite. Le origini di questa concezione che oggi definiremmo semplicemente nichilista, sono individuate dall’autore nel pensiero di Adam Smith che in un sol colpo fornì una base scientifica all’economia, ma anche la spinta propulsiva all’espansione capitalistica per “dare origine a una forma di società capace di espandersi indefinitamente (p. 50).
Nei capitoli che affrontano il tema della nostalgia dei moderni e quello ancor più marcatamente sociologico sull’idea di comunità, la capacità analitica dello studioso va di pari passo con lo spaesamento dinnanzi a un processo che, già da allora, si presentava come incontenibile. Rispetto al primo tema, lo studioso vuole precisare la relazione tra la nostalgia, che congela il passato e lo eleva a momento esemplare e irraggiungibile, e la memoria che invece opera in funzione del presente, ricostruendo il senso della continuità storica. Lasch ritorna sulle tappe attraverso cui si è sviluppata la relazione tra nostalgia e memoria, a partire dall’immagine della società pastorale, passando per l’utilitarismo di Bentham votato a denigrare la saggezza degli antenati e delle “popolazioni primitive” (p. 93), ripassando al setaccio il mito della frontiera e del West come infanzia della nazione fino agli anni venti del novecento e oltre. Se fosse vivo oggi, dovrebbe sicuramente aggiornare il suo compendio osservando una cultura talmente ossessionata dal passato da aver piegato ogni sua estetica sotto il penso di quel sentire che S. Reynolds ha ribattezzato “retromania”.
Allo stesso modo la questione della comunità, oggetto d’indagine squisitamente sociologica, ha segnato il passaggio dal globalismo universale al glocalismo degli anni novanta – quando la comunità era principalmente una questione estetica, fino al recupero esacerbato di tale dimensione in una chiave più tragicamente politica. Lasch vaglia criticamente, grazie anche a Rousseau, la relazione tra Illuminismo e Cosmopolitismo per mostrare come quest’ultimo degeneri in una sorta di “arroganza e di disprezzo per le masse meno illuminate” (p. 131). Per smantellare l’architettura concettuale del cosmopolitismo, il suo studio torna alle fondamenta stesse del pensiero occidentale, al cogito cartesiano e alla fondazione di una scienza sviscerata da condizionamenti emotivi e da radicamenti culturali. Oltre all’ambivalenza del marxismo, che vuole spezzare le catene della tradizione ma che allo stesso modo è spaventato dalla potenza distruttiva dell’individualismo (per Engels a Manchester) e del colonialismo (in India per Marx), Lasch passa a esaminare la medesima problematica nell’ottica del nascente pensiero sociologico. Allo stesso modo anche la fondazione della scienza sociologica è sospesa in una sostanziale ambivalenza. Così l’opera di un classico della sociologia – il Gustav Tönneis di Comunità e Società – è letta come una sorta di mare che “rispecchiava l’umore di chi vi si rifletteva” (p. 150). Se l’analisi che gettava le basi della storia del pensiero sociologico, lavorava su dicotomie troppo nette (la comunità come luogo inclusivo e cooperativo versus la società come luogo esclusivo e competitivo), la valutazione complessiva sulla questione del progresso era molto meno chiara e distinta. Alle immagini di un’innocenza perduta della comunità si sovrapponevano i sogni di un “futuro dorato” che inaugurava una sorta di mistica del mutamento sociale. Forse più interessante la constatazione che Tönnies vedeva il mondo trasformarsi in una “sola grande città” (p. 151), anticipazione dell’idea jungeriana di uno stato mondiale, ma anche delle più recenti visioni sulla monocultura globalizzata.
L’esigenza di difendere il valore della comunità, conduce Lasch a esplorare le ragioni di crisi del pensiero “liberal” (ma anche liberale). Per questo nell’ultimo capitolo del libro, lo studioso si cimenta con l’attualissimo tema dell’insorgenza del populismo di destra. Una serie di analisi che alle nostre orecchie suonerebbero come contemporanee, scavano invece nelle viscere della politica americana. Dal momento in cui le “minoranze etniche bianche hanno abbandonato i democratici… l’ansia di status rafforza il razzismo dei loro esponenti e li rende irrazionalmente gelosi delle minoranze razziali favorite” (p. 539). In un resoconto che pare cronaca giornalistica dell’America nel 2017, il pensiero della destra populista trae linfa dalla reazione contro le politiche “liberal”, proprio quando “l’appoggio liberale alla causa dell’aborto, delle azioni dimostrative, e del busing, aveva già allontanato grandi masse di democratici dal partito e non si poteva trovare nulla di meno appropriato all’obiettivo di riportarcele di questa scuola di liberalismo manageriale, tecnocratico e suburbano” (p. 573).
Il mito del progresso diventa ora mezzo di fusione tra le strategie legalistiche dei democratici, un approccio manageriale alla politica e un pensiero tecnocratico che insieme disegnavano un sistema intollerabile dal punto di vista del comune cittadino. Questo è il grande tema del declino dei ceti medi su cui Lasch insiste come uno dei fattori chiave nella spiegazione della deriva populista. Un declino già iniziato nel corso degli anni ottanta in USA ma destinato, come ben sappiamo, ad acuirsi e a diffondersi a mo’ di epidemia nel resto dell’Occidente. Dato che il confine tra classe media e classe operaia “si faceva sempre più incerto” (p. 556), diventava sempre più chiaro che le questioni sociali “fungevano da discriminante tra la destra e la sinistra”, mentre una stirpe di nuovi populisti cominciò a costruire una nuova coalizione politica attorno al risentimento della classe media” (p. 570). Tali condizioni riportarono in auge i temi sollevati dall’American Indipendent Party di G. Wallace, grazie anche a P. Weyrich, ideologo dell’allora nuova destra, che si batteva per un “conservatorismo fondato su base morale” ovvero “contro il laissez-faire, contro i cartelli del petrolio, dell’acciaio, delle assicurazioni e delle banche” che già dominavano la politica americana. In una sentenza dal sapore sorprendentemente oracolare, l’autore pare quasi riferirsi al nostro tempo. Riferendosi ai simboli della famiglia, della bandiera e del ritorno del sogno americano, Lasch pare quasi anticipare il motto trumpiano “make America great again”, sottolineando che i Repubblicani, “una volta affermato il loro diritto di richiamarsi alla tradizione populista”, sarebbero riusciti a vincere “un’elezione presidenziale dopo l’altra con monotona regolarità” (p. 574).
Il lungo excursus di C. Lasch sulla storia della cultura e della politica americana – dopo aver messo in discussione le ambivalenze di numerose scuole di pensiero nei confronti del mito del progresso (dai marxisti, alla nascente sociologia, a Freud ecc.) – giunge a una posizione altrettanto sfumata. Qualcuno l’ha definita “conservatorismo di sinistra”, oppure potremmo considerarla una sorta di neocomunitarismo senza razzismo. Ma così facendo egli ha anche fornito una base di legittimazione teoretica a ciò che nel mio pamphlet La mentalità neototalitaria ho definito come la “sindorme di Dogville”, ovvero l’emersione del lato oscuro del glocale che prepara la rivincita delle comunità terribili sulla scena della politica internazionale. Pare dunque che il lungo viaggio intellettuale dello studioso non abbia risolto la dicotomia tradizione vs progresso e come nel videoclip dei Talking Heads sopracitato, la comunità da cui si è partiti all’inizio del viaggio si ritrova alla fine ancora unita ma spaesata, senza punti di riferimento e ancora sperduta lungo la strada per il nessun-dove.