A vent'anni dalla sua morte / Le “lezioni americane” di Bruno Munari
Essendo uno degli atenei più importanti al mondo, l’Università di Harvard è stato uno dei crocevia privilegiati per intellettuali e artisti italiani in visita negli Stati Uniti. Particolare risonanza pubblica hanno avuto nel nostro paese le Charles Eliot Norton Lectures, un programma di Visiting Professorship istituito nel 1925 attraverso cui quale scrittori, artisti, intellettuali di fama mondiale vengono invitati a trascorrere un anno accademico nell’università del Massachusetts. Famose e celebrate saranno le Lezioni Americane che Italo Calvino avrebbe dovuto tenere a Harvard nell’autunno del 1985, ma mai portate a termine a causa della sua morte improvvisa avvenuta nell’estate dello stesso anno. Il libro pubblicato postumo diventerà una sorta di testamento letterario e critico che ha accompagnato l’esegesi calviniana nei decenni a venire. Quelle sei lezioni, quelle Six Memos for the Next Millenium nell’originale inglese, saranno poi ricordate da Umberto Eco nel 1992, quando sarà invitato a sua volta (secondo italiano dopo Calvino, e prima di Luciano Berio), a tenere un ciclo di lezioni che saranno raccolte nel libro Sei passeggiate nei boschi narrativi (1994).
Non molti ricordano però che qualche decennio prima, nel 1967, un altro artista italiano era approdato ad Harvard per tenere un corso presso il Carpenter Center for Visual Art: Bruno Munari. Kevin McManus ha pubblicato qualche anno fa un libro, Italiani a Harvard (FrancoAngeli, 2015), che racconta l’esperienza tutta italiana del Design Workshop della Graduate School of Design di Harvard, dove vennero chiamati alla direzione prima Costantino Nivola (1956-57, e 1970), e poi Mirko Basaldella (1957-69). In un dipartimento che contava tra le sue file alcuni dei più importanti progettisti, storici e teorici al mondo impegnati nel portare avanti gli ideali sviluppati in Germania dal Bauhaus, si diede vita a un’esperienza didattica destinata a lasciare un segno indelebile nell’arte e nella storia del design americano del secondo ‘900. E nessuno meglio di Munari nel contesto della cultura europea di quegli anni avrebbe potuto contribuire a quel progetto didattico di “learning by doing” che da sempre aveva caratterizzato il percorso artistico e professionale di Nivola e Basaldella. I resoconti delle sue lezioni, le sue impressioni bostoniane, e gli appunti visivi raccolti nel contesto di quel corso verranno poi pubblicati nel 1968 da Laterza con il titolo Design e comunicazione visiva (DCV), il libro più teoricamente informato e sistematico che Munari abbia mai scritto. Quell’invito era il giusto riconoscimento per un artista che aveva consolidato la propria fama soprattutto all’estero ma che veniva criticamente trascurato nel contesto italiano. Lo stesso Italo Calvino, pur avendo lavorato a fianco di Munari durante gli anni trascorsi a Einaudi, non ha mai considerato Munari come una significativa presenza nel panorama artistico italiano. Per Calvino Munari era semplicemente il “grafico” di Einaudi, avendo firmato insieme a Max Huber le copertine delle più celebri collane einaudiane del dopoguerra: dalla PBE al Nuovo Politecnico, dalla collana bianca di poesie alle Centopagine, diretta proprio da Calvino.
Più attento e generoso è stato invece il riconoscimento dato da Eco, che con Munari ha avuto una frequentazione più assidua, sia dal punto di vista professionale (Munari lavora anche per Bompiani) che intellettuale. Senza l’esperienza dell’Arte Programmata all’inizio degli anni ’60, Opera aperta sarebbe stato un libro diverso e avrebbe forse avuto un titolo differente. E sarà proprio Eco che nella sua “Bustina di Minerva” del 15 ottobre 1998, ricordando Munari dopo la sua scomparsa, avvicinerà l’artista milanese e il suo metodo proprio alle Lezioni americane di Calvino:
Lavorava sulla pagina come se accordasse un violino. … Quella matita si muoveva con una straordinaria leggerezza e rapidità, sembrava che tracciasse nel vuoto la danza delle api. E uso termini come “leggerezza” proprio pensando alla lezione americana di Calvino (chissà perché ho sempre visto Munari come un personaggio calviniano). Mi piace ricordarlo così, danzante e leggero perché lavorando accanto a lui ho capito molte cose sul ritmo, sul vuoto, su come si può “vedere” al millimetro, da un semplice schizzo, come sarà il lavoro finito – virtù rarissima.
Calvino aveva trovato soprattutto in Fausto Melotti, l’artista che avrebbe informato il principio di leggerezza e di trasparenza poi applicato alla scrittura delle sue “città invisibili”:
Le immagini più felici di città che vengono fuori sono rarefatte, filiformi, come se la nostra immaginazione ottimistica oggi non potesse essere che astratta […] C’è stato un momento in cui dopo aver conosciuto lo scultore Fausto Melotti, uno dei primi astrattisti italiani […] mi veniva da scrivere città sottili come le sue sculture: città sui trampoli, città ragnatela (Romanzi e racconti II, 1363).
Probabile in questa scoperta e discussione la mediazione di Paolo Fossati, einaudiano di lungo corso e autore di un libro su Melotti, Lo spazio inquieto, per cui Calvino scrive la prefazione. Per Einaudi, Fossati aveva curato anche uno dei libri più importanti di Munari, Codice ovvio, che però non intercetta l’attenzione o gli interessi calviniani, né al momento della pubblicazione, né più tardi. Marco Belpoliti nel suo L’occhio di Calvino ha individuato un residuo di ricordi melottiani in Lezioni americane, ponendo l’accento sulla comune tensione alla verticalità e alla leggerezza. In realtà, come ha suggerito Eco, Munari è un candidato molto più adatto a incarnare non solo la proverbiale leggerezza ma tutti i valori estetici e categoriali indicati da Calvino nelle sue Six Memos. Se c’è un artista del Novecento che ha informato la sua opera e il suo metodo secondo principi di leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, e coerenza, questo è Bruno Munari. In questo senso il decalogo (o esalogo) calviniano può servire come mappa per individuare alcuni fili conduttori o denominatori comuni del lavoro di Munari, non sempre semplice da sistematizzare, avendo operato in campi così diversi e con linguaggi estetici così vari: dal design industriale alla pittura, dai laboratori pedagogici alla grafica, dalla scrittura saggistica a quella creativa. Rileggendo Design e comunicazione visiva sembra che Calvino abbia semplicemente elaborato la desinenza letteraria di quelle “virtù” che Munari aveva già ampiamente discusso vent’anni prima.
Lightness/Leggerezza
Nell’introduzione al volume che abbiamo curato per Peter Lang, Bruno Munari: The Lightness of Art (2017), abbiamo spiegato come la leggerezza calviniana sia una chiave descrittiva che meglio di altre abbraccia in maniera compendiaria la molteplice varietà dell’opera di Munari. Una leggerezza che secondo Calvino non è superficialità o frivolezza, ma una leggerezza pensata, calibrata, inserita come un colpo d’ala nella struttura stessa dei suoi lavori. Una recente mostra a Palazzo Pretorio di Cittadella, curata da Guido Bartorelli, ha adottato una prospettiva simile scegliendo come titolo il binomio “Aria/Terra”, dove da una parte vi è la leggerezza fisica e mentale delle opere munariane, dall’altra la pratica concreta, l’arte come esperienza materiale, e come pedagogia del fare, che riporta l’esperienza estetica a un radicamento quasi antropologico. Molte delle opere esposte, e che corrispondono ormai a un repertorio classico di qualsiasi retrospettiva su Munari, rispondono in maniera esemplare a quella dimensione di “leggerezza” predicata da Calvino: Le Macchine inutili, i Filipesi, Concavo-convesso, la lampada Falkland, ma anche Flexi, le Sculture da viaggio, Abitacolo.
La dizione inglese della prima lezione, lightness, suggerisce un’ulteriore declinazione di questa particolare leggerezza adottata da Munari, ovvero quella che fa riferimento alla luminosità, alla luce (light). Se pensiamo alle Proiezioni dirette, i Polariscop, le Xerografie originali, i cortometraggi, Munari ha lavorato molto con la luce, materiale incorporeo per eccellenza.
La leggerezza di Munari va ovviamente interpretata anche nel senso dell’ironia, dello spirito irriverente, della mancanza di gravitas, che è un’altra costante delle opere e dello spirito di Munari. Ironia però anche come cosa seria, non tanto come posizione demistificante o scettica, ma come elemento metodologico. Da una parte l’ironia implica una distanza prospettica, osservativa, dall’altra viene definita come un “collaudo”. Il termine richiama la dizione di Marinetti che aveva rinominato le sue recensioni o le sue introduzioni come “collaudi”, prendendo a prestito un termine da manuale tecnico. Munari adotta la stessa terminologia, ma prendendola alla lettera:
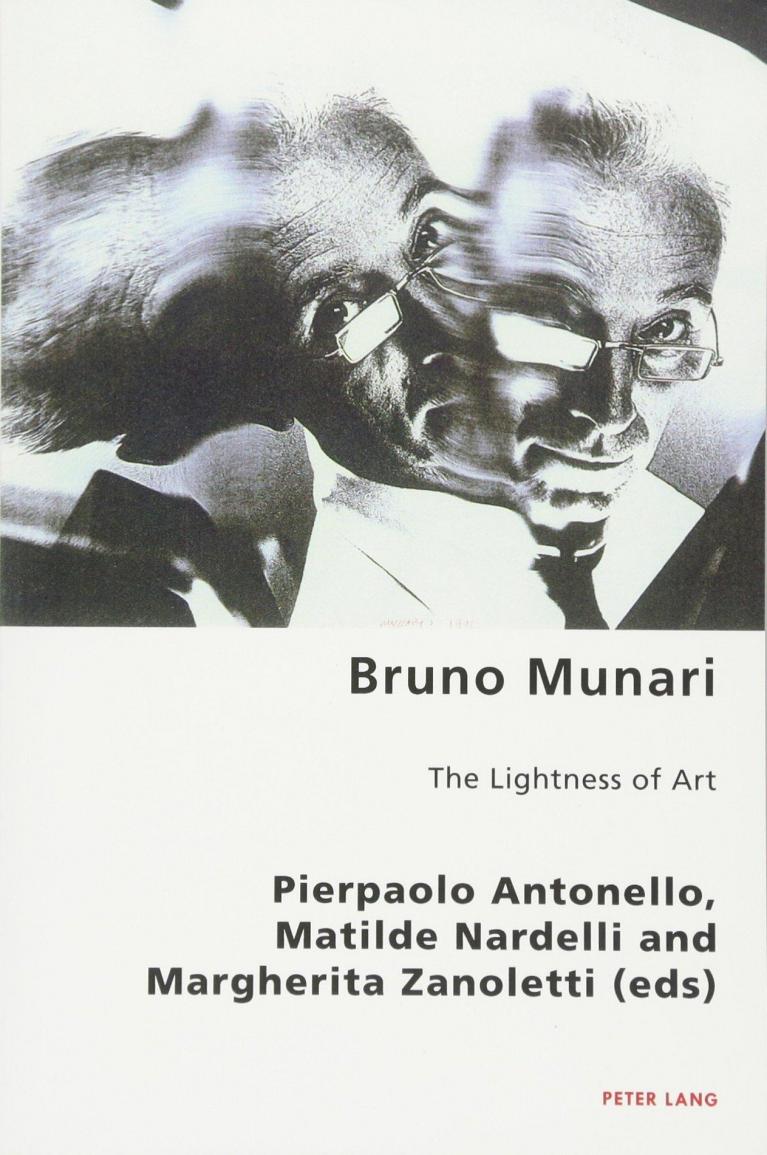
Si potrebbe dire che l’ironia è una specie di collaudo. Ci sono delle persone che producono degli oggetti nel campo dell’arte o in qualunque campo e si preoccupano di verificarli, per cui li mettono in giro e, magari, non funzionano. Invece, se noi pensiamo, per esempio, a quando un ingegnere costruisce un ponte sul quale deve passare un treno, lui lo carica con un peso equivalente a 10 treni; si potrebbe dire che fa dell’ironia, ma in realtà, su quel ponte siamo ben sicuri che passeranno i treni senza pericolo. Quindi, quello che io faccio, quando penso e progetto qualche cosa, è un’operazione di critica, di autocritica, per vedere se quello che io penso di fare resiste a qualunque obiezione. Se resiste, vuol dire che funziona (“Il caso e la creatività”, Domus, marzo 1985, 84-85).
Si tratta comunque non solo di cercare delle formule descrittive ad effetto, ma di capire più in profondità la matrice epistemica e metodica del suo operare, per potere dare un quadro di insieme o delle coordinate di comprensione del suo vagabondare tra modalità espressive così diverse. La leggerezza è infatti legata a un principio costruttivo fondamentale per Munari, che è la semplificazione; la riduzione alle componenti essenziali di un oggetto di design o di un’opera a funzione estetica: “complicare è facile, semplificare è difficile. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare”, ripete Munari in Codice ovvio.
Se nel campo del design questo principio ha ovvie determinazioni di carattere funzionale e di economia costruttiva, nel campo dell’arte fornisce spunti interessanti per capire l’epistemologia costruttivista di Munari. Si può fare un esempio prendendo come riferimento una delle sue opere più famose: le macchine inutili. Sono opere caratterizzate infatti da ironia (una macchina che non agisce secondo un principio produttivo o ripetitivo, ma aleatorio e di gratuità); essenzialità geometrica; riduzione estrema dei componenti pur mantenendo l’efficienza meccanica e cinetica, cioè pur rimanendo di fatto una macchina; meccanismo nudo che avvicina la macchina al giocattolo come macchina semplice. La macchina, la tecnica, se resa “inutile” diventa infatti uno strumento di gioco, ovvero un meccanismo di articolazione percettiva, sensoriale, e oggetto di interazione sia funzionale che estetica. È possibile intuire in questo modo le connessioni tra queste sue opere degli anni ’30 e i laboratori pedagogici sviluppati a partire dagli anni ’70. Con Munari l’homo faber incontra l’homo ludens.
Quickness/Rapidità
Eco ricordava come la matita di Munari si muovesse “con una straordinaria leggerezza e rapidità” dettata ovviamente da decenni di pratica e di ricerca sulle più svariate forme di comunicazione visuale. Analoga la memoria che ci ha lasciato Giulio Einaudi:
Lo ricordo in centinaia di riunioni. Lui arrivava e noi gli avevamo già preparato una pila di libri da copertinare: con un’inventiva fulminea riusciva a dare immediata rispondenza formale ai contenuti. Sceglieva i caratteri, i colori, le immagini. Aveva dei circuiti mentali rapidissimi che si coagulavano nelle mani. Le sue mani agivano, creavano come in un film accelerato; sembrava che pensasse con le mani e che il pensiero diventasse realizzazione in tempo reale.
Cesare Pavese aveva definito Calvino come lo “scoiattolo della penna”; Munari allo stesso modo potrebbe essere definito come uno scoiattolo dell’arte, per il suo muoversi agilmente e rapidamente sopra le pagine di un menabò ma anche fra i vari rami delle forme artistiche, frequentate con medesima abilità e efficacia produttiva, in maniera irrequieta, pronto a sperimentare quanto possibile, senza mai fermarsi sul già dato o fatto, ma spostando sempre oltre i limiti di quello che si può fare o dire nel campo della comunicazione visiva.
Munari non associa però la rapidità alla fretta (come per Guglielmo da Baskerville di Il nome della rosa di Eco che aveva paura della “fretta”): la fretta infatti ci impedisce di conoscere un problema con attenzione; è sinonimo di ignoranza, o è solo ansia appropriativa e competitiva: “la fretta di fare subito qualcosa che altri potrebbero fare a nostro danno” (DCV 54). Che è poi la stessa preoccupazione individuata da Primo Levi nella sua recensione a un libro di Lorenzo Tomatis che insegnava a lottare “contro la propria stanchezza, la propria fretta e la propria ambizione”.
“La rapidità, l’agilità del ragionare, l’economia degli argomenti, ma anche la fantasia degli esempi sono qualità del pensare bene”, dice Calvino, e non c’è prontuario più esemplare di questo appunto del volume Fantasia, dove l’agilità dell’immaginazione e l’articolazione delle risposte creative a questioni di carattere visivo e comunicativo vengono illustrate da Munari con esempi, semplici, diretti, di esperienza comune. Un libro che proprio per questo è diventato un prontuario di estetica usato dagli insegnanti di ogni scuola e grado.
Calvino parla inoltre di rapidità come “concisione”, massima concentrazione di pensiero e poesia in un testo che sia essenziale e diretto. Gli fa eco Munari quando afferma che “tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. […] La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte” (Verbale scritto).
“La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura”, scrive Calvino. “Pensare confonde le idee” ripeteva Munari, proprio perché l’esecuzione deve avere una precisa spontaneità, si potrebbe dire una “sprezzatura”, che non significa improvvisazione, ma un gesto che è stato allenato da anni di osservazioni e di esercizio pratico. A questo proposito Calvino mette in collegamento due figure mitiche, due archetipi: Mercurio, dio della rapidità e dello scambio, ma anche della sintonia e della partecipazione al mondo intorno a noi, e Vulcano, dio ctonio, chiuso nella sua fucina a battere incessantemente il ferro, e pertanto principio di focalità, ossia di “concentrazione costruttiva”. Rappresentano le due facce di una medesima disposizione all’efficacia e alla ricchezza produttiva: “La concentrazione e la craftmanschip di Vulcano sono le condizioni necessarie per scrivere le avventure e le metamorfosi di Mercurio”, scrive Calvino. E a mo’ di esempio cita la storia cinese di Chuang-Tzu, un pittore che chiese al re dieci anni di tempo e dodici servitori per poter disegnare un semplice granchio. Il re glieli accordò e allo scadere dei dieci anni Chuang-Tzu, “in un istante, con un solo gesto, disegnò […] il più perfetto granchio che si fosse mai visto”. Una storia che sembra riecheggiare con esattezza nelle parole di Munari nelle sue “lezioni americane”: anche nel campo artistico un prodotto fatto con rapidità conserva tutta la vita che era presente al momento concepitivo: le foglie di bambù di un dipinto cinese o giapponese sono fatte in un attimo, ma sono state osservate per lungo tempo. Osservare a lungo, capire profondamente, fare in un attimo (DCV 69).
Exactitude/Esattezza
Per Calvino il termine esattezza definisce soprattutto tre cose: “1. un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 2. l’evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili, in italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, ‘icastico’ […]; 3. un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione”.
Il fare dell’arte in Munari è informato da una prospettiva di carattere fortemente razionale, ispirata dai dettami dell’arte concreta, legata a una visione anti-impressionistica e geometrica dell’arte. Le sue opera sono attentamente progettate e informate da un rigore formale esatto. Munari non fa mai uso del termine avanguardia nei suoi scritti, se non per indicare una fase storica dell’arte del Novecento, né di sperimentazione artistica, ma descrive il suo lavoro estetico nei termini di “ricerca” usando un linguaggio tecnico-scientifico: “la ricerca parte da un fatto tecnico, parte dalle possibilità del mezzo per esplorare i valori di comunicazione visiva, indipendentemente dal contenuto della informazione, e senza tener conto di alcuna estetica passata e futura” (DCV 27). La necessità di precisione e esattezza lo porta anche ad avere una apertura epistemica e operativa nei confronti della tecnologia che permette di fare meglio e in meno tempo operazioni che una volta si facevano a mano “il principio è quello di arrivare allo scopo non solo senza fatica fisica ma con maggiore precisione”; “l’arte è un fatto mentale la cui realizzazione fisica può essere affidata a qualunque mezzo” (DCV 69-70). Sulla progettazione e sulla metodologia progettuale in campo di design industriale Munari scriverà poi un libro importante come Da cosa nasce cosa, dove scompone le varie fasi di un problema progettuale dando numerosi esempi di soluzioni progettuali, ragionate, definite e ben calcolate.
Per Munari è importante il valore oggettivo dell’opera d’arte, o di qualsiasi forma di comunicazione visiva, sia quella artistica in senso proprio, sia quella “applicata”, design grafico, editoriale o pubblicitario che sia: “Se l’immagine usata per un certo messaggio non è oggettiva, ha molte meno possibilità di comunicazione oggettiva: occorre che l’immagine sia leggibile a tutti e per tutti nello stesso modo altrimenti non c’è comunicazione visive: c’è confusione visiva” (DCV 13).
E a proposito, Calvino parla in Esattezza della peste del linguaggio che ha investito il mondo contemporaneo e che “si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche”; questa peste investe anche il mondo delle immagini, “immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato, come forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di significati possibili”.
Per Munari la chiarezza comunicativa, sia verbale che visiva, è una esigenza razionale, intellettuale, conoscitiva ma anche etica. Leggendo i libri di Munari risulta chiara la sua consapevolezza stilistica e di linguaggio. I libri di Munari sono scritti in un linguaggio piano, semplice, accessibile a tutti. Sono testi democratici e anch’essi “leggeri”. Esattamente come per le sue opere, la scrittura di Munari cerca sempre l’essenziale. È una lingua priva di tecnicismi, di formule critiche ricercate, non fa sfoggio di erudizione, ma è propedeutica a una comprensione dei problemi estetici che possano essere intesi da un pubblico generale e non solo dagli addetti ai lavori. Sono un esempio di uno stile che si oppone a quella che Calvino in un suo saggio avrebbe descritto come L’antilingua, – l’italiano di chi non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho effettuato”, dove la lingua viene uccisa, e la cui motivazione psicologica “è la mancanza di un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per sé stessi” (Una pietra sopra).
Proprio come Calvino anche Munari spende poi alcune pagine delle sue “lezioni americane” per parlare della confusione delle immagini simultanee e incoerenti che ormai ci investo nella nostra esperienza quotidiana, e chiede all’artista come al designer di provare a mettere ordine a questo caos. In questa direzione Munari sembra anticipare non solo le Six Memos di Calvino ma anche le famosissime righe finali di Le città invisibili (1971), sulla possibile salvezza dal caos infernale (“cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”) insistendo sulla necessità “di intervenire e collaborare per cercare di mettere un po’ d’ordine al caos”:
che cosa facevano gli artisti antichi quando progettavano le loro opere? Cercavano di rendere evidente un ordine (che si chiama estetica) nel caos della natura. Un ordine regolato da leggi di rapporti “armonici” fra la parte e il tutto. (DCV 53)
Munari per tanto si pone contro ogni forma di “disarmonia” artistica come resa mimetica (presuntivamente critica in quanto rivelatrice) del caos del mondo, ma predica una necessità di chiarezza e di comunicabilità come prerequisito per una politica effettiva delle immagini.
Visibility/Visibilità
Parlare di visibilità in riferimento a un artista e designer grafico è in qualche modo pleonastico, soprattutto per qualcuno che ha abbracciato i termini dell’arte concreta il cui scopo, come spiegava Max Bill, “è di rendere visibile idee astratte che esistevano solo in uno spazio mentale”.
Ma il concetto di visibilità espresso da Calvino ha delle sue caratteristiche precipue e che riguardano innanzitutto l’immaginazione e la fantasia, “un posto dove ci piove dentro” come scrive Calvino parafrasando Dante in Purgatorio 12. Potremmo dire che Munari a proposito abbia costruito un “pluviometro” scrivendo il suo libro più famoso Fantasia (1977).
Munari ha sempre pensato nei termini di una necessaria alfabetizzazione visuale, cercando di esercitare quel “pensare per immagini” che sta a cuore anche a Calvino. Importante per Munari è acquisire un linguaggio estetico e relazionale che consenta a tutti di leggere la coerenza formale di qualsiasi tipo di comunicazione visiva, e di mettere creativamente in relazione gli elementi della propria enciclopedia visiva, in modo da stimolare attivamente l’immaginazione: “L’immaginazione è il mezzo per visualizzare, per rendere visibile ciò che la fantasia, l’invenzione e la creatività pensano” (Fantasia 22). Da questo punto di vista Munari cerca di distinguere più precisamente i termini che Calvino usa in maniera meno controllata in Lezioni americane. Per Munari l’immaginazione interagisce costruttivamente con l’invenzione (che riguarda l’universo pratico e non si pone problemi di carattere estetico), e con la creatività che è un uso finalizzato della fantasia, che di per sé stessa rappresenta l’assoluta libertà di pensiero.
Calvino parlando di immaginazione si rifà a una ripartizione data da Jean Starobinski in L’impero dell’immaginario (1970), per il quale vi sono due correnti storiche che hanno pensato l’immaginazione o “come strumento di conoscenza o come identificazione con l’anima del mondo”, ovvero come capacità di “unificazione d’una logica spontanea delle immagini e di un disegno condotto secondo un’intenzione razionale” nel primo caso, e come “mezzo per raggiungere una conoscenza extraindividuale, extrasoggettiva” nel secondo. In Munari si può dire che agiscano entrambe le tensioni. La fantasia per Munari è essenzialmente una forma di conoscenza perché “nasce dalle relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce”. È anche la capacità di articolare dei nessi relazionali con i termini e le immagini che abbiamo acquisito nella nostra memoria, consentaneo con quanto Calvino scrive in Visibilità: alla base del lavoro creativo c’è la capacità di produrre “associazioni d’immagini. […] La fantasia è una specie di macchina elettronica che tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che corrispondono a un fine, o che semplicemente sono le più interessanti, piacevoli, divertenti”.
Per Munari la visibilità è legata anche a un principio democratico, alla necessità di usare le immagini per il loro valore oggettivo, per la loro capacità di essere efficacemente lette da tutti, o perché parte di un repertorio collettivo, depositato negli anni e nei secoli, o perché legate a leggi fisiche e a orizzonti naturali (da cui lo studio di forme antropologicamente essenziali come il quadrato, il cerchio e il triangolo). Come già detto riguardo a “esattezza”, lo spirito democratico di Munari si misura anche mediante la necessità etica e politica di una pedagogia del linguaggio e delle immagini, e pertanto contro quegli artisti che si sono “chiusi nelle loro torri d’avorio, nei loro linguaggi segreti e così oggi siamo nel bel mezzo della massima confusione dalla quale si può uscire solo ristabilendo delle nuove regole per la comunicazione visiva, regole elastiche e dinamiche […] che seguano il corso dei mezzi tecnici e scientifici usabili nelle comunicazioni visive, che siano soprattutto oggettive, cioè valide per tutti, e che diano una comunicazione visiva tale che non abbia più bisogno di interpreti per essere capita” (DCV 77).
Multiplicity/Molteplicità
A questo aspetto si può legare anche l’ultima delle lezioni lasciateci da Calvino che discute del “romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza, e soprattutto come connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo”. Traslando questa definizione all’ambito della creazione artistica e della comunicazione visiva, è chiaro come Munari sia sempre stato guidato da uno spirito enciclopedico, dalla necessità e dall’impulso inesausti di conoscere più cose possibili, di sperimentare quanti più stili, tecniche e generi possibili (come spiega in una intervista a Quintavalle). La molteplicità riguarda una necessaria apertura epistemica: “più aspetti conosciamo della stessa cosa, più la apprezziamo e meglio possiamo capirne la realtà che un tempo ci appariva solo sotto un unico aspetto” (DCV 78).
Sin dall’inizio della sua carriera artistica negli anni Venti, Munari si è messo in dialogo e ha preso a prestito e sviluppato elementi formali dal futurismo, dal surrealismo, dal dadaismo, dall’astrattismo, dal costruttivismo, dal Bauhaus, dal concretismo, dal razionalismo; ha sperimentato con l’arte cinetica, con l’arte programmata, con l’arte ambientale, con il cinema sperimentale, con la performance. Come altri protagonisti del modernismo internazionale Munari ha attraversato tutti i possibili generi e tecniche espressivi, nel campo della pittura, della scultura, della grafica, dell’illustrazione, del design industriale, della pubblicità, dell’architettura, del teatro, della scrittura creativa e saggistica.
Esattamente come il Perec o i sodali dell’Ou.li.po. citati da Calvino, Munari sviluppa un’idea generativa dell’arte, legata a dei vincoli programmatici che permettono all’opera di moltiplicare i propri aspetti in maniera potenzialmente infinita, come in un Aleph borgesiano. Un esempio erano già i mobiles degli anni Trenta e Quaranta, come le Macchine inutili o Concavo-convesso, che sono delle sculture che moltiplicano infinitamente la propria forma. All’inizio degli anni ’60 Munari sarà il promotore e il punto di riferimento principale di una serie di esperienze estetiche che saranno rubricate sotto il nome di “arte cinetica” (da cui lui si dissocerà), ma che riguardano essenzialmente un’idea di arte moltiplicata e programmata, generata da procedure e dispositivi che consentono di costruire “una successione di situazioni visuali diverse che si ordinano secondo uno svolgimento cronologico imprevedibile, sia pure con varianti in un ambito di situazioni che possono essere più o meno previste completamente dall’autore”.
Ispirato dal motto di Lao Tse: “Produzione senza appropriazione, azione senza imposizione di sé, sviluppo senza sopraffazione” (Da cosa nasce cosa), Munari programma la molteplicità dell’opera in vista della presenza attiva del fruitore che partecipa integralmente alla sua creazione. Questa potenzialità moltiplicativa è legata anche alla disponibilità tecnica data dalla contemporaneità, alle sue macchine, e alla possibilità di creare dei “multipli”, opere di design industriale a funzione estetica che come Flexi o le Strutture continue possono essere ricreate, manipolate, moltiplicate infinitamente, “per poter dare a tutti la possibilità di arricchire la propria cultura visiva, assorbendo per via diretta queste informazioni” (Codice ovvio). Da questo punto di vista la molteplicità di Munari fa della replicabilità dell’opera d’arte non tanto un problema di perdita di aura (Benjamin), ma lo strumento che può veicolare una migliore comprensione dell’arte e un più democratico accesso alle sue articolazioni percettive e formali.
Bruno Munari: The Lightness of Art, a cura di P. Antonello, M. Nardelli, M. Zanoletti, Oxford, Peter Lang, 2017.









