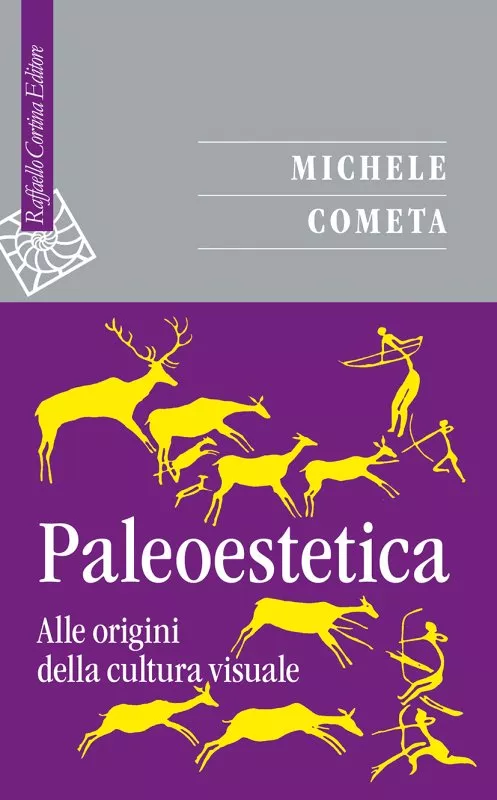Viaggio all’origine dell’immagine
Quando si vede per caso un arcobaleno credo che capiti a tutti di rimanere gioiosamente congelati, in una sorta di estasi contemplativa. Ci si sente bloccati davanti all’eleganza di quell’immagine, di quel segno perfetto e colorato nel cielo: il cuore sembra sobbalzare e verrebbe voglia di dire a tutti quelli che passano a testa bassa, magari assorti nelle loro preoccupazioni quotidiane, di alzare lo sguardo e godere anche loro, in silenzio, di quell’evento inatteso. Lo diceva anche Wordsworth in una poesia che è entrata a far parte del sapere comune: “My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky…”, “Il mio cuore sobbalza quando vedo un arcobaleno nel cielo / fu così quando cominciò la mia vita / è così ora che sono un uomo / sarà così quando diventerò vecchio / se no lasciatemi morire! / Il bambino è padre dell’uomo / e vorrei che i miei giorni / fossero legati uno all’altro da naturale devozione”. Sono versi che ci raccontano come quell’esperienza stupefacente e inattesa sia propria di ogni essere umano, indipendentemente dall’età e dalla condizione. È lo stupore che si prova davanti a qualcosa che non è a nostra disposizione, anzi, che più cerchiamo di raggiungere avvicinandoci, più si allontana, come diceva Edmund Burke. È qualcosa che non possiamo acquistare o possedere, ma che vediamo per caso, e davanti al quale non possiamo che restare stupiti. Ci tocca non solo la mente, ma anche il corpo: il cuore batte più forte e si sente uno strano trasporto verso una cosa che non pensiamo freddamente come fenomeno atmosferico, gocce d’acqua restate in sospensione e che filtrano i raggi del sole, ma che cogliamo immediatamente con meraviglia, come un evento magico che ci riguarda e al quale ci sentiamo in qualche modo legati per natura (“natural piety”).
È uno stato, per certi versi almeno, simile a quello che Michele Cometa descrive di aver provato da giovanissimo quando visitò per la prima volta i graffiti paleolitici nella grotta dell’Addaura in Sicilia e con il quale ci introduce al suo nuovo sollecitante, pirotecnico e come sempre documentatissimo libro, Paleoestetica (Cortina 2024). È lo stesso stupore estatico che provò Georges Bataille nell’ammirare le pitture rupestri paleolitiche nelle caverne di Lascaux, e con lui molti altri archeologi, storici dell’arte o semplici visitatori. È la stessa meraviglia provata da un regista dallo sguardo acutissimo come Werner Herzog, che nello splendido documentario Cave of Forgotten Dreams (del 2010 e disponibile su Rai Play) racconta la sua esperienza nella grotta Chauvet, dal nome dell’archeologo che la scoprì, per caso, nel 1994, nel sud della Francia, e che contiene circa 500 incredibili pitture rupestri risalenti a 32000 anni fa. Il documentario è ancor più prezioso dato che oggi la grotta non è visitabile per proteggere il delicatissimo clima interno, e può essere un utile prologo alla lettura del libro di Michele Cometa per chi non abbia avuto l’opportunità di entrare mai in una di queste magiche grotte paleolitiche.
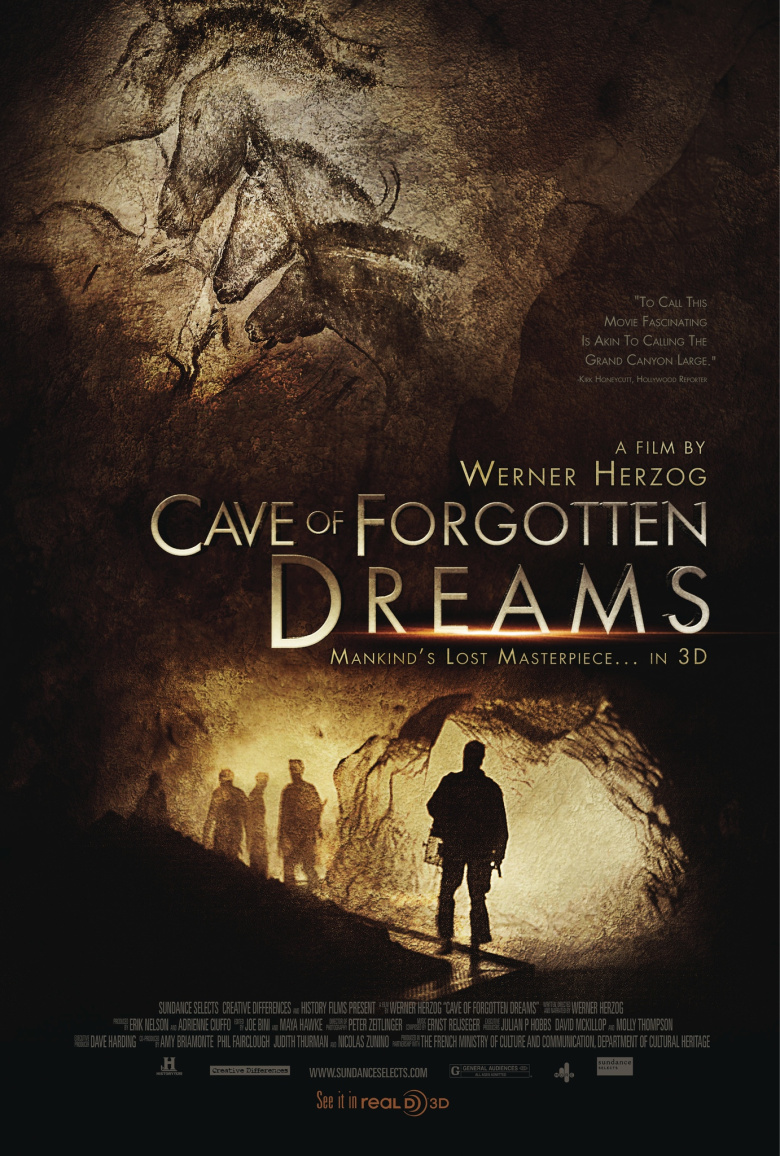
Fare esperienza diretta di quelle immagini così antiche, dentro una grotta particolare, con condizioni di luce particolari, in una condizione che oggi diremmo immersiva, per certi versi simile a quella che esperiamo quando siamo al cinema o a teatro, è un momento assolutamente soggettivo e irripetibile, indipendentemente dal fatto che conosciamo già quelle immagini per averle viste riprodotte nei libri di storia dell’arte, o per avere letto volumi e volumi di interpretazioni iconografiche. Scrive Cometa, “Quando scorgiamo per la prima volta una di queste immagini sentiamo che essa si rivolge a noi, come se fosse la prima volta e fosse la prima immagine che vediamo. Non è un caso appunto che si parli di ‘momenti di estasi’. Si tratta infatti di un’esperienza che ci trascina fuori da noi stessi, verso un passato immemoriale che però sappiamo essere il nostro passato. Riconosciamo quella singola immagine, vediamo che è un animale o un segno astratto, sappiamo che è qualcosa che appartiene al nostro patrimonio visuale. Non si tratta solo di un’emozione. In realtà (…) è un’esperienza insieme emotiva e cognitiva” (pp. 40-41).
Se per i romantici come Wordsworth, l’arcobaleno era una manifestazione dell’unità dell’io con la natura, e il poterlo vedere era un’esperienza emotiva e cognitiva fra io e mondo, qui Cometa mette in evidenza come quelle immagini così misteriose e enigmatiche, create decine di millenni fa, rimandino l’io, empaticamente, al suo inscindibile essere nella storia evolutiva della sua specie: “Nonostante ci sfugga il significato, nonostante non si sappia nemmeno collocarla cronologicamente, almeno in una cronologia che abbia senso per una singola vita umana, sappiamo che quell’immagine ci dice qualcosa, fa appello alle nostre capacità cognitive ed emozionali. Insomma comprendiamo immediatamente, anche se nulla sappiamo del Paleolitico, che quel segno sulla parete è prima di tutto un’immagine, qualcosa di così connaturato alla nostra evoluzione come specie che diamo per scontato, magari per un attimo, che quei lontani predecessori fossero come noi e che a noi si rivolgano” (p. 41).
Perché i nostri antenati abbiano inciso, dipinto e scolpito le figure di animali e di uomini nel fondo di caverne buie e difficilmente accessibili è stato oggetto di numerose indagini e di altrettante ipotesi, a volte non conciliabili tra loro, di studiosi della preistoria, archeologi, paleoetnologi, storici dell’arte ecc. Sono state pratiche da intendersi come propiziatorie per la caccia? Cerimonie religiose? Segni di riti animistici? Raffigurazioni mitiche? Narrazioni di eventi? Gwenn Rigal, in Il tempo sacro delle caverne (tr. it. di Svevo D’onofrio, Adelphi, 2022) offre una chiara e preziosa rassegna di numerose di queste teorie interpretative formulate da diversi studiosi che hanno tentato nell’ultimo secolo di dare un senso all’arte delle caverne.

Quello che cerca di fare Michele Cometa in Paleoestetica non è tanto offrire un quadro di queste diverse ipotesi, ma di sospendere il giudizio sull’artisticità di questi dipinti rupestri o sulla loro funzione, rituale o religiosa che sia stata, e di assumerli come una sorta di case study per un’indagine svolta nell’orizzonte della ricerca estetica intesa, secondo l’accezione di Alexander Gottlieb Baumgarten, il fondatore della moderna estetica, come scientia cognitions sensitivae, proficuamente applicabile anche al fare-immagini del paleolitico, sulla scorta dei metodi di ricerca dei moderni Visual Studies. L’estetica viene intesa qui come una scienza “umanistica”, interdisciplinare, forse indisciplinata, aperta e problematica, che non trascura di confrontarsi con “le scienze del bíos, con la tecnologia e con le scienze sociali”; una scienza che “affronta la questione della produzione estetica dal punto di vista delle facoltà cognitive”. Secondo Cometa “è proprio a Baumgarten che si può far risalire il filo rosso, spesso occultato dagli storicismi e spiritualismi che hanno costellato la storia dell’estetica moderna, che mette in relazione i manufatti tecnologici con le nostre capacità cognitive fondamentali” (p. 46).
In questo tentativo di ridefinizione dell’estetica, un ruolo fondamentale giocano gli studi sulle neuroscienze, sulla simulazione incarnata, sui neuroni specchio sui quali si sono concentrate le ricerche di Vittorio Gallese, con il quale Cometa ha collaborato in diversi recenti progetti di ricerca. Fra questi, quello culminato in un convegno tenutosi a Palermo nel 2018 e i cui atti sono ora disponibili nel volume Cultura visuale in Italia (Meltemi 2022) a cura dello stesso Cometa, di Roberta Coglitore e Valeria Cammarata, con un prezioso saggio introduttivo di W.J.T. Mitchell (Iconology 3.0), la cui opera è, per Cometa, riferimento imprescindibile degli studi sulla cultura visuale. Fra numerosi altri interessanti interventi si può leggere il saggio di Gallese (Il problema delle immagini. Una prospettiva a partire dal sistema cervello-corpo), prezioso per chi non ha avuto modo di entrare nel labirintico campo delle neuroscienze e per chi teme che questo approccio riduca l’esperienza estetica a una mera relazione meccanica e determinista. Scrive Gallese: “Le neuroscienze contemporanee ci dimostrano che ciò che vediamo non è semplicemente una registrazione visuale che avviene nel nostro cervello di ciò che si presenta davanti ai nostri occhi, ma il risultato di una costruzione complessa, il cui prodotto deriva dal contributo fondamentale del nostro corpo con le sue potenzialità motorie, dei nostri sensi e delle nostre emozioni, della nostra immaginazione, e dei nostri ricordi. (…) Con l’aiuto delle neuroscienze, possiamo testare la presunta universalità dell’espressione artistica umana e, soprattutto, mettere alla prova la sua apparente origine prettamente logocentrica. Le neuroscienze cognitive possono farci abbandonare la scelta forzata fra il relativismo totalizzante del costruttivismo sociale, che non lascia spazio alcuno al ruolo costitutivo del corpo nell’ambito della cognizione, e il determinismo scientifico di alcune parti della psicologia evoluzionista, il cui scopo è quello di spiegare l’arte esclusivamente in termini di adattamento e modularità” (p. 280).

Sulla scorta delle acquisizioni delle neuroscienze e degli studi di cultura visuale, Cometa si oppone all’idea, peraltro diffusa sia in ambito archeologico e storico artistico, sia in quello linguistico, di una “improvvisa esplosione cognitiva” che avrebbe consentito a un certo punto, quasi per miracolo, all’homo sapiens di fare-immagini. Questa abilità, che prende corpo nelle incisioni rupestri, nelle statuette, nelle miniature e negli ibridi, va considerata “come un prodotto dell’evoluzione tecnica degli ominidi su un arco di tempo di alcuni milioni di anni” (p. 114). Nel suo studio del fare-immagini del paleolitico, Cometa propone dunque “di abbandonare le consolidate e comode sicurezze della storia culturale (i ‘significati’ degli artefatti preistorici, la linearità dei processi storici) e persino le rassicuranti cronologie stabilite”, per affrontare piuttosto questo argomento “partendo dalla relativa stabilità delle attitudini e delle capacità cognitive sviluppate dall’Homo sapiens” (p. 115), e dalla ricognizione dell’esperienza concreta del fare-immagini come pratica capace di produrre oggetti, cose, strumenti, come estensione incarnata (embodied ed embedded) della mente umana. Il libro di Cometa, non da leggere svogliatamente né a cuor leggero sotto l’ombrellone, ci guida a interrogarci sulle immagini rupestri, sulle superfici e le pareti delle grotte che fanno da schermo per quelle incisioni e dipinti, sulle statuette paleolitiche, ma anche sulle nostre modalità di ricezione di quegli oggetti, mettendo in luce come l’esperienza estetica sia una esperienza relazionale e empatica.
Vagare nelle caverne di Lascaux, di Chauvet o dell’Addaura, ma anche restare, in assorta sospensione, davanti a un arcobaleno (la “willing suspension of disbelief” di Coleridge), è, come scriveva Ira Konigsberg, “in fin dei conti vagare dentro il Sé. Ciò che è particolarmente eccitante delle caverne è la sensazione che vagare dentro di esse sia vagare nella mente dei nostri antenati primitivi. È un viaggio indietro nell’origine, alla fonte del nostro essere, nell’infanzia della nostra infanzia” (in Cometa, p. 169). È un viaggio di empatico riconoscimento e immedesimazione.